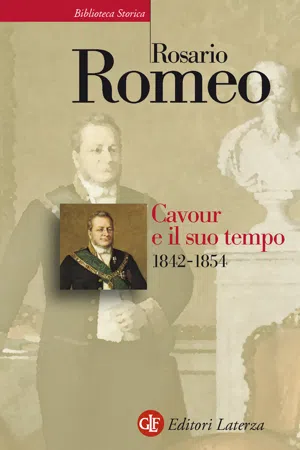VIII. Il «connubio» e la formazione del ministero Cavour
L’uomo al quale ormai si volgevano tante attese e tante speranze veniva acquistando un posto sempre più alto agli occhi degli osservatori piemontesi e non piemontesi. «Camille trône tous le jours plus haut – scriveva Roberto d’Azeglio al momento della nomina del conte a ministro delle finanze –. Il est certain qu’il se montre un homme supérieur... Il serait admiré n’importe où». «Cavour è riconosciuto indispensabile anche da’ suoi avversari ed invidi, che son molti a destra ed a sinistra – assicurava nello stesso tempo Luigi Carlo Farini –. Ma egli è tal uomo di cuore, di ingegno e di operosità, che Europa non credo abbia oggi il simile». Questo era il giudizio di un amico devoto: ma anche Massimo d’Azeglio, che pure si rendeva ormai conto di come fosse difficile collaborare con un simile personaggio, riconosceva che «Cavour è fatto apposta per menare affari e Parlamento». Gioberti, nel grande programma del Rinnovamento civile, tracciato dal suo esilio parigino al movimento nazionale italiano, segnalava le doti eccezionali del nuovo ministro, pure rimproverandogli di accentuare le tendenze aristocratiche e municipali del ministero Azeglio, e di negare in tal modo la base nazionale che sola poteva sostenere il suo gran disegno di riforma e di progresso. Nonostante tutto, aggiungeva, «quel brio, quel vigore, quell’attività mi rapiscono; e ammiro lo stesso errore magnanimo di trattare una provincia come fosse la nazione»; senza escludere e anzi augurando che il conte intendesse la sua vera missione nazionale e italiana: perché, «quando egli sia impegnato alla causa patria... chi vorrà dubitare della sua perseveranza?»; e chi meglio adatto a farsi «iniziatore del Rinnovamento»?. Economisti illustri come Adolphe Blanqui aspiravano a fare la sua conoscenza per esprimergli la propria ammirazione «pour votre caractère et pour l’élévation de vos principes économiques». «Les germes féconds que vous avez semés en Piémont ne tarderont pas à porter leurs fruits... – gli scriveva l’economista nizzardo al momento della sua uscita dal ministero – Vous avez laissé les États Sardes aggrandis de toute l’étendue des débouchés que vous leurs avez ouverts et réparé à vous seul, je l’espère, la plupart des malheurs de la dernière guerre... Votre oeuvre n’est pas fini». Lo stesso Cobden si diceva convinto che «there is no man in Europe who can deal with financial and economical question more ably than your Finance Minister: and I hope he will find sufficient intelligence and morality in the country to support him in the contest which he will have to wage with interested parties in his enlightened advocacy of commercial freedom». Da parte sua Cavour non si stancava di sottolineare il legame tra la battaglia ch’egli conduceva per «faire triompher dans le parlement les doctrines du libre échange» e la causa generale del liberalismo e liberismo in tutto il continente. In tal modo egli entrava a far parte di quella élite nella quale il liberalismo europeo riconosceva la sua guida intellettuale e politica: una sorta di internazionale, senza istituzioni bensì e senza statuti, com’era nella natura del movimento, ma non perciò meno solida ed efficace delle strutture internazionali che più tardi si daranno movimenti come quello socialista. Ed era un’internazionale di cui si sentivano parte non solo politici e uomini di cultura ma anche uomini pratici e di affari, i quali parimenti, scriveva Hambro a Cavour, si sentivano legati «de coeur, d’âme et de... fortune» alle sorti del Piemonte liberale, «parce que je crois ce pays destiné à former le levier pour ce progrès régulier de l’humanité, que ni les despotes ni les anarchistes ne peuvent arrêter». Per alcuni decenni, sino alla fine del secolo, questa élite fornirà l’intelaiatura di una classe dirigente europea, di importanza non minore di quella internazionale aristocratica della diplomazia alla quale restava affidata la guida della politica estera nel continente.
Anche nelle sezioni più conservatrici e più ostili di quegli ambienti, del resto, la personalità del conte veniva imponendosi: «son activité... son savoir-faire, le succès de ses dernières opérations financières..., le système commercial qu’il a inauguré» erano da tutti riconosciuti. Specialmente a partire dalla ripresa della sessione parlamentare, nell’autunno 1851, egli appariva ormai, ad amici e nemici, il vero capo del gabinetto: grazie al suo «caractère ambitieux, despote et dominant...» – riferiva l’inviato austriaco – e anche, «il faut le dire», a «ses talens et son activité... il en devint peu-à-peu l’âme et la pensée dirigeante, en prenant de l’influence sur ses collègues, en s’emparant de l’initiative dans toutes les questions, en faisant subir au Parlement l’ascendent de sa parole facile et féconde, en éblouissant le public par son infatigable activité et la hardiesse de ses conceptions commerciales et financières». Il che non significa che le antipatie personali di cui il conte era così largamente circondato nell’ambiente torinese fossero adesso minori che in passato. Se l’opinione pubblica liberale guardava a lui con crescente fiducia e simpatia, nei ristretti circoli aristocratici della capitale e nel mondo politico all’unanime riconoscimento delle sue capacità si univa una diffidenza e spesso un’ostilità che non accennavano a scemare: «il a une manière d’être qui dégoûte tout le monde d’avoir des rapports avec lui», commentava con acredine Costanza d’Azeglio, in un momento peraltro in cui i rapporti tra l’ambiente azegliano e il conte erano vicini alla rottura. Di quel modo di essere Massimo d’Azeglio cercava di delineare i tratti principali, quando ormai il periodo della collaborazione era giunto al termine: in Cavour – scriveva – «il difetto principale sta nell’amore della tirannia, che per i liberali da cento mila franchi d’entrata è come pe’ preti l’obbligo dell’uffizio. E a quarant’anni, quando s’è stati enfant gâté fino allora, la conversione è difficile, tanto più coll’aggiunta d’una vanità che non appartiene al partito moderato, e colla controforza d’un’ambizione che fra le passioni umane ci vede chiaro all’incirca come l’amore, l’ira e la gelosia». Era un ritratto non propriamente falso ma certo incompleto. Vi mancava infatti, ed era una lacuna decisiva, la virtù che «quel brio, quel vigore, quell’attività» di cui diceva Gioberti possedevano di suscitare simpatie e stimolare energie in cerchie che andavano ben oltre le ristrette élites torinesi. Ed era questo, per il conte, un elemento importante di forza politica, assai più grande, a conti fatti, dell’ostacolo che certo costituivano le persistenti antipatie di cui era circondato, non senza riflessi anche negli ambienti della diplomazia e all’estero.
Non sarebbe giusto, del resto, limitare alle sole iniziative cavouriane l’opera del gabinetto Azeglio, anche dopo che il conte era entrato a farne parte. Al nome di Giuseppe Siccardi è infatti legata, accanto all’abolizione del foro ecclesiastico, anche quella delle ultime vestigia del regime feudale in Piemonte. A lui si dovette la soppressione dei fedecommessi, primogeniture e maggioraschi, con la quale si portava a compimento un’opera che, a giudizio dello stesso Siccardi, si poteva già dire «condotta presso al suo termine per beneficio in parte delle passate legislazioni ed in parte del tempo»; e per sua iniziativa vennero anche abolite, con indennizzo, le bannalità coattive. Ancora ad una proposta del Siccardi si dovette la legge sulla inamovibilità della magistratura, che dava attuazione a una delle garanzie statutarie più importanti, nonostante qualche ingerenza che l’esecutivo conservava nel pubblico ministero e nella determinazione degli organici del personale giudiziario. Sotto il suo successore, Giovanni De Foresta, si sottoposero i funzionari incaricati della polizia giudiziaria alla direzione e dipendenza dall’avvocato fiscale generale e dall’avvocato fiscale presso il tribunale di prima cognizione, vennero determinate le attribuzioni degli avvocati fiscali e dei giudici d’istruzione, ed emanate nuove norme sugli arresti e i procedimenti penali: provvedendosi in tal modo a una migliore tutela della libertà individuale, nonostante che l’opposizione lamentasse i residui interventi del pubblico ministero nei primi atti dell’istruzione, e nonostante il rifiuto delle proposte avanzate dal Brofferio per la libertà provvisoria su cauzione e per la soppressione del carcere preventivo in materia correzionale. Qualche mese dopo venne anche approvata una nuova legge sull’ordinamento e sul personale della...