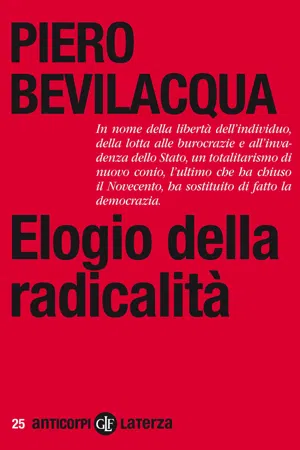capitolo nono
Rovesciare il mondo capovolto
Alla fine del percorso analitico di questo Elogio appare inevitabile presentarsi, e per giunta drammaticamen-te sguarniti, di fronte alla Grande Sfinge: l’egemonia del capitale. Ma tutto ciò che è stato fin qui raccontato mi spinge a fare i conti con l’ardua questione. Il tema che ha aleggiato in tutte le pagine di questo saggio e che attende ora, inevitabilmente, una riflessione d’insieme. So bene quanto sia azzardato, in tempi così calamitosi, mentre la classe operaia e i ceti popolari sono sotto assedio nei vari angoli del mondo, nel momento in cui perfino gli Stati nazionali vedono gravemente menomata la loro stessa sovranità, tentare di sotterrare dagli strati profondi dell’oblio la grande parola: egemonia. E sia pure nella programmata limitatezza di una breve nota. Egemonia rimanda a tempi lunghi, mentre tutto, l’intera scena pubblica, oggi appare dominata dalle urgenze indifferibili, da tempi brevi e brevissimi, da stati di necessità imposti da invisibili potenze esterne – i mercati – al cui volere divino pare non si possa sfuggire. Eppure, storicamente, all’egemonia e comunque alle grandi prospettive di un assetto più avanzato delle società umane si è pensato nei momenti bui, quando l’orizzonte dell’avvenire appariva gravemente precluso. Si parva licet componere magnis, ricordo che proprio Antonio Gramsci, il teorico di tale concetto, lo elaborò nel fondo di una cella, detenuto nelle carceri fasciste, meditando sulla sconfitta e sulla tragedia del proletariato italiano. E se vogliamo volgerci ad altro ambito di pensiero e di condizione personale, è forse il caso di rammentare che John Maynard Keynes scrisse le sue pagine più cariche di speranza e di prospettive utopiche nel 1930, dopo il crollo di Wall Street, quando l’ombra della Grande Depressione era calata sull’Occidente. In quell’anno, nel saggio Economic Possibilities for our Grandchildren, egli prevedeva, da lì a un secolo, come risolti i problemi economici dell’umanità e realizzata la prospettiva di un orario di lavoro ridotto a turni di tre ore al giorno e venti ore alla settimana. Un nuovo assetto di civiltà grazie alla ricchezza e alla produttività industriale garantite dallo sviluppo tecnologico.
Forse opera in noi un qualche meccanismo segreto. Mentre il presente ci assedia con i suoi problemi che appaiono irrisolvibili, è probabilmente un bisogno di salute mentale, di ossigeno richiesto dal cervello, che spinge il pensiero a immaginare le prospettive avvenire, visibili solo negli strati profondi del corso storico, sempre all’opera malgrado l’apparente immobilità della superficie. La “vecchia talpa”, è noto, non finisce mai di scavare. E, d’altra parte, questo scarto della mente si genera esattamente allorché la normalità è sospesa. È quando crollano solidi edifici di senso comune, certezze, abitudini, insomma la stoffa inerziale del solito andare avanti, che si è portati ad alzare gli occhi oltre il basso orizzonte quotidiano. Si intravedono nuove terre solo quando interi continenti di certezze sono sprofondati. Allora incalzano le grandi domande. E una domanda grande è: che cosa è accaduto al capitalismo? Che cosa nasconde la grande bufera economico-finanziaria in cui siamo immersi da oltre quattro anni? Abbiamo a che fare con una crisi ciclica del capitalismo più lunga del solito o siamo alla fine non tanto della sua capacità di dominio, della sua capacità di durare, ma della sua egemonia?
La domanda si pone certo immediatamente a causa della presente crisi economica, che è solo in parte l’esito di una strategia trentennale del capitalismo internazionale, ispirata dalle ideologie neoliberistiche, sbaragliate sul campo e senza gloria dalla durezza della realtà, dalla prova della storia. Neppure a causa dell’evidente ed esplosiva contraddizione che si è venuta a creare, come notato da alcuni economisti, tra mercati globali, Stati nazionali e democrazia: contraddizione generatrice di problemi inediti per le classi dirigenti di buona parte del mondo. La crisi è un grande segnale d’altro, come ho cercato di mostrare in miei precedenti lavori. E non ha un valore politico da poco se persino un uomo come Jean-Claude Trichet, l’ex presidente della Bce, così restio a prendere lezioni dalla realtà, ha dovuto pubblicamente far ricorso – certo, nel suo specifico linguaggio –, per descrivere il presente disordine mondiale, all’espressione fatale: «crisi sistemica».
La domanda si pone, innanzi tutto, per una ragione storica, che ci aiuta a comprendere le novità profonde della situazione presente. Il capitalismo è stato il primo modo di produzione che abbia dato vita a una formazione sociale e a una architettura del potere fondata sull’egemonia. Vale a dire, per riprendere l’essenziale del concetto di Gramsci, una forma di organizzazione del potere radicata nel consenso, nell’accettazione da parte dei cittadini, oltre che nel dominio fondato e reso possibile dal potere economico. È una presa d’atto di carattere storico essenziale per comprendere la chiusura degli orizzonti che si para oggi di fronte ai ceti dominanti. Per afferrare lo stadio cui è giunto questo modo di produzione secolare.
A voler essere meno essenziali, e dunque meno assertivi, dovremmo certo ricordare che il capitalismo è avanzato e continua tuttora a farlo, in misura ridotta, su un doppio registro di potere. In fabbrica, dove si genera il plusvalore che alimenta la riproduzione del capitale, il dominio sulla forza lavoro ha incarnato, nei tre secoli della sua storia, il controllo più totalitario e costante sulla persona che sia mai apparso nelle società umane. Qui domina ancora, nella sua forma più pura, il comando. Al tempo stesso, però, fuori dalla fabbrica, esso è riuscito a coinvolgere nell’accettazione del proprio modo di produrre ricchezza, e nel proprio dominio, altri settori economici, segmenti diversi del potere borghese, le classi medie, gli intellettuali. Per brevità argomentativa e senza voler essere provocatorio, rammento che i più autorevoli testimoni di questa capacità egemonica che il capitale mostrava già nella prima metà dell’Ottocento sono Marx ed Engels nel Manifesto. Le pagine iniziali dedicate al carattere rivoluzionario della classe borghese grondano tutto il fascino che essi subivano osservando il sommovimento in corso sotto i loro occhi. E le gigantesche fondamenta su cui il capitale veniva allora erigendo un potere egemonico, inesistenti in tutti i precedenti modi di produzione, erano essenzialmente due, già ben evidenti nell’analisi dei fondatori del comunismo: l’incommensurabile capacità di produrre ricchezza, la sua continua e insonne forza generatrice di beni, e la liberazione degli uomini dalle antiche superstizioni, ma anche dalle dipendenze personali che avevano dominato nell’antico regime. Prosperità e libertà, libertà formale – se non per tutti almeno per una crescente massa di cittadini – come orizzonte di una nuova storia. Non ci si riflette mai abbastanza, ma pur nella sua evidente iniquità sociale il capitalismo, che riempiva di operai sporchi e laceri tante città inglesi nel XIX secolo, era portatore di una narrazione teleologica, capace di egemonia su vasti strati della società del tempo. L’ideologia del progresso che percorre tutto l’Ottocento poggia su questa gigantesca promessa di prosperità che viene dalla produzione di merci, dal volume crescente del commercio internazionale, dalla inedita mobilità di uomini e beni, dalle scoperte scientifiche e dal dominio tecnologico sempre più dispiegato sulla natura, dallo sviluppo culturale e artistico che esplode in quel secolo e agita l’intera Europa. Potremmo dire che il racconto del socialismo, la prospettiva di una prosperità sociale fondata sull’eguaglianza, sulla fine dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, si sviluppa a ridosso della teleologia capitalistica, ne costituisce lo specchio contrapposto. Ma rimarrà profondamente legata ad essa. Lo è ancora oggi, e tale dimenticato legame costituisce la barriera rocciosa che ha impedito e impedisce ancora alle forze più ampie della sinistra di aprirsi al nuovo universalismo della critica ecologica al capitale.
Com’è noto, l’intero XX secolo vede le classi dirigenti delle società capitalistiche impegnate in uno sforzo di governo egemonico della società ancora più ampio e più consapevole. La nascita, nel 1917 in Russia, di uno Stato socialista veniva a incarnare per la prima volta nella storia la forma reale dell’alternativa egalitaria al capitale, del governo in mano al popolo. Quello Stato, che le potenze di allora non riuscirono a soffocare sul nascere, costituiva dunque una sfida e una minaccia, una possibile via di liberazione per altri popoli della terra, e creava un gigantesco e inedito terreno di competizione fra due sistemi, destinato a percorrere gran parte del Novecento. Sappiamo bene oggi che la sfida più progressista, articolata e alla fine vittoriosa contro il progetto di società comunista incarnato dall’Urss l’ha ideata e promossa l’America. Sfida le cui potenzialità Gramsci aveva precocemente intravisto in Americanismo e fordismo, un progetto di società fondato prevalentemente sull’immensa capacità produttiva del capitalismo tecnologicamente avanzato di quel paese, sulla sua capacità di coinvolgere strati estesi di classe operaia in un avanzamento di reddito e di condizioni di vita.
Di recente, una storica americana che porta un cognome italiano, Victoria De Grazia, nel suo L’impero irresistibile, ha messo in evidenza come la promozione della società dei consumi, fondata su una gigantesca macchina produttiva, ha costituito l’asse centrale di un progetto egemonico imperiale con cui gli Stati Uniti si sono affermati, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, sul resto del mondo. Naturalmente un impero come quello americano, pur fondato su basi egemomiche, si è sviluppato anche su basi tecnologiche, militari e finanziarie che non bisogna dimenticare, come ha sottolineato di recente Alex Callinicos, docente al King’s College di Londra, nel suo Imperialism and Global Political Economy.
Negli ultimi trent’anni noi abbiamo assistito a una continuazione di quel grande disegno. Ma esso è apparso sempre più privo di slancio, di reali energie propulsive. Benché il fenomeno sia stato, per così dire, oscurato dal sempre più evidente imballo degli Stati autoritari dell’Est europeo, che ha offerto non poche ragioni alla retorica neoliberista. I discorsi antisocialisti di Margaret Thatcher, tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, ne costituiscono un esempio significativo. Ma il progetto capitalistico oggi si mostra come un edificio pieno di crepe, soggetto a crolli in più parti. La crisi attuale ci spinge, se vogliamo afferrare il grado di egemonia di cui continua a godere il modello “americano”, a porci la domanda fondamentale: i due pilastri storici del consenso capitalista su gran parte della società sono ancora in piedi? La liberazione dell’individuo e la prospettiva di un incremento illimitato e crescente della prosperità sono sempre gli elementi chiave di una narrazione capace ancora di persuadere e sedurre, di creare consenso e stabilità? Ha scritto di recente Franco Cassano: «Ogni egemonia è sempre fragile ed esposta al rischio di una crisi, che potrebbe annunziare l’inizio del suo declino, il momento in cui il consenso intorno a un paradigma inizia a sgretolarsi. Tale crisi inizia a manifestarsi quando la massa degli eventi che esso non ha previsto o non riesce a spiegare supera la soglia di guardia, quando le anomalie si accumulano e acquistano evidenza. È allora che inizia ad ampliarsi lo spazio per l’egemonia di paradigmi concorrenti o addirittura per l’emergere di nuovi». È una riflessione che è anche un piano di lavoro storico e teorico a cui le note che seguono vogliono dare un contributo di avvio.
Ebbene, io credo che il grande racconto si sia spezzato. La trama non regge più e il lieto fine previsto si è dissolto nella nebbia di un bosco più intricato e selvaggio di quello delle antiche favole. Il cosiddetto “sogno americano”, il nucleo retorico e paradigmatico di quella grande narrazione, è da tempo uno slogan usurato. E non è una considerazione che nasce dallo spettacolo dei grandi problemi sociali che la crisi squaderna davanti a noi. Questi sono solo una parte del quadro, talora solo l’evidenziatore che rende più visibili i tracolli sistemici sotterranei. Io credo che la liberazione dell’individuo nei paesi dell’Occidente, la sua corsa solitaria verso la libertà, sia finita. La libertà individuale, scaduta ormai e degenerata in individualismo, divenuta anarchica dissoluzione dei legami sociali, trasformatasi in nevrosi e infelicità esistenziale, si è rovesciata nel suo contrario. La sua attuale condizione è ormai analizzata e raccontata da una vasta schiera di sociologi, filosofi, psicologi, persino economisti. Una delle grandi conquiste della modernità è finita nel cul-de-sac di una patologia esistenziale. Su tale aspetto non occorre insistere più di tanto se non per ricordare che tale degenerazione storica non nasce solo – come tende a suggerire, sia pur splendidamente, l’ultimo Zygmunt Bauman – dal dilagare della società dei consumi. Essa è figlia anche della sfera della produzione, del diretto rapporto capitalistico. Perché è ancora al cuore profondo di questo modo di produzione che occorre guardare per cogliere sul nascere i fenomen...