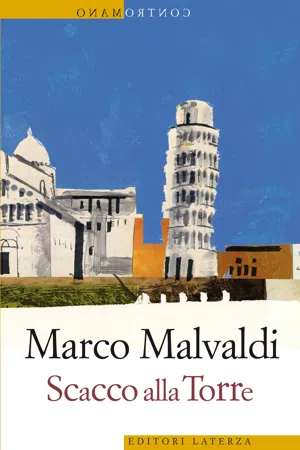
- 112 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Scacco alla Torre
Informazioni su questo libro
A Pisa, si tende a pensare, c'è solo la Torre che pende. Innanzitutto, ad essere precisi, le torri che pendono sono tre: e quella famosa, oltretutto, è quella meno inclinata.
Mi è venuto in mente che sarebbe stato bellino scrivere un libriccino su tutto quello che c'è, di significativo e di godibile, a Pisa. Non, intendiamoci, una vera e propria guida turistica. Piuttosto, un pot-pourri di aneddoti, descrizioni, impressioni. Qualcosa che possa colpire tutti, pisani e forestieri, esperti e novellini, gente colta e livornesi. Qualcosa che non spieghi, ma piuttosto incuriosisca. «Ti garberebbe?» gli ho chiesto io (che, d'altronde, sono pisano). «Dio Bono!» mi ha risposto lui. Ed eccoci qua.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Scacco alla Torre di Marco Malvaldi in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Editore
Editori LaterzaAnno
2015eBook ISBN
9788858122037La piazza, di giorno
Siete arrivati in piazza dei Miracoli?
Bene. Adesso, tutto quello che vi ci vuole è una guida abile e competente; qualcuno che, in questo posto, ci abbia lavorato. Qualcuno come me. Io, infatti, ho lavorato (o, in alcuni casi, sono stato remunerato: la parola lavoro sarebbe veramente troppo grossa) in quasi tutti gli edifici che compongono il meraviglioso complesso che avete intorno a voi.
Se vogliamo cominciare bene, io vi consiglierei di fare prima di tutto un bel giro intorno ai monumenti, gustandovi il contrasto tra il verde del pratino tenuto a regola d’arte e il loro splendore.
Certo, dovrete fare degli sforzi immani per tentare di escludere dalla vostra vista le terrificanti bancarelle addossate sul lato sud della piazza, che oltre ad escludere dalla vista lo spedale di papa Alessandro offendono il visitatore esponendo paccottiglia di ogni genere inviso al buon gusto. Dopodiché, si può incominciare.
Partiamo dalla Cattedrale: cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, secondo alcuni sulle rovine di una chiesa più antica, pare dedicata a Santa Reparata. La cattedrale, concepita dal geniale architetto Buscheto e più tardi completata (e ampliata) dall’allievo Rainaldo, è pregevole sia dentro che fuori: ma, poiché questa è una guida personale e non ha nessuna pretesa di essere completa, io se fossi in voi sceglierei di passare un po’ di tempo al suo interno, piuttosto che guardarla da fuori. Anche perché, all’esterno, della cattedrale originaria si sono perse parecchie cose. Un po’ per l’incendio che in pieno Rinascimento, nel 1595, devastò la cattedrale, bruciandone il soffitto e i portali bronzei; un po’ per il modo scellerato in cui la cattedrale stessa venne restaurata nella prima metà dell’Ottocento, laddove in molti casi la parola restauro fu interpretata come “frego il capitello originale e ne metto una copia fatta alla meglio, tanto lassù in alto chi vuoi che lo veda”. Se proprio volete passare un po’ di tempo al di fuori, vi consiglio il portale bronzeo di Bonanno Pisano, l’unico scampato all’incendio, e che si trova sul retro della chiesa, sul braccio del transetto di fronte al campanile (cioè, per amor di chiarezza, alla Torre).
All’interno, invece, la cattedrale è ampia, magnificente, piena di cose belle da guardare e soprattutto fresca; se credete che questa osservazione sia inopportuna e che io sia un essere prosaico senza nessuna inclinazione al Bello, provate a visitare la piazza tra giugno e luglio e poi me lo ridite.
Quando prestavo servizio come cantore presso la Cappella Musicale dell’Opera del Duomo (servizio interrotto nel 2005, a causa di una piccola e oserei dire freudiana dimenticanza di mia moglie, che prenotò le vacanze a metà agosto dimenticandosi che io a Ferragosto per contratto avrei dovuto stare in chiesa a cantare, invece che a crogiolarmi al sole) passavo dei minuti interminabili a guardare, dal mio scranno, i vari particolari incredibili dell’interno della chiesa. Quello che mi colpiva di più era ed è il meraviglioso pulpito trecentesco che si trova a metà della chiesa. Il pulpito, opera di Giovanni Pisano, è una vasca ottagonale sorretta da statue e da colonne, a loro volta sorrette da leoni, e racconta lungo il proprio perimetro degli episodi della vita di Cristo e della Vergine, oltre ad alcuni aspetti del giudizio universale. Allo stesso modo, da un punto di vista estetico ho rimirato e analizzato spesso l’altare e l’ambone della chiesa, opera dello scultore contemporaneo Giuliano Vangi, chiedendomi come fosse possibile che la stessa persona in grado di scolpire un altare così bello – etereo e insieme solenne, con figure di angeli che tengono sollevato il sacro piano – fosse stata in grado di pensare e, una volta finito, di tollerare che il Vangelo venisse sorretto da un ambone così brutto, in cui troneggia un Cristo più simile a un missile che a un Messia.
Da un punto di vista ingegneristico, invece, ho passato più di un momento a chiedermi come fosse stato possibile, nei tempi antichi, trasportare i monoliti di granito che costituiscono le colonne della navata centrale; ho da poco scoperto che queste furono sollevate grazie al genio dello stesso architetto Buscheto, tramite un meccanismo di sua invenzione che viene celebrato con un’epigrafe sulla facciata della chiesa stessa. Cercatela, sull’arcata cieca della prima facciata: è una scritta in latino, che dice:
Quod vix mille boum possent iuga iuncta movere
et quod vix potuit per mare ferre ratis
Busketi nisu quod erat mirabile visu
dena puellarum turba levabat onus.
Siccome siamo in mezzo a un latino medievale, per orientarci è conveniente cercare l’oggetto della frase, ovvero onus: cioè, quel peso che la forza di mille buoi muoveva a stento e che a fatica poteva venir portato per mare, grazie all’intuizione di Buscheto – oh, mirabile a vedersi – se dobbiamo credere all’iscrizione, venne sollevato da un gruppo di dieci fanciulle. Ad avvalorare questa possibilità, e questo uso simpaticamente allegorico di un gruppo di una decina di pulzelle per sollevare un oggetto cilindrico al cielo, c’è un’altra testimonianza: può essere, infatti, che questo Buscheto sia lo stesso Buzeta che, secondo un’epigrafe dello stesso periodo, avrebbe innalzato l’obelisco Vaticano in quella che era la sua posizione originale, e cioè sulla spina del Circo di Nerone, a Roma. L’epigrafe, infatti, sostiene che tale obelisco venne innalzato grazie al genio di Buzeta e alle mani di quindici ragazze. L’impresa, se veritiera, sarebbe notevole, anche perché stiamo parlando dell’unico obelisco di Roma che non è mai caduto, e che è restato sempre ritto, anche se non è chiaro per merito di chi.
Avanzo dei dubbi sulla possibilità che davvero dieci pulzelle abbiano potuto sollevare l’immane blocco, non solo perché sono un bastian contrario, ma anche perché non sarebbe la prima volta che i singoli arredi della chiesa vengono fatti oggetto di leggenda. E qui, per capirmi, vi invito a guardare in alto, a metà circa della navata centrale.
Il pesante lampadario in bronzo che vedete ondeggiare di fronte ai vostri occhi, opera di Vincenzio di Domenico Possenti, secondo la leggenda avrebbe suggerito a Galileo Galilei, fisico insigne e fedele piuttosto distratto, la legge dell’isocronia delle piccole oscillazioni di un pendolo. Secondo la leggenda, infatti, il buon Galileo, rompendosi le scatole a messa, aveva incominciato a osservare le oscillazioni del lampadario e a cronometrarle tramite il battito del polso, osservando così che indipendentemente dall’ampiezza le volute descritte dal pendolo avevano sempre la stessa durata. Storia mirabile, e plausibile, perché a volte non c’è niente come la noia per permettere al nostro cervello di vagare indisturbato finché, inaspettatamente, non gli capita di convergere su di un’idea geniale. È storia, purtroppo, assolutamente falsa: perché la legge dell’isocronia del pendolo venne scoperta e pubblicata da Galileo nel 1583, mentre la detta lampada venne installata nel 1588...
Se proprio voleste vedere la lampada originale, dovreste andare qui vicino, presso la cappella Aulla, che si trova nel Camposanto Monumentale. Però, se entrate dentro il Camposanto e provate a dare un’occhiata ai muri, ho il sospetto che la povera lampada di Galileo probabilmente passerà in secondo piano.
Se vi guardate intorno, il Camposanto Monumentale (i pisani doc lo chiamano Camposanto Vecchio) è quel rassicurante ed equilibrato susseguirsi di archi ciechi che chiudono la piazza sul lato nord. Per entrarvi avete a disposizione due porte, una delle quali sormontata da una ridicola edicola neogotica, rappresentante una Madonna con bambino e quattro loschi figuri in piedi, che per gli amanti della simmetria è un vero e proprio calcio in uno stinco. Ma, una volta dentro, vi aspetta una sorpresa.
Un po’ per l’interno, un cortile erboso racchiuso da una teoria di finestroni gotici inscritti in archi romani a tutto sesto, ma, soprattutto, per gli affreschi. Quelli che ancora rimangono. Nel 1944, infatti, quando ancora non esistevano le bombe intelligenti e non si bombardava per liberare le popolazioni dai tiranni, ma semplicemente per radere al suolo le infrastrutture, una stupidissima bomba americana centrò in pieno il camposanto, e la copertura dell’edificio, tutta in piombo, fuse colando sugli affreschi sottostanti, che già sopportavano da decenni l’esposizione all’aria salmastra e ai ceri condominiali dei devoti più esibizionisti.
Solo pochi di questi capolavori sono ancora visibili; gli altri, ricoverati in un capannone in via Pietrasantina, vengono restaurati da decenni da una paziente équipe di restauratori, chimici e storici dell’arte, di cui per un anno ha fatto parte pure il sottoscritto. Ma quei pochi che restano, credetemi, sono una cosa che toglie il fiato. Per chi ama l’arte medievale anche il solo Trionfo della Morte, opera (probabilmente) di Buonamico Buffalmacco, a mio modesto parere vale il viaggio per la città.
Dall’altra parte, di fronte alla Cattedrale, sorge il Battistero, dedicato con grosso sforzo di fantasia a San Giovanni Battista (con questo, non crediatevi che a Pisa non siamo in grado di stupirvi con le dediche: nel posto dove vivo, a Nodica, la chiesa è intitolata a San Giuda).
Le particolarità di questo battistero sono molteplici, ma si possono ridurre tutte sotto un’unica parola. Tale parola è, in italiano, eterogeneo, mentre in pisano lo stesso concetto si esprimerebbe col termine lasciato a mezzo. Già da fuori è possibile vedere che la cupola è bicolore, e ricorda vagamente un gelato da due gusti: tegoli rossi verso il tramonto, lastre di piombo verso est, a perenne testimonianza di come la mancanza di fondi destinati alle opere pubbliche sia un problema millenario per il nostro paese.
Anche all’interno, nell’architettura, si può notare una certa discontinuità, data dal fatto che il progetto originario di Diotisalvi era di stile moresco, e quindi aveva previsto in origine una cupola tronco-conica. Spirato il Diotisalvi, il Battistero venne riportato in Europa da Nicola e Giovanni Pisano, che sfruttarono le tecniche costruttive del gotico per ricoprire la cupola a forma di fez con un bel cupolone emisferico, tanto che la sommità originale oggi si può vedere (appunto) solo dall’interno. All’interno, però, la cosa che vale veramente la pena guardare è il meraviglioso pulpito di Nicola Pisano, che con il suo rigore classico interpretato da Nicola con nuovo impeto anticipa il Rinascimento di più di un secolo.
Ma queste cose, diciamoci la verità, le potete leggere su di una qualsiasi guida turistica, e sono a mio parere ben poca cosa rispetto alla caratteristica veramente impressionante del Battistero; una cosa che si può apprezzare solo dall’interno, e che non si può nemmeno immaginare anche dopo aver letto una ventina di guide turistiche. La cosa veramente spettacolare di questo edificio, infatti, è l’acustica.
Se vi trovate nel Battistero con una visita guidata, o contemporaneamente ad una di queste, quasi sicuramente la guida chiederà ad uno degli addetti di emettere due suoni l’uno dopo l’altro (t...
Indice dei contenuti
- Una breve spiegazione
- Lungarni
- Road map
- Curiosità toponomastiche
- La piazza, di giorno
- Finalmente soli
- In supremae dignitatis
- Un crocevia della scienza
- Un popolo di scrittori
- Verso il vasto pelago
- Metter su peso, perdere peso
- Un uomo solo al comando
- Ringraziamenti bibliografici