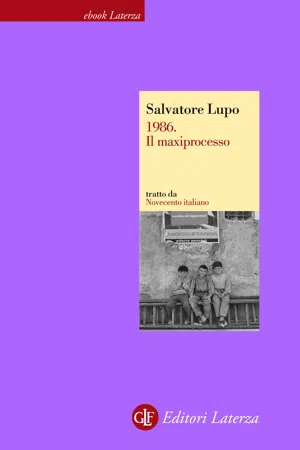1986. Il maxiprocesso
di Salvatore Lupo
1. Il maxiprocesso si svolse a Palermo tra il febbraio del 1986 e il dicembre del 1987: con 400 mafiosi portati in giudizio dei 700 che erano stati incriminati in sede istruttoria, 114 dei quali, lo dico subito, vennero assolti, ivi compreso l’antico capomafia Luciano Leggio detto Liggio – a dimostrazione del fatto che processo vero fu e non mera rappresentazione, come da parte di alcuni si voleva o si temeva.
La Palermo di quel periodo è una città messa sotto stato d’assedio, tranquillizzata rispetto agli anni precedenti quando – come tra poco meglio diremo – era stata insanguinata dall’offensiva mafiosa: mutamento indotto forse dallo spiegamento delle forze dello Stato, o soltanto dall’attesa degli eventi, dall’incertezza di chi si interrogava sui risultati che avrebbe sortito quell’evento così innovativo.
La novità consisteva nel fatto che una così grande quantità di individui fosse accusata di una gran quantità di delitti perpetrati sotto l’egida dell’associazione o società segreta detta mafia o Cosa nostra. Il primo termine era quello antico, in uso sin dal periodo post-unitario. Il secondo, introdotto negli Stati Uniti a partire dal 1963 da un gangster di origine italiana risoltosi a collaborare con le autorità, Joe Valachi, mai usato in precedenza in Sicilia, venne portato ora sulla ribalta dal supertestimone dell’accusa al maxiprocesso, Tommaso Buscetta.
Si trattava di un antico nome iniziatico? Derivava l’espressione da un più recente effetto di rimbalzo, dal riuso nel sottomondo mafioso di uno dei materiali rinvenibili sul terreno del dibattito pubblico? Difficile dirlo. Più importante è chiarire la scelta interpretativa che stava dietro l’enfasi su quel nome posta dallo stesso Buscetta e dai magistrati inquirenti, da Giuseppe Falcone, da Paolo Borsellino e da tutti gli altri. Sotto processo non era un contesto socio-antropologico difficilmente definibile e delimitabile, non un codice culturale tradizionalista, non un comportamento vagamente antisociale, ma appunto un soggetto collettivo da indicarsi con un nome preciso, con il suo nome.
Dal punto di vista formale, la legge che chiamiamo Rognoni-La Torre, entrata appena un paio di anni prima nell’ordinamento italiano, sanciva che un tal genere di associazione esisteva, che era giuridicamente definibile, che farne parte rappresentava un reato. Dal punto di vista sostanziale, le indagini e le confessioni provenienti da ‘pentiti’, come Buscetta o Salvatore Contorno, stabilirono che i reati addebitati ai singoli mafiosi non potevano essere spiegati se non partendo dal sistema delle relazioni vigente al suo interno, dalle alleanze e dai conflitti che al suo interno si sviluppavano. Condotti per mano soprattutto da Buscetta, gli inquirenti presero atto che in quella società segreta si entrava con un rito tenebroso e un tenebroso giuramento, ovvero attraverso un passaggio formale; ‘appartenenza’ poi confermata nel tempo grazie a un meandro di codici, regole, linguaggi iniziatici. Per questa via, come accade ai militanti di un partito politico, i mafiosi acquisivano una forte coscienza di sé, ivi comprendendo una qualche idea della loro storia o per meglio dire una mitologia. Pensavano di far parte di uno Stato, idea che dobbiamo tener presente, sia pure nella piena consapevolezza del suo carattere approssimativo o meglio ideologico.
Se la mafia-Cosa nostra si presentava come uno pseudo-Stato, la Commissione o Cupola che la dirigeva voleva esserne lo pseudo-governo. Caso vuole che nello stesso anno 1986 si celebrasse a New York il processo contro la Commissione di Cosa nostra americana. Ovviamente non si trattava di un caso. Si trattava degli effetti di una stagione di riarmo investigativo che investì i mafiosi contemporaneamente su entrambi i versanti dell’oceano, impedendo loro di riproporre l’antico gioco: fare dell’America una sicura retrovia quando si trovavano sotto pressione in Italia, e viceversa.
Abbiamo già richiamato il cosiddetto pentitismo. Il termine è ovviamente ambiguo, il suo uso non può che essere convenzionale. Esso non allude tanto a una sfera etico-religiosa, quanto alla vicenda politica e ideale italiana ancora in corso della crisi interna delle organizzazioni armate o terroristiche di estrema sinistra che avevano insanguinato l’Italia, alle disillusioni di chi aveva militato in esse, alla decisione di tanti di farla finita collaborando con le autorità.
Buscetta aprì la sua confessione con un’autodefinizione – non sono un traditore, non sono uno spione, non sono un pentito. In apparenza dunque si tirava fuori dallo schema, eppure nel suo discorso possiamo individuare cruciali punti di contatto (insieme a innumerevoli differenze) con le motivazioni dei brigatisti e degli altri ‘politici’ risoltisi ad abbandonare la loro parte. Come molti di costoro, egli rivendicò per se stesso una continuità, una coerenza ideologica. Per gli aspetti fondamentali, per i valori di fondo non lui, ma i suoi avversari – disse – avevano tradito. Proprio perché coerente sino in fondo, egli era stato forzato a collaborare con l’autorità, di fronte a una mafia attuale ormai degenerata rispetto a quella dei suoi tempi e dei tempi antichi.
Veramente, Buscetta non corrispondeva in nulla all’immagine del mafioso tradizionale. Era un contrabbandiere che da più di vent’anni aveva il suo luogo di residenza nelle due Americhe e nel narcotraffico il suo principale campo di attività. Sapeva però, come tanti suoi pari, che da più di un secolo l’unico mafioso accettabile e accettato era quello amante della tradizione, dell’ordine e della gerarchia. Con quella faccia egli scelse di presentarsi all’autorità e all’opinione pubblica.
I molti avversari e detrattori suoi e dei magistrati con cui collaborò negarono allora, in linea particolare, che si fosse pentito; e, in linea generale, che un mafioso potesse mai pentirsi. Non erano convinti che l’organizzazione mafiosa in quanto tale esistesse, né del collegamento – che abbiamo detto implicito nel concetto di pentitismo – tra la cultura della mafia e l’ideologia di un movimento politico eversivo. Io convengo che Buscetta non si pentì, nel senso che continuò a esprimersi con il frasario e i codici comunicativi mafiosi, il che non vuol dire che il suo contributo non sia stato su moltissime questioni veritiero, fondamentale per svelare il volto del nemico.
L’immagine che il pentito volle dare di se stesso fu ben accetta agli inquirenti:
Egli, mafioso di vecchio stampo, si era reso conto che i principi ispiratori di Cosa Nostra erano stati ormai irrimediabilmente travolti dalla bieca ferocia dei suoi nemici, che avevano trasformato l’organizzazione in un’associazione criminale della peggiore specie, in cui egli non si riconosceva più. Non aveva, pertanto, più senso prestare ossequio alle regole di un’organizzazione in cui non credeva, non aveva più senso tenere fede alla legge dell’omertà, egli doveva operare per la distruzione della ‘nuova mafia’, doveva vendicarsi dei tanti lutti subiti, ma la soverchiante superiorità dei suoi nemici non gli lasciava molte speranze, non gli restava altra via che rivolgersi alla Giustizia dello Stato, per consumare la sua vendetta e per salvare la sua vita1.
Il brano, almeno nella sua prima parte, appare troppo indulgente verso l’autointerpretazione del supertestimone. Falcone si rendeva però conto molto bene (e una volta lo disse anche esplicitamente) che il tradizionalismo era per i mafiosi il corrispondente dell’ideologia rivoluzionaria per i brigatisti: uno strumento per mantenere coeso il gruppo. Gli inquirenti dovevano prenderlo sul serio se volevano stabilire un rapporto con mafiosi risoltisi alla collaborazione, ma pur sempre bisognosi di sentirsi e di essere considerati uomini d’onore. Solo stabilendo un rapporto di mutua considerazione i primi potevano sperare che i secondi indicassero la strada che portava nel profondo dei misteri della segreta società.
Seguirono così un percorso inverso a quello sino ad allora più consueto. In genere chi dall’esterno si accosta alla macchina ideologica mafiosa finisce col convincersi che dietro o al di sotto di essa non c’è alcuna segreta società; ritenendo al contrario di trovarsi davanti a un sistema di regole informali, riferibile a una cultura, a un comportamento diffuso in tutta la società siciliana, a codici antropologici antichi propri di un popolo isolano e isolato, tradizionale e tradizionalista.
All’origine di questa linea interpretativa possiamo collocare alcune piccole pagine scritte dall’etnologo e medico positivista palermitano Giuseppe Pitré alla fine degli anni Ottanta del XIX secolo. Col termine ‘mafia’ non deve indicarsi, spiega Pitré, una società segreta dotata «di regolamenti e statuti», come vorrebbero pubblici funzionari, giornalisti e pubblicisti d’occasione, bensì una qualità riguardante le profondità dell’anima siciliana, le sue rozzezze e le sue sottigliezze. In passato, spiega Pitré, esso era adoperato in ambienti popolari come sinonimo di bellezza, di eccellenza; analogamente, d’altronde, all’altro termine-chiave del lessico mafioso, ‘omertà’, che deriverebbe dalla radice ‘uomo’. È vero, ammette il nostro etnologo, che i Siciliani tendono alla violenza, è vero che si fanno giustizia da sé senza rispondere alla giustizia dello Stato, ma lo fanno perché c’è in loro un senso sia pure esagerato dell’onore, ovvero della dignità virile2. Sono dunque uomini in senso profondo, un senso un po’ barbarico, certo, agli occhi dell’incivilito XIX secolo, ma sicuramente positivo; perché nella cultura ottocentesca – e spesso anche in quella novecentesca – ‘femminile’ sta per negativo e ‘maschile’ sta per positivo.
Ci troviamo q...