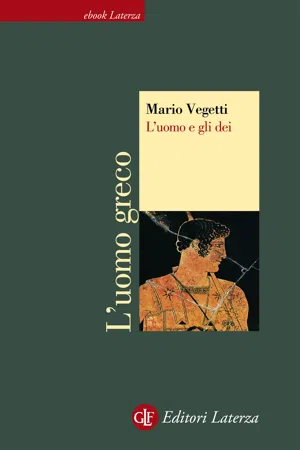L’uomo e gli dei
Racconta Aristotele che il vecchio sapiente Eraclito, «rivolgendosi a quegli ospiti che desideravano rendergli visita, ma che, una volta entrati, ristavano vedendo che si scaldava presso la stufa di cucina, li invitò a entrare senza esitare: ‘anche qui, disse, vi sono dei’» (De partibus animalium, 1, 5).
L’aneddoto aristotelico è per varie ragioni significativo e utile a comprendere l’atteggiamento religioso dell’uomo greco. Esso illumina, in primo luogo, il carattere diffuso dell’esperienza del «sacro», la sua prossimità ai tempi e ai luoghi della vita quotidiana. Il focolare domestico, attorno al quale la famiglia si riunisce per cucinare e consumare i pasti, è per esempio consacrato a una divinità, Estia, che protegge la prosperità e la continuità della vita familiare; ogni nuovo nato viene portato in giro attorno al focolare, per sancirne anche religiosamente l’immissione nello spazio domestico.
Nel motto di Eraclito, questa diffusione del sacro si prolunga in un rapporto di familiarità con gli dei che caratterizza largamente l’esperienza religiosa greca: la divinità non è lontana e inaccessibile, la sua frequentazione caratterizza, si può dire, ogni momento significativo dell’esistenza privata e sociale; accade così sovente di incontrarla, nelle sue immagini, nelle pratiche cultuali che le sono dedicate, nel raccontare familiare e pubblico in cui si disegnano le trame fitte di una simbolizzazione significativa dell’esistenza, che la domanda sul perché i Greci credessero ai loro dei appare mal posta. Ci si dovrebbe piuttosto chiedere come sarebbe stato possibile che essi non credessero agli dei, visto che questo avrebbe implicato la negazione di una larga parte dell’esperienza quotidiana di vita.
Al senso di diffusione del sacro e di familiarità con gli dei si aggiunge, nel contesto aristotelico dell’aneddoto, un terzo carattere, che riguarda specificamente l’atteggiamento intellettuale dei filosofi verso la sfera del divino. Esso viene sempre più identificato come il principio e la garanzia di ordine, di regolarità, di senso del mondo naturale (Aristotele cita infatti il motto di Eraclito per legittimare lo studio teorico della natura vivente, un ambito certo meno nobile di quello dei cieli e degli astri, più vicino alla divinità, ma pur sempre governato da leggi di ordine e di valore, dunque anch’esso «pieno di dei»). Questo atteggiamento filosofico non contrasta, almeno nel senso di fondo, con i caratteri dell’esperienza religiosa comune, ma certo li prolunga in una nuova concezione che trasforma la prossimità e la familiarità del divino nella sua immanenza all’ordine del mondo.
Di tutti questi caratteri dell’esperienza religiosa greca si dirà analiticamente più avanti. Per comprenderne tuttavia l’aspetto fondamentale e apparentemente contraddittorio, quello cioè di essere un’esperienza diffusa e onnipervasiva dell’esistenza, ma al tempo stesso per così dire «leggera», non opprimente psicologicamente e socialmente, occorrerà in primo luogo procedere a qualche delimitazione in negativo. Occorrerà insomma chiarire quel che la religione greca non è stata.
Una religione senza dogmi e senza chiesa
In primo luogo, essa non si fonda su alcuna rivelazione «positiva» direttamente concessa dalla divinità agli uomini; non ha dunque alcun profeta fondatore, a differenza delle grandi religioni monoteistiche del Mediterraneo, e non possiede alcun libro sacro che enunci le verità rivelate e costituisca il principio di un sistema teologico. L’assenza del Libro comporta la parallela assenza di un gruppo di suoi interpreti specializzati; non c’è mai stata in Grecia una casta sacerdotale permanente e professionale (l’accesso alle funzioni sacerdotali essendo in linea di principio aperto a ogni cittadino, e di norma in via transitoria), e tanto meno una chiesa unificata, intesa come apparato gerarchico e separato, legittimato a interpretare le verità religiose e ad amministrare le pratiche del culto. Né ci sono mai stati dogmi di fede la cui osservanza andasse imposta e sorvegliata, e la cui trasgressione desse luogo alle figure dell’eresia e dell’empietà.
Questo sistema di assenze si prolunga in un silenzio particolare ma assai significativo. Nell’insieme delle credenze e dei racconti intorno alla divinità, non hanno alcun ruolo centrale – e di fatto non esistono, se non in correnti marginali e settarie, come vedremo – quelli relativi alla creazione del mondo e degli uomini; nell’esperienza comune c’è dunque sempre stata, nel mondo, una convivenza tra la schiatta degli dei e quella degli uomini. Non c’è parimenti (con le stesse eccezioni già accennate) alcuna idea di un «peccato originale» da cui gli uomini debbano in qualche modo venir purificati e salvati: a meno che si macchi di una colpa e di una contaminazione specifica, l’uomo greco è normalmente «puro», e come tale può liberamente accedere alle funzioni sacre. Altrettanto marginale è, almeno al livello della religione pubblica, la questione della sopravvivenza dell’anima e della sua salvezza oltreterrena, anche se essa tenderà a emergere, come pure si vedrà, nell’ambito dei culti misterici e iniziatici.
Questo insieme di considerazioni negative fa sì che sia difficile parlare positivamente di una «religione» greca, almeno nel senso in cui il termine viene usato nell’ambito delle tradizioni monoteistiche. Manca persino in greco una parola il cui campo semantico equivalga propriamente al termine «religione». Quella che più le si avvicina, eusèbeia, viene definita dal sacerdote Eutifrone, il protagonista dell’omonimo dialogo platonico, come «la cura (therapeia) che gli uomini hanno degli dei» (Platone, Eutifrone, 12e). Questa religiosità consiste dunque nella puntuale osservanza dei riti cultuali in cui si esprime il rispetto degli uomini verso la divinità, in cui le si rendono i dovuti segni di ossequio e deferenza, consistenti in primo luogo nelle offerte sacrificali e votive. Un valore parallelamente debole ha l’equivalente greco del termine «fede». Nella lingua comune, l’espressione «credere agli dei» (nomizein tous theoùs) non significa tanto (come accadrà nel posteriore e maturo linguaggio filosofico) una convinzione razionale relativa alla loro esistenza, quanto «rispettare», onorare nelle pratiche di culto la divinità: nomizein equivarrà dunque in sostanza a therapeuein, dedicare alla divinità le opportune cure rituali.
Il nucleo del rapporto fra uomini e divinità, della «religione» e della «fede» dei Greci appare dunque consistere nell’osservanza dei culti e dei riti prescritti dalla tradizione. Questo non deve tuttavia far pensare a una ritualizzazione ossessiva e pervasiva dell’esistenza. Il sarcastico ritratto della superstizione (deisidaimonia) che il filosofo Teofrasto traccia nei suoi Caratteri (16) alla fine del IV secolo a.C., è probabilmente ispirato a un atteggiamento diffuso: il superstizioso è colui che vive nell’afflizione di un perpetuo timore verso la potenza divina e dedica ridicolmente gran parte della sua esistenza allo sforzo di ingraziarsela attraverso i riti, al tentativo maniacale di evitare l’empietà e di purificarsi da ogni possibile colpa. Ma si tratta, appunto, di un «carattere» da commedia: la satira teofrastea non lascia alcun dubbio sul fatto che l’ossessione ritualistica non fosse né diffusa né apprezzata nel contesto della religiosità greca. Questo non significa naturalmente che non esistesse un profondo e radicato timore della divinità e della sua capacità di punire le colpe degli uomini colpendoli nell’arco della loro esistenza e anche nella loro discendenza. Questo timore è ben attestato in tutta l’esperienza culturale greca del V secolo, e ancora in quello successivo Epicuro, un filosofo all’incirca contemporaneo di Teofrasto, pensava che uno dei compiti fondamentali della filosofia, se si voleva restituire serenità alla vita degli uomini, dovesse consistere appunto nel liberarli da questa paura della punizione divina.
L’insieme di questi atteggiamenti, nella sua complessità, può ben essere rappresentato da un ingenuo aneddoto narrato dallo storico Erodoto, che scrive nel V secolo ma si riferisce alla vicenda del tiranno ateniese Pisistrato (metà del VI secolo). Erodoto racconta di uno stratagemma di Pisistrato per riconquistare il perduto potere in Atene: travestita una ragazza nella foggia e nell’armatura della dea Atena, egli la inviò su un carro verso l’acropoli, facendola precedere da araldi che intim...