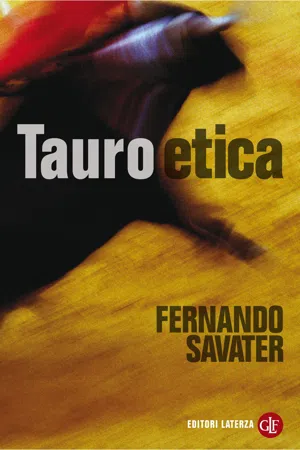1. Prologo
Nella Storia si parla troppo poco degli animali
Elias Canetti
La provincia dell’uomo
La ragione principale per la quale vengono pubblicate queste pagine (e per la quale, in gran parte, sono state scritte) è il dibattito avviato dal Parlamento della Catalogna a seguito di un’iniziativa cittadina che chiede l’abolizione delle corride di tori nella regione autonoma.
Non è azzardato supporre che, se la proposta diventerà legge, seguiranno iniziative simili in altre regioni, anche se con minori probabilità di successo (in Catalogna abolire la corrida è una scelta politicamente vantaggiosa, in quasi tutto il resto della Spagna no). In ogni caso, la vecchia polemica relativa alla corrida, ai suoi presunti valori simbolici e artistici o alla sua altrettanto presunta brutalità antimoderna è tornata prepotentemente d’attualità. E oggi, a differenza di altre epoche, il dibattito si svolge in un contesto generalizzato di sensibilità ecologica pro-animalista che ha trasformato in opinione diffusa ciò che un tempo era considerato un capriccio da intellettuali stravaganti, contrario al senso comune.
In termini di conseguenze sociali (e anche economiche), le decisioni che verranno adottate dal Parlamento catalano, per quanto di portata locale, rischiano di ripercuotersi anche su scala nazionale, soprattutto se risulteranno favorevoli alla tesi abolizionista. Ma da un punto di vista filosofico – quello che ci interessa in questa sede – la questione più rilevante è il dibattito stesso, specialmente per le sue implicazioni etiche (l’atteggiamento morale da tenere verso gli animali) e ontologiche (la relazione che ci lega alla natura). In realtà, tali questioni di fondo non sono state affrontate nel dibattito parlamentare: anzi, diciamo pure che hanno brillato per la loro assenza.
Forse il luogo e il momento per porle non erano i più opportuni, ma salvo brevi discorsi a carattere teorico che non hanno lasciato il segno, si è persa una buona occasione per riflettere su questi temi. Le considerazioni che propongo in queste pagine cercano almeno parzialmente di rimediare a tale mancanza, poiché il tema – indipendentemente dalla corrida – lo merita. Per quanto riguarda la retorica sublime che tanto infiamma sostenitori e detrattori della corrida, riconosco che mi annoiano enormemente frasi come «la tauromachia è l’espressione dell’animo spagnolo e per questo non potrà mai essere sradicata dal nostro paese», o «le corride sono forme di sadismo collettivo, antiquato e fanatico, che si alimenta della sofferenza di esseri innocenti», come pure le loro numerose varianti. Mi risulta più facile riconoscermi nelle parole dell’ammirevole Monsieur Teste di Paul Valéry: «La bêtise n’est pas mon fort».
Naturalmente, quando le discussioni hanno uno sfondo politico, gli argomenti vengono spesso interpretati in maniera distorta. Il caso a mio avviso più scandaloso è stato quello che ha avuto per protagonista il professor Jesús Mosterín, il quale, per rispondere a chi giustificava con l’argomento della tradizione il diritto a esistere delle corride, ha affermato che in certi paesi anche l’ablazione del clitoride costituisce una tradizione e non per questo è meno condannabile. L’argomento era chiaro e logicamente ineccepibile, ma ha provocato una levata di scudi da parte di numerosi politici e giornalisti, indignati dal fatto che Mosterín paragonasse l’ablazione del clitoride alla tauromachia... cosa che naturalmente non aveva fatto. Oggetto del paragone era la tradizione come fattore di legittimazione di certi usi, non gli usi in sé. Distinzione troppo sottile per i contestatori, capaci di alzare la voce e battere i piedi ma per nulla disposti a lasciarsi persuadere. Soprattutto quando si tira in ballo un tale oltraggio alla dignità delle donne... questione sulla quale nessuno è disposto a scherzare. È incredibile come, tra tutte le argomentazioni anticorrida basate sull’equivalenza implicita tra le «torture» subite dai tori e le sofferenze umane, l’unica a suonare offensiva alle orecchie dei più sia stata questo paragone concreto (e frainteso) del professor Mosterín. Per inciso, inizia a essere preoccupante il rifiuto oscurantista che una certa inquisizione pseudofemminista oppone verso qualsiasi forma di ragionamento giudicata irrispettosa nei confronti della sacra causa. Un tempo si diceva che non bisogna parlare alle stupide e alle pazze: ebbene, ogni giorno che passa sono sempre più numerose le occasioni in cui bisognerebbe attenersi a questa norma.
Mosterín, tuttavia, avrebbe potuto citare un esempio non meno utile al suo ragionamento e certamente più congruo, poiché riguarda una tradizione dotata di valore artistico (e che per di più interessa solo i maschi, con buona pace dell’irritabile genus): mi riferisco al canto dei castrati, che per secoli furono privati della loro virilità per intrattenere gli ascoltatori – tra cui predominavano gli alti ecclesiastici e i sovrani – con la raffinatezza dei loro gorgheggi. Per quanto elevato fosse il piacere estetico provocato dalla voce di queste creature mutilate, oggi consideriamo giustificata da ragioni di decenza umanitaria – dunque, strettamente etiche – l’abolizione della crudele pratica che rendeva possibili i loro acuti.
Naturalmente in questo caso, come in quello non meno drammatico dell’ablazione del clitoride (in cui non si insegue un piacere ma semplicemente si proibisce quello femminile), le vittime sono esseri umani, non animali. Ma non si potrà applicare lo stesso criterio al caso della corrida, in cui una tradizione artistica si basa anch’essa sul dolore di esseri viventi?
Che le corride costituiscano una tradizione è un dato indubbio, anche se – osserva giustamente il professor Mosterín – il radicamento ancestrale non legittima di per sé né le feste, né i comportamenti, né nulla di nulla: scusate, ma siamo moderni. Ed essere moderni vuol dire avere pregiudizi favorevoli verso ciò che è nuovo, non verso ciò che è antico. Dirò di più: anche la tauromachia racchiude un suo innegabile valore artistico, soprattutto in un’epoca come la nostra così generosa nel concedere la patente di «arte» ai prodotti e alle attività più insospettabili. Ci manca solo che possiamo chiamare «opera d’arte» l’orinatoio di Duchamp o qualsiasi piatto decostruito di Ferrán Adriá e non una grande esibizione di Curro Romero! E tuttavia nemmeno la perfezione estetica serve come certificato universale di buona condotta: pensate di nuovo ai castrati...
Da parte loro, i volenterosi militanti anticorrida hanno coniato il motto «la tortura non è cultura». E che altro sarebbe, di grazia? Piaccia o no, la tortura è cultura, al pari dei missili terra-aria o dello spionaggio industriale. Avrebbero potuto sostenere che la tauromachia – una tortura, a loro modo di vedere – è una forma di cultura da condannare, come tanti altri prodotti culturali che a volte accettiamo e in altri casi cerchiamo di estirpare: pensiamo alla tortura di esseri umani, per quanto si possa considerare «culturale» una tale forma di barbarie.
Dunque, coloro che propongono di vietare per legge la corrida non lo fanno in nome di un sentimento personale di condanna e ripugnanza verso di essa (la sensibilità di ognuno, per quanto nobile e «illuminata», non può trasformarsi in norma obbligatoria per gli altri) né perché ne mettono in dubbio i valori tradizionali, estetici o culturali (per non menzionare quelli economici o lavorativi), ma perché la considerano incontrovertibilmente immorale: di una immoralità, per giunta, non meramente personale, ma civile, che non può essere accettata nella società decente in cui vogliamo vivere. È questo il nocciolo della questione: le corride devono o no essere considerate immorali dal punto di vista civile? Se lo sono, nel senso che non risultano compatibili con diritti fondamentali su cui si basa la nostra Costituzione o con principi etici indiscutibili sui quali vorremmo che si basasse la civiltà, allora devono essere proibite a dispetto della tradizione e dell’arte che le attestano e per quanto possano costituire il modus vivendi professionale di numerose persone. Come ha affermato un militante antitaurino in occasione dell’ultima Settimana Santa, anche la crocifissione di Cristo ha reso possibili meravigliose opere d’arte e dato luogo a nobili tradizioni di pietà, ma non per questo consentiamo che oggi si continui a crocifiggere la gente. Ovvio che Cristo non è un toro (né una tigre, come pretendeva William Blake), ma l’Agnello di Dio, ossia un tipo di animale molto speciale e diverso rispetto agli altri. Arriviamo così alla questione di fondo: per accettare i paragoni di cui si servono gli oppositori della corrida per argomentare le loro posizioni, dobbiamo equiparare i tori agli uomini o agli esseri divini, cioè modificare il concetto abituale di animalità.
Alla riflessione su questa fondamentale questione di etica applicata è dedicata la maggior parte del libretto che avete in mano. La domanda a cui tenterò di fornire una risposta efficace è la seguente: «Gli animali sono esseri umani allo stesso modo in cui gli esseri umani sono animali? Qual è l’atteggiamento etico adeguato da tenere nei confronti delle bestie? Si devono riconoscere diritti agli animali e considerare la difesa dei loro interessi o del loro benessere come parte dei nostri doveri morali? Con loro abbiamo stipulato un contratto – come con i nostri compagni di genere – o istituito soltanto un protocollo di comportamenti che dobbiamo regolare in modo specifico, specie per specie?». È ovvio che le risposte a tali quesiti interessano tutti, appassionati di corride e no. Ed è altrettanto ovvio che queste risposte non chiamano in causa soltanto una certa forma di divertimento festivo tipico di certi luoghi (la Spagna, numerosi paesi dell’America Latina, la Camargue francese, ecc.), ma implicano delle conseguenze per quanto concerne la convivenza con gli altri esseri viventi del pianeta. Un tema controverso, dunque, che impone alcune riflessioni storiche, per quanto la nostra epoca nutra scarso interesse per la storia.
Le pagine che seguono possono essere lette in due direzioni: partendo dalla fine, dove affronto la questione specifica della tauromachia, per passare alla riflessione generale su come devono essere trattati gli animali; o al contrario, iniziando dalla riflessione più generica per arrivare a quella più concreta che l’ha motivata. In entrambi i casi, l’importante è l’indagine di fondo, non il contesto folklorico ed emotivo della discussione specifica sulla corrida. I testi della seconda parte sono scritti occasionali e in un certo senso riassumono in modo più giornalistico la mia opinione sul tema. È curioso notare che quando nel 2004 pronunciai il discorso di inaugurazione della Feria de Abril a Siviglia (che apre la seconda parte di questo libro), gruppi di cittadini si adoperavano per dichiarare Barcellona «città detaurinizzata», mentre un paio di anni più tardi José Tomás trionfava nell’arena della capitale catalana facendo il tutto esaurito. Ora è il Parlamento della Catalogna a riproporre il tema. E io sono di nuovo qui, pronto a discutere con tutti un’altra volta... e tutte quelle di cui ci sarà bisogno. Certamente non spero di «convertire» nessuno al mio modo di pensare, ma mi piacerebbe convincere i lettori che il pensiero non è mai di troppo quando cerchiamo di stabilire principi e fissare norme di vita, persino quando, per emotività o testardaggine, i temi sembrano destinati a essere risolti sull’onda dell’impulso momentaneo e di sentimenti confusi.
Aprile 2010