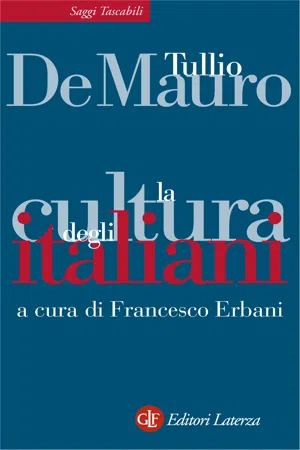1. La cultura, le culture
Erbani Come prima cosa, per avviare questa conversazione, proviamo a chiarirne l’oggetto. È possibile, parlando di una popolazione, definirne la cultura? E, più in dettaglio, è possibile parlare di una cultura degli italiani?
De Mauro Da parecchio tempo cerco di non usare la parola «cultura» al singolare in riferimento a una popolazione, e specialmente agli italiani. Perché credo che il vocabolo copra una serie di realtà molto diverse. L’uso restrittivo di questa parola è correntemente testimoniato da intere colonne del Grande dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia, e arriva, grosso modo, fino al bravo Paolo Villaggio che ha scritto un libretto, Come farsi una cultura mostruosa. In questa accezione restrittiva «cultura» vuole dire «cultura intellettuale». Ma ancor più che cultura genericamente intellettuale, nella nostra tradizione italiana «cultura» vuol dire specificamente «cultura letteraria». Se si vuole, «letterario-filosofica», ma io direi piuttosto «letterario-ideologica».
D. Può farmi un esempio?
R. Un esempio altissimo di questo uso restrittivo è il volume di Alberto Asor Rosa, La Cultura, incluso nella Storia d’Italia Einaudi. Lì si parla della cultura al singolare, dal 1870 al 1976, ed è inutile cercare qualsiasi nome che non sia di scrittore, poeta, romanziere, critico letterario, storico della letteratura, saggista di varia umanità. E non c’è traccia del fatto che siano esistiti in questo paese non solo singoli studiosi, ma scuole e tradizioni di discipline naturalistiche, fisiche, matematiche. La cultura è – in questa accezione – conoscenza delle belle lettere. Nel libro di Alberto, con il quale ho discusso varie volte, c’è solo un nome di un non letterato, quello del matematico Federigo Enriquez. Ma perché vi figura? Perché ebbe una polemica con Croce intorno al 1911-12, e Croce lo bastonò duramente poiché Enriquez lamentava l’attitudine esclusivamente umanistica della nostra tradizione intellettuale. Questa è l’opinione comune: chi conosce a memoria una poesia di Montale è colto, chi non la conosce non lo è. Può essere un grande matematico o biologo, ma non conosce Montale: non è colto. Tutto il resto della cultura, anche della cultura intellettuale, è in ombra.
D. E invece?
R. E invece a me pare ovvio pensare che nella cultura esista anzitutto anche una componente scientifica, e ciò in qualsiasi paese, perfino nel nostro, che in questa materia soffre di una qualche deprivazione, per usare l’espressione di Antonio Gramsci. E non solo. In disaccordo con un altro amico carissimo, oltre Asor Rosa, e cioè Carlo Bernardini, credo che esista anche una dimensione tecnica, tecnologica, operativa delle culture intellettuali. E anche qui sempre noi italiani registriamo una qualche povertà.
D. Cosa vuol dire dimensione tecnica delle culture intellettuali?
R. L’ingegnere, il medico, ma persino il funzionario di banca o il finanziere, sono anche loro portatori di ciò che secondo me va chiamato cultura. Direi di più. La spinta a grandi elaborazioni intellettuali, anche scientifiche, anche molto astratte, è venuta proprio da tecniche molto prossime all’operatività e alla pratica. Ciò è accaduto dalle scienze mediche all’idraulica, o alla scienza delle costruzioni. Per conto mio questo è evidente e mi pare strano che un fisico come Bernardini, molto attento alla storia delle idee scientifiche, e del come si siano formate, di fronte al valore intrinseco e di promozione conoscitiva delle pratiche ingegneristiche – tanto per fare un esempio – si chiuda a riccio e sostenga solo le virtù della cultura intellettuale e scientifica nelle sue forme più astratte. E invece non ci dovrebbe essere bisogno di ricordare quello che sappiamo dalla storia delle elaborazioni scientifiche, anche le più sofisticate, e cioè quanto agiscano le spinte che vengono dalla pratica addirittura artigianale. Il caso di Galilei è clamoroso: Galilei elabora una prospettiva radicalmente nuova per guardare agli eventi fisici, costruita attraverso la lettura matematica e quantitativa dei fenomeni e la replicabilità delle esperienze, ma muovendo da ciò che osserva nell’Arsenale di Venezia, dove per far navigare una nave era necessario rispettare una serie di procedure pratiche che poi hanno trovato la loro interpretazione organica nella meccanica classica.
D. È quantomeno singolare che lei, di formazione umanistica, debba convincere i suoi colleghi scienziati del valore della pratica.
R. Una volta mi è capitato di parlare nella facoltà di Medicina della Sapienza di Roma e di leggere lo stupore dipinto sulla faccia dei colleghi quando ho provato a dire che, non solo nel mondo antico, ma anche nel mondo contemporaneo, le pratiche mediche sono la madre di tutte le scienze, una fonte fondamentale di spinte teoriche. L’hanno scambiata per una forma di piaggeria nei loro confronti. Ricordo che Marino Raicich, che ha dedicato studi insuperabili a molti aspetti della storia dell’istruzione in Italia, negli ultimi anni di vita diceva di essersi pentito per aver lasciato in ombra la cultura dei Manuali Hoepli. Non perché la ritenesse di serie B, mi diceva, ma perché, essendo ritenuta di serie B o di serie C addirittura, anche lui aveva finito con l’occuparsi di latino, di greco, di italiano, di filosofia, di storia del loro insegnamento, lasciando del tutto a margine il ruolo che hanno avuto questi veicoli di cultura tecnica che furono i Manuali. Del resto, se si esamina la legge Casati sull’istruzione, che risale al 1859, il disegno è già assolutamente chiaro. C’è una cultura alta, che è quella classico-umanistica, c’è una cultura marginale, quella scientifica, e poi c’è una cultura per vili meccanici, che pure serve per sopravvivere, ed è quella degli studi tecnici.
D. E questa è rimasta la partizione classica che ha dominato per decenni nel sistema scolastico italiano...
R. ...e che a me pare profondamente sbagliata. Ma questa è solo una parte del dubbio che l’uso della parola «cultura» provoca se riferito esclusivamente alle forme intellettualmente più elaborate. Io resto affezionato a una definizione larga di quel termine, e più precisamente a quella che forniscono etologi e antropologi.
D. E quale definizione danno etologi e antropologi?
R. Chiamano, chiamiamo cultura quel complesso di elaborazioni, condizionate dal patrimonio genetico di una specie vivente, ma non dettate da questo, nascenti dal rispondere ai bisogni che quella specie trova sul suo cammino. Trasmissione per imitazione, ricombinazione di elementi già dati, invenzione sono le tre radici della cultura intesa a questo modo. Negli anni Settanta Danilo Mainardi pubblicò un libro di larga divulgazione intitolato provocatoriamente L’animale culturale, in cui analizzava tutti i fenomeni legati alla capacità innovativa di specie viventi, diverse dagli esseri umani. Queste capacità innovative sono originate non da una curiosità intellettuale, ma da un bisogno pratico che stimola la curiosità intellettuale. Ora possediamo una gran quantità di conoscenze sulle capacità culturali di altri esseri viventi diversi dall’uomo, non solo di grandi mammiferi o di scimmie, perfino di specie evolutivamente più lontane da noi, compresi i microrganismi. Capire come funzionano i sistemi simbolici e di accumulo dell’informazione da parte dei virus è un’acquisizione di enorme interesse per chi si occupa di semiotica e di teoria della comunicazione allo stato puro, ma queste indagini hanno poi ricadute sull’immunologia e l’immunologia ne ha, a sua volta, sulla nostra vita di esseri umani. Quindi lo sviluppo che ha realizzato quella che chiamiamo zoosemiotica, dagli anni Quaranta e Cinquanta in poi, cioè lo studio delle culture linguistiche, comunicative quantomeno, di altri esseri viventi, è uno studio che risponde continuamente a sollecitazioni molto pratiche, di sopravvivenza o di migliore sopravvivenza.
D. Torniamo a quella nozione larga di cultura.
R. Ci torno per aggiungere che qualunque popolazione, anche la più «incolta» – come diremmo in riferimento alla cultura intellettuale, «alta» – non può non avere una sua capacità di elaborazione culturale. A me pare che questa definizione larga sia utile per lo studio di qualunque cultura, e per lo sviluppo di quelli che in ambito anglosassone ormai si chiamano cultural studies, i quali partono da questa nozione larga e vi iscrivono poi la considerazione di fenomeni specifici, come le formazioni intellettuali più elaborate o la diffusione di conoscenze attraverso la scuola. Questa definizione larga è particolarmente preziosa nel caso della frantumata realtà italiana. Dove mi pare che ci si orienti con sufficiente sicurezza soltanto tenendo conto delle molte facce che la cultura ha assunto.
D. Può fare qualche esempio?
R. I fenomeni di arricchimento o di deprivazione si possono osservare soltanto tenendo conto di tutti questi aspetti. In altri termini, se ci si riferisce esclusivamente alle culture intellettuali – tanto più con l’ulteriore restrizione alle sole culture letterarie – si ha una visione abbastanza distorta e rischiamo di perdere di vista fenomeni enormi quali la rivoluzione avvenuta in campo linguistico, una rivoluzione in parte nascosta, di cui la cultura alta non è pienamente consapevole perché rifiuta perfino i numeri che ci permettono di capire che cosa è successo tra la metà del Novecento e oggi. Non mi riferisco solo al cammino verso l’appropriazione della lingua nazionale, di cui, se lei vuole, avremo modo di riparlare. Una lingua che cinquant’anni fa era sconosciuta per lo meno a due terzi della popolazione e che oggi è parlata – più o meno bene, in modo più o meno soddisfacente – dal 95 per cento degli italiani ed è scritta – di nuovo, in modo più o meno soddisfacente – da molto più di un terzo della popolazione. Ma non è questo il fenomeno che a mio avviso merita più attenzione. Penso anche a quell’ordine di accadimenti culturali di cui si sono occupati pochi, e uno dei pochi è un bravissimo studioso e intellettuale sardo che si chiamava Michelangelo Pira. Pira ha scritto un bellissimo libro molti anni fa, pubblicato dopo la sua morte nel 1983, dal titolo completamente sballato ed enigmatico: La rivolta dell’oggetto. Io ho tentato di farmene propagandista, ma con scarso successo. Pira prende in esame la cultura del mondo contadino sardo, ma la sua indagine vale per tutta la realtà del mondo contadino, ancora dominante in Italia – se si ha una visione larga della cultura – negli anni Cinquanta. Questo mondo aveva al suo centro, secondo Pira, non solo la famiglia o la famiglia allargata, ma la «bottega familiare» vista come luogo di elaborazione del sapere e del saper fare, e anche del sapersi orientare nel mondo delle relazioni. Lì si imparavano le cose più importanti della vita, lì più che a scuola. Dall’igiene al modo in cui si tiene una casa. Nel mondo contadino più propriamente inteso si andava molto in là, la casa si imparava a costruirla. La bottega familiare garantiva a gran parte della popolazione italiana, tagliata fuori dalla scuola, un tessuto di competenze che, dopo essere state capitalizzate, sono state investite. La manodopera che dal Veneto o dalle campagne del Sud si spostava in città negli anni Cinquanta e Sessanta quelle competenze le ha messe al servizio della grande industria a costi bassissimi.
D. E cosa è rimasto di questo patrimonio?
R. Chi è arrivato in città non ha trovato nulla, o quasi nulla, di ciò che la bottega familiare in una realtà contadina riusciva a garantire. Gli adulti hanno trovato lavoro e redditi più alti, e questo era desiderabile. Ma i loro figli non hanno trovato niente. Hanno trovato scuole assolutamente incapaci di capire cosa potessero e dovessero fare dinanzi a questi nuovi arrivati. Pira scrive dieci, quindici anni dopo questi avvenimenti. Ma è impressionante che sul campo negli anni Cinquanta solo alcuni, da Pier Paolo Pasolini a don Lorenzo Milani, colgano il rischio di quello che stava avvenendo. Il rischio di quello che quasi vent’anni dopo, in un editoriale del «Corriere della Sera», Eugenio Montale chiamò «il terremoto antropologico sotterraneo» che ha devastato il paesaggio culturale italiano. Ma culturale, evidentemente, qui è nel senso più largo del termine. Dinanzi a Gianni, uno dei suoi alunni, don Milani avverte il pericolo che sia catturato senza ancore da un vortice di consumismo e poi, al limite estremo, finisca con alimentare i bisogni della malavita. Gianni, va detto ai molti che male interpretano don Milani, è un ragazzo del suburbio fiorentino, non è l’esemplare di una resistente realtà contadina. Ma, a parte l’acutezza e la genialità di queste intuizioni così precoci, poche testimonianze possediamo di ciò che è seguito alla scomparsa della bottega familiare, cui ha stentato a corrispondere una crescita educativa integrale capace di recuperare o di sostituire il sistema delle competenze e dei valori che la bottega familiare consentiva. La scuola è stata accettata, ma vissuta come l’istituzione che assicurava livelli formali di conoscenza, che offriva il pezzo di carta, un’alfabetizzazione più alta, molto più alta delle generazioni passate. Ma questa non è sufficiente: se nella bottega familiare della prima m...