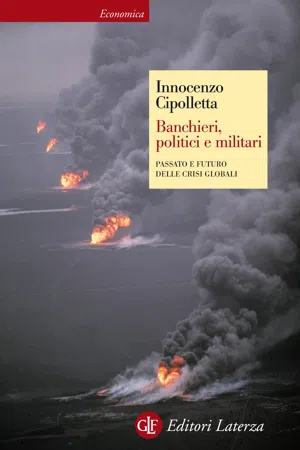II. La prima recessione globale: la crisi da petrolio
1. La guerra del Vietnam e i disavanzi gemelli
Gli anni Sessanta furono anni «favolosi» per i paesi occidentali. La crescita economica era forte, l’inflazione bassa e la disoccupazione stava per essere sconfitta. Ma è proprio nella seconda parte di quel decennio che il sistema economico dei paesi industriali cominciò a presentare grosse tensioni economiche e sociali. La ragione principale sembrava essere l’emergere di una nuova generazione, nata dopo la guerra, che rifiutava le logiche sociali, politiche e militari della guerra fredda.
È la generazione del baby boom. I nati nel 1945-1950 hanno costituito la prima generazione del dopoguerra. Numerosa, come sempre avviene dopo un conflitto che ha tenuto separate le famiglie, essa non aveva vissuto gli orrori della guerra ed era anche priva dei molti condizionamenti culturali della generazione precedente. Questi furono i giovani del mondo occidentale che, nel corso degli anni Sessanta, cominciarono ad esprimere nuove idee politiche. Il bersaglio divenne presto il rifiuto della logica bipolare USA-URSS. Da qui, l’esaltazione della gioventù di Praga contro il dominio russo nel campo dei paesi del mondo comunista. Da qui anche la forte opposizione in Occidente al crescente impegno degli USA nella guerra del Vietnam.
Gli Stati Uniti erano rimasti imbrigliati nelle guerre di indipendenza che si svolgevano nel Sud-Est asiatico contro la presenza coloniale della Francia, in quella che allora si chiamava Indocina. Dopo alcune sconfitte, la Francia si stava ritirando dalla regione ed apparivano sempre più evidenti l’influenza dell’Unione Sovietica e la presenza della Cina comunista, che volevano estendere il loro controllo nella regione asiatica. Gli USA cominciarono ad inserirsi in queste vicende sin dagli inizi degli anni Sessanta, proprio per ostacolare l’avanzata cinese. L’America finì per assumere il ruolo di sostenitore del Vietnam del Sud contro gli attacchi del Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam che ormai controllava il Vietnam del Nord a regime comunista. Di fatto l’America era convinta di poter ripetere nel Vietnam la strategia che era stata vincente in Corea: una strenua difesa del Sud del Vietnam per edificare uno Stato libero da contrapporre a quello comunista del Nord. L’esperienza coreana sembrava indicare che l’obiettivo era a portata di mano. I generali americani erano certi di combattere ancora la precedente guerra.
La guerra del Vietnam costò moltissimo in termini di vite umane, di distruzioni civili e di impegni economici. Da parte vietnamita, le cifre dei caduti sono stimate attorno ai cinque milioni di persone: un milione di combattenti e circa quattro milioni di morti civili. Da parte delle truppe occidentali (non solo statunitensi perché nella guerra furono coinvolti molti altri paesi del mondo occidentale) i caduti sono stati oltre 58 mila ed i feriti oltre 153 mila. Questo grande tributo di vite umane descrive l’impatto della guerra meglio delle cifre economiche, che comunque furono ingenti. Il costo complessivo della guerra del Vietnam è stato stimato in oltre 500 miliardi di dollari (di allora) nel corso degli anni. Si tratta, per l’epoca, di una cifra colossale che ha contribuito non poco a generare pesanti squilibri nei pagamenti internazionali, con ripercussioni permanenti sul sistema economico internazionale.
La guerra del Vietnam mutò radicalmente lo scenario mondiale e nessuno all’epoca se ne rese pienamente conto. I movimenti di opposizione studentesca cominciarono negli USA con la rivolta a Berkeley, Università della California, nel 1964. Essi sfociarono ben presto in opposizione alla crescente implicazione militare degli USA, che già con John F. Kennedy si era intensificata con l’invio dei «consulenti» nel Vietnam. Il movimento studentesco nato a Berkeley portò poi al Maggio francese del 1968, alla Primavera di Praga sempre nel 1968 (dal 5 gennaio al 20 agosto), all’«autunno caldo» in Italia nel 1969. Furono tutti episodi provocati da cause specifiche, diverse tra di loro, ma legate dalla forte componente giovanile, studentesca e sindacale, che li caratterizzò, tanto da assumere l’appellativo di «contestazione generazionale». La contestazione studentesca e sindacale pose fine alla fase di pace sociale che aveva regnato nel mondo occidentale durante il periodo della ricostruzione post-bellica, in un clima di guerra fredda.
L’impegno militare degli USA ebbe chiare ripercussioni economiche. L’economia americana è stata sostenuta e distorta dalla guerra nel corso degli anni a cavallo del 1970. Soprattutto essa fu squilibrata profondamente, dando luogo a quelli che furono poi chiamati i «disavanzi gemelli». Da un lato cresceva il disavanzo pubblico per l’aumento continuo delle spese militari, che non potevano essere finanziate con inasprimenti fiscali per non demoralizzare la popolazione e per non deprimere l’economia. Spese che si autoalimentavano, posto che, accanto a quelle per gli interventi militari, cresceva sempre di più anche la spesa per i sussidi ai reduci e per il loro reinserimento nella società. Al crescente disavanzo nei conti pubblici si accompagnò un altrettanto crescente disavanzo nei conti con l’estero, perché le spese militari erano in gran parte erogate all’estero e perché la crescita della domanda interna, trainata dalla spesa pubblica, favoriva un forte aumento delle importazioni.
Tutta la struttura economica degli USA venne distorta a favore delle spese militari, ciò che finì per far perdere competitività ai settori civili. Il saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti statunitense, che era ancora positivo nel 1966 per 2,1 miliardi di dollari, diventò negativo nel 1968, fino a raggiungere nel 1972 un disavanzo di circa 8 miliardi di dollari. Il saldo globale, compresi i movimenti di capitale, divenne passivo per ben 30 miliardi di dollari nel 1971 in seguito alla crescente uscita di capitali dagli USA.
Gli USA vivevano chiaramente al di sopra delle loro possibilità e finanziavano il loro debito stampando dollari che venivano accettati da tutti e conservati come risparmio, perché la moneta americana, a quella epoca, era garantita dall’oro. L’accordo di Bretton Woods, stipulato alla vigilia della fine della seconda guerra mondiale, fissava i cambi delle diverse monete con il dollaro e garantiva che il dollaro fosse sempre convertibile in oro ad un valore predeterminato, pari a 35 dollari all’oncia di oro fino. A sua volta gli USA si impegnavano a tenere nelle loro riserve (detenute a Fort Knox) un ammontare d’oro sufficiente a servire da garanzia per la conversione del dollaro. Questa garanzia faceva sì che tutti gli altri paesi tenessero dollari nelle loro riserve, perché il dollaro poteva essere tramutato in oro quando se ne avesse avuto bisogno o desiderio. Nasceva da lì una capacità di indebitamento all’estero quasi illimitata per gli USA.
Presupposto di questo accordo era che gli USA non approfittassero della loro posizione di creatore di moneta di riserva. Ossia che gli USA non avrebbero stampato dollari in eccesso, con il presupposto che gli altri paesi li avrebbero tenuti nelle loro riserve. E così fu fino alla metà degli anni Sessanta. Ossia fino a quando gli USA non si trovarono coinvolti fino al collo nella guerra del Vietnam. Presi nel turbine degli eventi, gli USA intensificarono l’impegno bellico nel Vietnam, impiegando somme consistenti, sotto la presidenza del democratico Lyndon B. Johnson (22 novembre 1963-20 gennaio 1969) e poi del repubblicano Richard Nixon (20 gennaio 1969-9 agosto 1974).
Questi comportamenti diedero un colpo mortale agli accordi di Bretton Woods. Gli USA presero a stampare dollari per i crescenti esborsi relativi alle spese militari, ciò che determinava un pesante disavanzo pubblico e contribuiva al disavanzo dei conti con l’estero (i disavanzi gemelli). A loro volta questi dollari erano accumulati nelle casse delle riserve degli altri paesi, certi della loro convertibilità in oro al prezzo stabilito di 35 dollari l’oncia, grazie agli accordi di Bretton Woods. Ma il peso dei dollari nelle riserve dei paesi cominciò a crescere in modo così rilevante che alcuni paesi presero a dubitare della capacità degli USA di far fronte ad una eventuale domanda di oro.
Iniziò così una vera corsa all’acquisto dell’oro per garantirsi da eventuali svalutazioni del dollaro. In questo si distinse la Francia, sotto la presidenza del generale Charles de Gaulle, venuto al potere in un clima di rinnovato nazionalismo. Il presidente francese, fautore di un ritorno della grandeur francese dopo le sconfitte coloniali, fece uscire la Francia dalla NATO ed avviò un programma francese di armamento nucleare (la force de frappe). A ribadire la sua indipendenza anche in politica economica, nonché la divergenza di opinioni con gli USA, la Francia cominciò a convertire le sue riserve di dollari in oro sul finire degli anni Sessanta. Una conversione legittima ma che generò evidenti tensioni sul prezzo dell’oro. Gli USA impiegarono parte delle loro riserve d’oro per far fronte alla domanda di metallo prezioso, ma ben presto si accorsero che questa situazione non poteva durare a lungo, pena l’esaurirsi delle riserve detenute a Fort Knox. È così che si arrivò alla decisione di uno sdoppiamento del mercato dell’oro e della creazione presso il Fondo Monetario Internazionale dei Diritti Speciali di Prelievo (Special Drawing Rights, SDR).
I Diritti Speciali di Prelievo, nelle intenzioni dei loro creatori, avrebbero dovuto sostituire dollari e oro nelle riserve delle Banche Centrali. Essi, si pensava, non sarebbero stati garantiti da nessun valore se non dall’accordo internazionale al Fondo Monetario Internazionale.
Era così nata la moneta virtuale nel 1968, ossia nell’anno dell’«immaginazione al potere», come recitava uno slogan in voga nel Maggio francese. Un antico sogno, una vera utopia. Quella di costruire una nuova moneta internazionale non più limitata da elementi fisici (come l’oro), non più battuta da un singolo Stato nella sua discrezione, ma creata da un organismo internazionale in quantità sufficiente a far crescere il commercio mondiale a ritmi tali da assicurare un elevato sviluppo economico, senza inflazione.
Questo sogno era stato più volte accarezzato nel secolo scorso. La scarsa disponibilità di oro e la sua distribuzione ineguale nel mondo avevano generato non poche difficoltà alla crescita dei commerci internazionali nella storia economica dei paesi. Prima degli accordi di Bretton Woods i rapporti internazionali erano regolati dal Gold Standard. In tale sistema le monete erano convertibili in oro direttamente e gli Stati nazionali erano costretti ad avere, nelle loro riserve, sufficienti quantità di metallo giallo per compensare momenti di squilibrio anche nei rapporti bilaterali. Quando uno Stato non aveva sufficiente oro in riserva, era costretto a svalutare la moneta e ad adottare drastiche misure di freno all’economia per ridurre le importazioni, con pesanti ripercussioni sull’occupazione e sulla ricchezza del paese. Nella prima metà del Novecento, il Gold Standard aveva frenato gli scambi mondiali, generato instabilità e originato forti tensioni tra paesi, poi sfociate in guerre devastanti.
Gli accordi di Bretton Woods, con l’introduzione del dollaro quale moneta garante della convertibilità in oro, avevano consentito una crescita sostenuta degli scambi mondiali. Ma la liquidità internazionale era così legata alla volontà e alle esigenze di un solo paese, gli USA. La vera soluzione appariva quella di sostituire un bene disponibile in modo limitato, come l’oro, o la valuta di una nazione, come il dollaro, con una valuta prodotta sulla base di studi scientifici e generata da accordi internazionali. Questo sembrava essere il trionfo della razionalità illuministica rispetto ai contingentamenti della natura o alla dipendenza dalla politica economica di un solo paese. Un grande passo in avanti verso un nuovo sistema monetario e finanziario internazionale, finalmente trasparente e stabile!
Purtroppo la ragione non prevalse e l’avventura dei Diritti Speciali di Prelievo non decollò mai veramente. L’utopia di una moneta di riserva internazionale svincolata dai beni e dai capricci di una singola nazione non si è ancora realizzata. Ancor oggi c’è chi chiede l’abbandono del Dollar Standard e la creazione di un nuovo strumento di riserva. All’inizio del terzo millennio, in piena crisi finanziaria globale, sarà la Cina a chiedere la creazione di una moneta internazionale di riserva, nel timore di una pesante svalutazione del dollaro, dopo aver accumulato miliardi di dollari di riserve durante la prima fase della globalizzazione dei mercati. Una storia che, come si vedrà nel seguito di queste pagine, si è nuovamente riprodotta.
Il sogno di una scelta razionale nella creazione di liquidità internazionale s’infranse di fatto nel 1971, sotto la pressione della speculazione internazionale. La situazione precipitò ancora una volta per gli squilibri dei conti americani devastati dall’impegno militare nel Vietnam. I mercati internazionali ormai odoravano nell’aria una svalutazione del dollaro e si erano precipitati ad investire nella moneta allora ritenuta più forte, il marco tedesco. La moneta della Germania subì forti pressioni al rialzo, malgrado una politica tedesca volta a scongiurare l’afflusso di dollari. Infatti, la Germania adottò misure che limitavano le possibilità del sistema bancario tedesco di indebitarsi all’estero. In quell’anno esplose il mercato dell’eurodollaro, ossia il mercato dei dollari detenuti fuori dagli USA da parte delle banche internazionali. Venne così dato il via ad un poderoso processo di finanziarizzazione dell’economia. In particolare, le imprese e gli operatori tedeschi, che non potevano finanziarsi presso il sistema bancario per la politica restrittiva imposta dalla Bundesbank, si indebitarono sul mercato dell’eurodollaro, al punto che nel solo primo quadrimestre del 1971 affluirono in Germania quasi 4 miliardi di dollari, entrati in larga parte per motivi speculativi. Questi afflussi significavano una sola cosa: l’attesa di una rivalutazione del marco e delle altre monete europee. Il 5 maggio 1971 la Banca Centrale tedesca acquistò sul mercato valutario, in poche ore di contrattazioni, ben un miliardo di dollari e quindi fu costretta ad annunciare la sospensione degli interventi sul tasso di cambio a pronti del marco con il dollaro.
Da qui la decisione degli USA di porre fine agli accordi di Bretton Woods. Il 15 agosto 1971 il presidente degli USA, Richard Nixon, annunciò la sospensione della convertibilità del dollaro in oro e l’imposizione di una sovrattassa del 10% sulle importazioni (oltre a misure di agevolazione fiscale per investimenti in beni strumentali prodotti negli USA). Era la fine del Gold Exchange Standard ideato a Bretton Woods il 22 luglio 1944, alla vigilia della conclusione della seconda guerra mondiale. Era l’inizio di una nuova era. La Relazione della Banca d’Italia relativa al 1971 (presentata il 31 maggio 1972) coglie bene questo clima. Essa inizia con queste parole: «Il 1971 è stato un anno cruciale per l’economia internazionale: l’esigenza di rivedere ed adattare l’ordine sul quale le relazioni economiche internazionali poggiano da oltre un quarto di secolo si è posta con immediatezza. Quell’ordine era stato definito nelle sue grandi linee prima della conclusione del secondo conflitto mondiale».
Le motivazioni americane non erano solo valutarie. L’amministrazione Nixon aveva crescenti difficoltà a gestire l’economia. Il malcontento negli USA per la prosecuzione della guerra e per il degrado della competitività americana era forte. L’inflazione cresceva ed il governo statunitense aveva deciso un blocco dei salari ed un controllo dei prezzi, cosa inaudita per un paese liberale con un governo conservatore. Sotto la pressione dei gruppi industriali e dei sindacati, spaventati per l’aumento della disoccupazione, gli USA si impegnarono in politiche protettive e nazionalistiche. C’era da registrare anche il rancore degli USA per la politica agricola europea che colpiva gli interessi dei potenti agricoltori americani. Pesava il malumore dell’opinione pubblica americana che vedeva gli alleati occidentali sottrarsi agli impegni militari nel Vietnam e alle politiche di aiuto internazionale ai paesi in via di sviluppo che gli USA portavano avanti coerentemente con la loro politica di ingerenza e di controllo militare. D’altro canto, l’economia USA aveva avuto una recessione nel 1970 ed ogni recessione fomenta pulsioni protezionistiche in quel paese, sia da parte dei sindacati che da parte dei gruppi industriali.
Al fine di evitare una devastante guerra protezionistica con ritorsioni da parte degli altri paesi, si arrivò ad un accordo alla fine del 1971 (accordo di Washington del 18 dicembre 1971) tra paesi europei, Giappone ed USA per la determinazione di nuovi rapporti di cambio. Il dollaro venne svalutato del 9,5%, mentre lo yen si rivalutò del 13,5% e la lira e il franco francese si svalutarono leggermente (–1,5%). Si decise anche un ampliamento delle bande di fluttuazione delle monete (dall’1% al 2,25%) e si diede il via al nuovo regime, che sarà poi di fluttuazione generalizzata dei cambi.
L’accordo di Washington, che sanciva la fine dei cambi fissi, sembrò aprire la strada ad un accordo monetario all’interno della Comunità Europea, volto a mantenere stabili i cambi reciproci. In questo senso ci si mosse prudentemente, come riferisce lo stesso Governatore della Banca d’Italia Guido Carli nelle sue Considerazioni finali della Relazione della Banca d’Italia (31 maggio 1972): «In queste condizioni si è rafforzato il convincimento della necessità di trasformare la Comunità economica europea in un’area monetaria munita di una propria individualità nel quadro del sistema monetario internazionale. In seguito ad una decisione assunta dal Consiglio della Comunità, è stato stabilito che, con decorrenza del 24 aprile 1972, i margini di oscillazione delle monete comunitarie intorno alle parità reciproche non possano superare il 2,25%, anziché il 4,50% che risulterebbe dall’applicazione dei limiti massimi di fluttuazione attualmente consentiti rispetto al dollaro».
Ma questo auspicio relativo alla costituzione di un’area monetaria europea verrà travolto dagli eventi e si dovette ripiegare su una situazione di libera fluttuazione delle monete, seppure con interventi delle Banche Centrali. Questa fu la fine degli accordi di Bretton Woods e l’inizio dell’era della grande finanza internazionale. Bisognerà aspettare il nuovo millennio per veder nascere una moneta europea: l’euro.
2. La crisi da petrolio
Gli Stati Uniti, impegnati nelle trattative di Parigi per cercare una via di uscita dalla guerra e sospinti da un’opinione pubblica interna sempre più avversa all’impegno militare, annunciarono la sospensione delle azioni offensive in Vietnam il 15 gennaio 1973. Gli accordi di Parigi per la pace vennero poi firmati il 27 gennaio 1973. Nel marzo dello stesso anno, le truppe americane vennero ritirate. Gli USA mantennero un sostegno finanziario sempre più debole per il Vietnam del Sud, che venne poi invaso dal Vietnam del Nord. Saigon, allora capitale del Vietnam del Sud, cadde il 30 aprile del 1975, ciò che pose fine definitivamente alla guerra del Vietnam e comportò la riunificazione del paese sotto il regime comunista del Nord.
Ma la fine della guerra nell’Estremo Oriente non significò un ritorno alla pace e alle condizioni prevalenti nei decenni precedenti. La bolla che era stata creata dai disavanzi gemelli degli ...