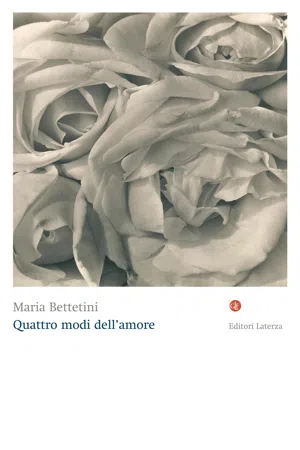Della passione
Nessun maggior dolore
che ricordarsi del tempo felice
nella miseria, e ciò sa ’l tuo dottore;
ma s’a conoscer la prima radice
del nostro amor tu hai cotanto affetto,
dirò come colui che piange e dice.
Noi leggevamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse:
soli eravamo e sanza alcun sospetto.
Per più fiate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disiato riso
essere baciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi baciò tutto tremante.
Dante Alighieri, Inferno V, 121-136
Francesca da Rimini Una vertigine, una voragine. Credevo che tutto fosse finito. Non volevo nient’altro, per l’eternità mi sarebbe stato sufficiente il tremore di Paolo, quando mio marito ci ha sorpresi, e chissà da quanti giorni ci spiava, mi sono quasi gettata sulla lama. Avevo avuto tutto, che cosa mi poteva importare una conciliazione, un perdono? Sì, Gianciotto è padre di mia figlia. Ma forse i da Polenta di Ravenna e i Malatesta di Rimini non si prenderanno cura di lei? Io avevo avuto tutto, da quell’uomo tutto tremante. Ora la sorpresa, continua quella vertigine che provavo da quando la bocca mi baciò. Mentre intorno a noi si grida, sento con sempre minor fastidio le schegge del pavimento sul viso, sulle gambe. Non ricordo perché un caldo flusso umido mi ha quasi soffocato. No, mi ha soffocato, ne sono morta. Sono felice, avevo avuto tutto e non avrei perso nulla, se un uomo violento e brutto nel letto significa qualcosa più di nulla. E mentre mi cullavo in quella meravigliosa perdita, il vento. Ero così confusa. Ma che dico vento? Bufera. Non sapevo dove aggrapparmi per avere un sostegno, finché mi sono accorta di essere già avvinta, e che Paolo nella tempesta non tremava più. Non lo avrei mai perso.
1. Pàschein
Le pagine del quinto canto dell’Inferno dantesco contengono parole ineguagliate per dire il cuore di ciò che in italiano diciamo passione, in latino passio, in greco pathos. L’essere presi e posseduti per sempre, il patire volentieri una condizione di prigionia.
Non è naturalmente possibile distinguere con precisione geometrica la passione dall’amore appassionato, dalla dedizione, dall’incantamento. Con il desiderio di non far violenza ad alcuna rappresentazione dell’amore, in queste pagine ci occuperemo solo di quel sentire che è insieme essere presi e felicemente presi. Della passione hanno scritto filosofi e poeti. Con pagine a volte dure, scientifiche, precise. A volte – e sono quelle più note e amate, o detestate, a seconda dell’indole – soavi e accattivanti. Potremo qui percorrere una storia della passione? Nemmeno per idea. Qui si sta scrivendo una storia filosofica, quindi si valuterà il senso tecnico di quel pàschein di cui sopra. Poche ed essenziali citazioni, qualche aiuto dalla letteratura, che nel 1922 per dire della follia d’amore descrive una forma di psicosi tropicale:
“Lei sa cos’è l’amok?
L’amok?... Mi pare di ricordarlo... una sorta di ebbrezza presso i malesi...
È più che un’ebbrezza... è una follia rabbiosa, una specie di idrofobia umana... un accesso di monomania omicida, insensata, non paragonabile a nessun’altra intossicazione alcolica...
La gente nei villaggi sa che nessuna forza può fermare un invasato dall’amok... perciò danno l’allarme in anticipo, quando arriva, e gridano: Amok! Amok!, e tutti scappano... ma l’ossesso corre senza sentire, corre senza vedere, pugnala tutto ciò che gli capita davanti” (Stefan Zweig, Amok, 56-57).
2. Non sempre buona, non sempre cattiva
I filosofi hanno raramente amato la passione, proprio per le caratteristiche di passività che indica l’esser preso, posseduto, del soggetto da parte di qualcosa d’altro, sia interno che esterno (Aristotele nelle Categorie contrappone azione e passione). La biga trainata da cavalli alati, che nel Fedro di Platone è metafora dell’anima, ha un significato esplicito, e infatti segue di poche righe la descrizione dei quattro generi di mania, ovvero di possesso (l’ispirazione divina di oracoli e sacerdotesse, la capacità di predire il futuro, l’arte poetica, l’eros). L’anima umana è dunque simile a un carro alato trainato da due cavalli e guidato da un auriga. Un cavallo “è bello e buono e derivante da belli e buoni”, l’altro “deriva da opposti ed è opposto” (246 B 1-3). Per l’auriga la guida del carro è molto difficile, e nella corsa che accompagna dèi e uomini attraverso l’iperuranio fino alla “pianura della verità”, se i due cavalli non sono stati ben allevati fanno sbilanciare il carro, perché “il cavallo partecipe del male cala, piegando verso terra”. Da lì la perdita delle ali, la rovinosa caduta che porta alla reincarnazione, tanto più di grado basso quanto meno l’anima si è potuta nutrire di quel prato ove si trovano i veri esseri. Il destino migliore che possa capitare è rinascere “amico del sapere (philòsophos) e amico del bello, o amico delle muse, o desideroso d’amore” (248 D 2-4), ovvero i generi di vita che più facilmente consentono un ritorno alla desiderata pianura della verità, alla compagnia degli dèi.
Ma chi è questo cavallo “opposto” e cattivo? Nella Repubblica si legge che è l’anima concupiscibile, situata nel ventre dell’uomo, capace solo di desiderare, di cercare soddisfazione a tutti gli istinti di cui è schiava, quindi con un ruolo totalmente passivo. Le sta accanto, ed è il cavallo buono, l’anima irascibile, con sede nel fegato, che ha un ruolo anche attivo grazie al coraggio (thymos) necessario per superare gli ostacoli che si frappongono all’azione, e quindi è di aiuto all’anima razionale, all’auriga. La città ideale ripropone la triplice divisione nella gerarchia che vede al grado più basso contadini, artigiani e commercianti, poi i militari (custodi) e al governo i filosofi. Ma ci si soffermi un poco sulla passione rappresentata dal cavallo buono e dai militari, che sono peraltro cresciuti come filosofi (tra loro, infatti, si sceglieranno i governanti). Tra le “malattie dell’anima” che sono le passioni (così Platone in Timeo 87 A ss.), una sola è giustificata da tutta la cultura greca, anche da Platone e Aristotele. È l’ira, la menis del pelide Achille “che tanti lutti addusse agli Achei”, e che è la vera protagonista dell’Iliade. Nel primo libro, questa stessa passione è detta menis (indignazione, risentimento), ma anche cholos (collera), menos (furore guerriero) e infine thymos, la spinta coraggiosa all’azione. In poche righe quattro sinonimi dell’unica passione riconosciuta, che è anche l’unica capace di preservare il valore del singolo guerriero e, soprattutto, il suo onore. Per Aristotele il coraggio (andrèia, quindi la pienezza dell’essere anèr, uomo) è la virtù media tra paura e temerarietà: e non esiste solo il coraggio civile o l’abilità bellica, ma anche il thymos di “quelli che agiscono per impulsività, come le bestie che si gettano contro coloro che le hanno ferite”; infatti tale genere di coraggio “è lo slancio più impetuoso contro i pericoli” e mentre le bestie agiscono solo per reazione al dolore, i coraggiosi lo fanno “per amore del bello, e il thymos coopera con loro” (Etica Nicomachea III, 6-8).
Non stupisce trovare nella classificazione delle passioni di Tommaso d’Aquino l’ira come passione suscitata da un male subìto e arduo da fuggire, una sorta di legittima difesa, e la cultura medievale non esiterà a parlare di “santa ira” definendola come ribellione del giusto: tale è la violenta reazione di Gesù contro i mercanti nel tempio raccontata da tutti e quattro gli evangelisti, con riferimento a Salmi 69 (68), 10, “perché lo zelo per la tua casa mi divora”.
3. Educare le passioni
Ma l’ira è l’unica passione a meritare un trattamento speciale, le altre sono nòsoi, malattie che stravolgono la natura umana, la cui essenza è la ragione. Occorre quindi educarle, dominarle, così come riesce a fare Ulisse che prende le distanze anche dal thymos che gli si gonfia in petto, quando scorge le ancelle di casa andare a giacere con i Proci per la notte, tutte giulive. “Il cuore gli latrava di dentro”, come una cagna quando vuole difendere i suoi cuccioli. E tenendosi il petto, Ulisse rimprovera il suo cuore: “Sopporta, cuore” e allora “fermo nell’obbedienza restava il cuore costante, tenacemente”, anche se Ulisse non riesce a prendere sonno e si rigira agitato (Odissea XX, 5-30). D’altra parte questi è l’Ulisse “dalle molte capacità” che si fece legare all’albero della nave per poter ascoltare il canto delle Sirene, dopo aver turato con la cera le orecchie dei suoi marinai. Le Sirene, infatti, orrendi esseri dal corpo di uccello e dalla testa di donna, avevano il potere di convincere i marinai a dimenticare il ritorno a casa e a raggiungerle sugli scogli, trovando morte sicura: non era solo la bellezza della loro voce ad attrarre lo sventurato marinaio, ma anche la promessa di raccontare tutto ciò che era successo in quegli anni e che riguardava la sua vita e la sua famiglia. La tentazione era massima: voci armoniose che promettevano racconti, il grado di malìa più alto. Ulisse, avvertito dalla maliarda Circe, ne esce vivo perché costringe gli altri a legarlo e a non liberarlo, una forma di resistenza alla passività dell’esser catturato che prefigura l’uomo moderno, capace di gestire le passioni provenienti dall’esterno (le Sirene) come dall’interno (il suo cuore). Rimane alle spalle, lontano dalla civiltà, l’Achille dell’Iliade che, schiavo dell’ira, avrebbe ucciso il suo compagno e sodale Agamennone, non fosse stato trattenuto “per la chioma bionda” dalla dea Atena (Iliade I, 188-222).
Che la passione fosse una malattia da curare e da cui guarire era anche idea presente nella filosofia stoica, fondata da un giovane di sangue semitico, Zenone di Cizio (333-263 a.C.), che ad Atene creò la scuola del Portico (Stoa), dove si insegnava il controllo delle passioni fino all’apàtheia, lo stato di un uomo felice in quanto diretto dal logos e libero da ogni forma di pathos, non qualcosa di esterno alla ragione, ma una sua distorsione, una diastrophè. Se lo scopo della filosofia è raggiungere la felicità secondo il proprio modo di essere, e la natura dell’uomo è nel logos, il compito di ciascuno sarà innanzitutto volgersi verso se stesso, comprendersi e insieme appropriarsi della propria natura. Questo è quanto gli Stoici definiscono oikèiosis, ovvero diventare un essere che appartiene a se stesso (oikèion) e che proprio per questo è a casa, è casa a se stesso (oikos). Nella “casa” dello stoico governa la ragione, che sa che cosa è male, ovvero ciò che porta a diminuzione dell’essere, e ciò che è bene, la virtù che conserva e incrementa la vita del logos stesso. Tutto ciò che riguarda il corpo e la vita biologica, invece, non è né bene né male, è indifferente. Tra gli indifferenti, la coloritura del dovere o, meglio, di ciò che è “conveniente”, che per i latini sarà l’officium, rende virtuose azioni che non lo sono in assoluto e viceversa, costituendo una sorta di categoria intermedia. Come dunque si deve destreggiare l’uomo per essere saggio, raggiungere così la pienezza della vita e della felicità? Siamo qui forse all’apoteosi di quell’intellettualismo etico di cui tanto si discute a proposito della filosofia classica. Il saggio, per il fatto stesso di essere tale non ha bisogno di leggi, la sua stessa disposizione interiore non potrà che spingerlo a compiere azioni virtuose. Precetti e doveri sono per la massa, il sapiente lo sa, e anche quando il suo agire sembra andare contro la legge, in quanto compiuto dal sapiente è certamente virtuoso. Tra le prime accortezze del sapiente troviamo quella di evitare in maniera assoluta ogni passione, che può essere fonte solo di errore e infelicità. Sia che la si intenda come un movimento dell’anima irrazionale e contrario alla natura (così Zenone), sia che con Crisippo la si consideri un giudizio errato della ragione, ogni forma di passione deve essere estirpata, in vista dell’impassibilità che sola appartiene al sapiente, tanto autarchico quanto solo, ai limiti della crudeltà: “La misericordia fa parte dei difetti e vizi dell’anima: misericordioso è l’uomo stolto e leggero. Il sapiente non si commuove a favore di chicchessia; non condona a nessuno una colpa commessa. Non è da uomo forte lasciarsi vincere dalle preghiere e distogliere dalla giusta severità”. E proprio per conoscere bene il nemico da affrontare, dopo le distinzioni di Aristotele, sono gli Stoici a creare una tassonomia dettagliata delle passioni e una raffinata analisi degli stati passionali, destinata a venire utilizzata fino in età moderna, in cui il fenomeno psichico viene accompagnato da una descrizione fisiologica – basata sulle variazioni di temperatura dei fluidi corporei – che a sua volta riprende la dottrina di Ippocrate.
4. guarirle
Per quanto ne sappiamo, fu Ippocrate (V sec. a.C.) il primo medico a cercare le cause delle malattie in circostanze esterne o interne al corpo del paziente e non in interventi magici o soprannaturali. Nella sua scuola si compilavano le prime cartelle cliniche, si praticava l’eziologia, si studiavano tutti gli elementi della vita del malato, con una completezza di vedute certamente dimenticata dalla iperspecialistica medicina dei giorni nostri. Ma la dottrina che influenzò per secoli ogni approccio alla malattia fu proprio quella degli “umori”: come l’universo intero è frutto della composizione dei quattro elementi, così in ogni singolo essere umano si mescolano aria, acqua, terra e fuoco nelle forme di sangue, flemma, bile nera e bile gialla. L’eccesso o la carenza di uno dei quattro elementi porterebbe alla malattia, proprio come la siccità o un’inondazione sono disgrazie per il mondo in cui viviamo. Il sangue o umore rosso corrisponde all’aria e ha sede nel cuore: il tipo sanguigno, con eccesso di sangue, è rubicondo, gioviale, allegro, sensuale. L’acqua è nel flemma o flegma che si trova nella testa, e infatti il flemmatico è razionale, sereno, un po’ pigro. La terra corrisponde alla bile nera o atrabile, nella milza, e l’eccesso di bile nera è all’origine della malinconia che quando diventa patologica (oggi parleremmo di depressione) porta a tristezza, debolezza, fastidio per le gioie della vita. Tutt’altro atteggiamento ha invece il collerico, ovvero colui che ha il fuoco dentro di sé, il prevalere della bile gialla o “collera” che ha sede nel fegato. La teoria degli umori arriva anche a trovare corrispondenza tra elementi (e loro caratteristiche: caldo, freddo, secco, umido), caratteri e stagioni della vita (infanzia, giovinezza, maturità, vecchiaia) e le quattro stagioni dell’anno solare.
Chi è malato d’amore è affetto da squilibri di umore rosso e bile nera; alterna infatti momenti di entusiasmo, anche sessuale, a grandi tristezze. Per illustrare le devastanti conseguenze di questa passione, gli Stoici (tra questi Crisippo) citano esempi tratti da due figure tragiche: Medea e Fedra.
5. Mal d’amore
In particolare nel personaggio di Fedra, descritto da Euripide nell’Ippolito, troviamo la passione d’amore rappresentata come una situazione drammatica in cui i deboli sono coinvolti indipendentemente dalla loro volontà, e chi più debole di una donna? La moglie di Teseo è lo strumento della vendetta di Afrodite, offesa dalla mancanza di attenzioni da parte di Ippolito (figlio di Teseo e della regina delle Amazzoni), che ha sacrifici e preghiere solo per la rivale Artemide, vergine dea della caccia: “dice che la pessima tra le demoni io sono per natura”, “disprezza i letti e non tocca le nozze”, questi i lamenti di Afrodite (vv. 10-16). La dea fa sì che Fedra sia “presa da un amore terribile” per il giovane figliastro e la misera giace logorata sul letto, si vela il capo, invoca la morte, perché subisce una passione di cui si vergogna nei momenti in cui il logos riesce a prevalere: “Nascondimi: dagli occhi una lacrima, a me, discende / e, per la vergogna, lo sguardo è stravolto. / Il raddrizzarsi infatti, nell’intelletto, addolora, / e l’essere impazzita è male, ma prevale, / per chi non conosce, il morire” (vv. 243-249). La dea ...