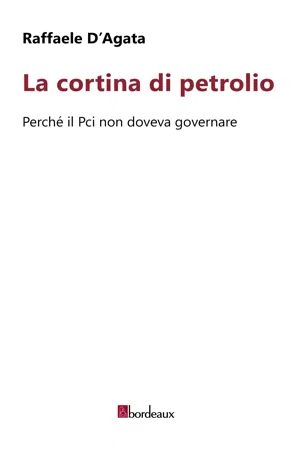
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Gli anni Settanta del Novecento sono stati lo spartiacque fra una situazione di possibile compimento della democrazia oltre i limiti posti dal sistema sociale e il suo ridimensionamento, di fatto avvenuto e tuttora in atto. Le alternative di sistema erano da un lato una rivitalizzazione e un'estensione qualificata degli aspetti finanziari ed economico-sociali del keynesismo e del newdealismo al di là della loro crisi, e dall'altro una nuova forma del plurisecolare complice intreccio tra politiche di potenza e autonomia sovrana dei mercati finanziari.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La cortina di petrolio di Raffaele D'Agata in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a History e Italian History. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
HistoryCategoria
Italian History1. La sinistra e l’ideologia euroatlantica, ieri e oggi
Politica e geopolitica
Secondo un pregiudizio diffuso, l’accettazione dell’Alleanza atlantica enunciata da Berlinguer nell’imminenza delle elezioni politiche italiane del 1976 avrebbe rappresentato il primo di una lunga serie di passi che, in sostanziale continuità, avrebbero portato alle concezioni infine enunciate e praticate dalle successive formazioni politiche (Pds, Ds, e infine Pd) che sono state convenzionalmente riconosciute come eredi del Partito comunista italiano dopo il suo scioglimento, avendolo generalmente anche dichiarato da parte propria (ma sempre meno spesso, e con crescente beneficio d’inventario). Troppi sono invece gli elementi che rendono impossibile e decisamente falsa una tale ricostruzione. Troppi cioè i fatti e le situazioni che caratterizzavano quel tempo come profondamente diverso da quello presente, e davano senso alle relative mosse politiche.
E, naturalmente, ciò riguarda anche la Nato, che a quel tempo era uno degli elementi costitutivi di una configurazione del sistema internazionale completamente diversa da quella presente, e anche per questa ragione presentava più di un aspetto significativamente diverso rispetto a ciò che oggi porta ancora lo stesso nome. Essendo cioè anche allora, tra l’altro, ricettacolo di energie oscure (o piuttosto, semplicemente, nere) intente a porre limiti alle possibili scelte di alcuni popoli, le mancava comunque (per cause oggettive), la spinta direttamente e sfrenatamente aggressiva che ha manifestato in questo secolo. Oggettivamente, cioè, l’equilibrio generale di cui la Nato di allora costituiva un elemento non concedeva abbastanza spazio per lo sviluppo di impulsi e di comportamenti di tale genere.
Anzi, per le medesime cause, e senza per questo cessare di esercitare le pesanti e oscure forme di interferenza nella vita interna di paesi come l’Italia che rispondevano comunque agli interessi della sua potenza dominante, nel secolo scorso la Nato finì presto per trovarsi a svolgere un ruolo non del tutto proprio come fattore di stabilità, ossia di contenimento ed effettivo raffreddamento di potenziali fattori di crisi bellica: tanto è vero che, rispetto ad altre più rischiose possibilità presenti nel contesto internazionale dei primi anni Cinquanta, essa finì per apparire infine preferita (di fatto) dagli stessi dirigenti sovietici. Non a caso infatti (come raramente si ricorda), nel 1954 Mosca si spinse a fare un passo per entrare a farne parte con evidente riferimento all’ancora fluida definizione dell’equilibrio europeo ruotante intorno all’irrisolta questione tedesca (suscitando comunque soltanto imbarazzate reazioni di rifiuto).
Un anno più tardi, l’effettiva stabilizzazione dell’equilibrio europeo ebbe luogo con la simmetrica formazione del Patto di Varsavia, includente la Germania orientale, mentre la Germania Occidentale entrava a sua volta a fare parte della Nato malgrado la ferma opposizione del partito socialdemocratico, che per qualche tempo restò per questo tacitamente marchiato da una presunzione di “inadeguatezza a governare” non formalizzata ma efficace. Poiché infatti l’indizione di elezioni pantedesche e la conseguente riunificazione erano risultate impossibili proprio a causa del rifiuto occidentale di applicare all’intera Germania lo statuto di neutralità permanente che pure avrebbe poi tempestivamente permesso di porre fine alla quasi analoga divisione in zone di occupazione dell’Austria (dove peraltro la minore rilevanza geopolitica e strategica non aveva già in precedenza impedito la formazione di un governo centrale), l’iniziale rigetto della Nato portò i socialdemocratici nella Repubblica di Bonn a trovarsi per qualche anno in una posizione alquanto simile a quella in cui i loro padri e nonni si erano trovati immediatamente dopo la formazione del Reich bismarckiano come partito “antinazionale”. Ma questa situazione durò poco.
Equilibrio e movimento
Come eludere i limiti alla libertà di scelta derivanti da ferrei vincoli di politica estera, più o meno interiorizzati? Nella seconda metà degli anni Cinquanta, la tragedia dell’Ungheria fu anche una manifestazione di questo problema, e proprio in un paese che, pur appartenendo volente o nolente al blocco politico-militare opposto, aveva qualcosa in comune con la Germania, vale a dire la situazione di paese sconfitto anziché liberato e una storia anche molto recente di irrequietezza irredentista e di successivo espansionismo che conservava vive, per quanto compresse e silenziose, riserve di carattere territoriale. Mentre però in Ungheria un primo tentativo di forzare le limitazioni interne comportate dall’equilibrio europeo – qui, certamente, ben più pesanti – fu compromesso dalla scelta di mettere immediatamente in questione questo equilibrio medesimo, in Germania la socialdemocrazia si avviò presto a scommettere sulla stabilità geopolitica come doppia garanzia (tanto verso Ovest quanto verso Est) nel perseguire profondi cambiamenti su altri più sostanziali e più importanti terreni; e, in funzione di questo, scelse infine di accettare la Nato.
Non essendo ancora inequivocabilmente enunciata nelle stesse risoluzioni del congresso di Bad Godesberg del 1959, questa scelta fu resa esplicita nel giugno del 1960 proprio da un ex-comunista come Herbert Wehner in un celebre discorso parlamentare, mentre la maggioranza di centro-destra continuava da parte propria a coltivare un revisionismo territoriale che presupponeva in linea di principio la legittimità delle frontiere del 1937 (quando non del 1938) e nutriva del resto una sorda diffidenza perfino nei confronti di Washington. A Bonn si dovette attendere che tali ostinate riserve portassero a un evidente vicolo cieco prima che la necessità di ridefinire il consenso nazionale di fondo attraverso un governo di Grande Coalizione fosse abbastanza ampiamente riconosciuta, così da riportare la sinistra, nel 1966, là donde le forzate dimissioni del governo Müller la avevano tratta via trentasette anni prima (insieme con una quantità crescente e terribile di cose essenziali). E in tale quadro, essendo stati rimossi alcuni preconcetti, ma non certo tutti i dissensi né specialmente tutti gli equivoci, un socialista sarebbe salito a guidare un governo di più ristretta coalizione dopo elezioni anticipate provocate a questo fine. Non si trattò di un piccolo mutamento, nel clima psicologico di quella prima fase di storia della Repubblica di Bonn, e tanto meno poiché il genere di socialista di cui si trattava (cioè Willy Brandt) era quello di un antifascista che aveva lottato anche vestendo una divisa norvegese durante la Seconda guerra mondiale.
Il passaggio attraverso la Grande Coalizione aveva certamente contribuito a raffreddare le passioni e a togliere al mutamento tutta la drammaticità che non fosse inevitabile. Ma altrettanto, appunto, poteva dirsi della svolta di politica estera costituita dalla rinuncia alla pregiudiziale neutralista. La stabilità dell’equilibrio tra i blocchi politico-militari era chiamata cioè a svolgere una funzione di raffreddamento delle tensioni geopolitiche, e questa a sua volta era concepita come base e presupposto di progressivi allentamenti dei vincoli esistenti in Europa rispetto alle scelte di ordine sociale e culturale (in particolare proprio nei rapporti tra le due Germanie) che apparivano, ed erano, strettamente associati con queste tensioni.
Ora, per quanto l’opposizione del Pci nei confronti della Nato si nutrisse di sentimenti molto meno equidistanti, e per quanta eco di argomenti polemici propri della retorica sovietica fosse presente nella sua propaganda fino agli anni Settanta, tale opposizione restava comunque (tecnicamente e formalmente) neutralista: dopotutto, cioè, l’adesione al Patto di Varsavia non fece mai parte di alcun suo programma politico o elettorale. Pertanto, la sua possibilità di diventare elemento di una coalizione di governo era resa impervia, in gran parte, nello stesso modo in cui l’analoga possibilità era restata preclusa alla Spd fino al 1960.
La difficoltà di “tradurre in italiano” lo schema di politica estera seguito dalla Spd dopo il 1960 (che, bisogna forse precisare, non dipendeva strettamente dal molto riduttivo schema di politica economica e sociale interna adottato un anno prima a Bad Godesberg) era certo notevole. Da “Gladio” alla “Rosa dei venti” e oltre, il sottobosco di connivenze tra atlantismo sommerso ed eversione nera era fin troppo noto e sperimentato, ed era certo più corposo e temibile di quanto analogamente in Germania il “passato che non passava” si insinuasse tra le pieghe del medesimo fenomeno. Era di questo, tuttavia, che sostanzialmente si trattava, e la commossa popolarità conquistata da Brandt all’inizio degli anni Settanta come strettamente associata all’idea di pace, unita ai contatti riservati ma intensi tra Spd e Pci che erano in corso, suggerivano che lo schema meritasse di essere seguito. Perché mai veti e ammonimenti americani avrebbero dovuto cioè ostacolare novità perseguite e attuate in Italia sul terreno politico interno, sociale e culturale, se l’equilibrio delle forze in Europa non fosse messo in discussione da modificazioni nella composizione dei sistemi d’alleanza? Se c’era ingenuità in questo, era ingenuità voluta (ossia sottile provocazione), confortata (come si è osservato) da alcuni elementi.
Destino ed euforia
Gli avvenimenti extraeuropei, e specificamente mediorientali, dall’autunno del 1973 in poi, avrebbero comunque dato la risposta, spazzando via il clima incerto ma complessivamente favorevole che aveva permesso fino ad allora lo sviluppo e l’enunciazione di linee d’azione fortemente innovative sulla base della nuova situazione politica nella Repubblica di Bonn. Fino ad allora, appunto. Perché dopo quegli eventi una brusca frenata fu imposta e attuata con fermissima determinazione attraverso l’Oceano, accompagnata dall’enunciazione di limiti alle scelte di politica estera che non avrebbe potuto essere più chiara e priva di tatto. Sicché, da allora in avanti, il destino del tentativo di Berlinguer si può anche riconoscere oggi come segnato.
Ciò non comporta che alcuni effettivi sviluppi non specificamente predestinati e alcune scelte non dettate da alcunché, derivanti tanto dai comportamenti di altri soggetti quanto soprattutto provenienti dall’interno del Pci, siano stati ininfluenti nel determinare il ritmo e la qualità della sconfitta, ossia la sua manifestazione sotto forma di totale e disordinata disfatta. In una certa relazione con l’entusiasta ed efficace adeguamento interno alla frenata esterna (recante il nome di Helmut Schmidt) che ebbe luogo in Germania Occidentale a partire dal 1974, e con la connessa accentuazione di dogmi conservatori ancora prevalenti in campo monetario e finanziario a Bonn mentre Brandt governava, la Grande Coalizione italiana si realizzerà infine non soltanto nella forma parziale di una poveramente compensata tolleranza comunista verso governi conservatori, ma soprattutto nella sostanziale condivisione della logica puramente e classicamente emergenziale propria del conservatorismo (nella dichiarata, più o meno credibile, e comunque ancora più classica, attesa di tempi migliori). In tale quadro, reazioni di sottile scetticismo, cui gran parte della cultura non si sottrasse, circonderanno Berlinguer nella sua intuizione della possibilità e della necessità di articolare e qualificare l’esigenza dell’“austerità” così da renderla effettiva e immediata occasione di profondi cambiamenti, onde dare luogo piuttosto a una disincantata promozione (sempre, ovviamente, enunciata come obbligata e provvisoria) della classica accezione del termine e del suo contenuto.
Ne conseguirà, naturalmente, un forte indebolimento del protagonismo popolare come fattore di resistenza alla restaurazione ormai avviata, e piuttosto lo sviluppo di forme di protagonismo popolare, minoritarie ma non irrilevanti, che avranno ormai (non inspiegabilmente) lo stesso Pci come obiettivo. I modi sottili ed efficaci in cui la vocazione reazionaria del nesso atlantico, sempre più determinante durante l’evoluzione della crisi globale aperta in quel decennio, sapranno fare leva su ciò, sono noti. Ciò senza necessità di negare alcuna delle molte ed eterogenee verità che costituiscono la complessa sostanza dei processi che culminarono nell’assassinio di Aldo Moro.
Un’ipotesi controfattuale che forse merita attenzione, comunque, è se tale cospirante lato esterno di quella tragica e decisiva vicenda sarebbe stato presente (e, in subordine, se in sua assenza proprio tutto sarebbe accaduto precisamente e puntualmente come accadde) qualora l’allineamento del Pci sulle nuove posizioni tedesche e comunitarie fosse stato veramente completo. In effetti, l’indivisibilità dei processi di distensione ancora proseguiti malgrado tutto fino all’adozione dell’Atto finale di Helsinki nel 1975, e specificamente la loro estensione al Mediterraneo e al Medio Oriente, restava un cardine della politica estera enunciata e proposta dal Pci, essendo del resto condivisa dalla sinistra cattolica e dallo stesso Moro.
A parte questo aspetto, comunque, il processo di lenta metamorfosi del Pci destinato a concludersi con la sua scomparsa può essere fatto risalire ad allora, anche se Berlinguer dovrebbe esserne visto piuttosto come tragico testimone che come protagonista. La sua guida, tra il 1976 e la sua morte nel 1984, si manifesterà divisa tra convinzioni mantenute e responsabilità riconosciute nei confronti di un partito grande e radicato nel paese, la cui unità sembrava richiedere massima cura.
Gli epigoni di Berlinguer si illusero forse di cavalcare la tigre mentre il sistema euroatlantico si consolidava come “vincitore” nella guerra fredda, nell’ipotesi più aperta a comprendere. Comunque, la sola cosa che certamente né i pochi dichiarati epigoni restati attivi entro una dichiarata “sinistra” sempre meno riconoscibile, né soprattutto la generazione dei post-epigoni, possono fare, è professare entusiasmo euroatlantico oggi affermando di “proseguire” Berlinguer. La Nato resta nel mondo di oggi, dopo la ...
Indice dei contenuti
- Questo libro
- 1. La sinistra e l’ideologia euroatlantica, ieri e oggi
- 2. Perché un “compromesso storico”?
- 3. La nuova Realpolitik
- 4. Normalizzazione e proto-globalizzazione
- Epilogo