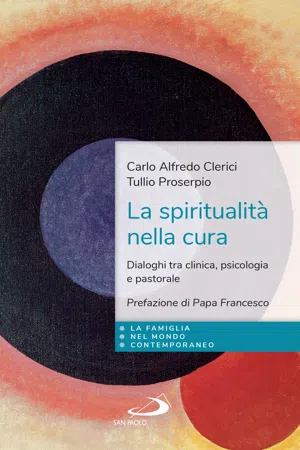
eBook - ePub
La spiritualità nella cura
Dialoghi tra clinica, psicologia e pastorale
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La spiritualità nella cura
Dialoghi tra clinica, psicologia e pastorale
Informazioni su questo libro
Tra un medico e un presbitero che si incontrano, ogni mattina, nei corridoi di uno dei più importanti ospedali d'Italia – l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – nasce un dialogo autentico, appassionato, lucido sul tema della spiritualità nella cura. Di che cosa ha bisogno l'ammalato che soffre e che intravede l'avvicinarsi dell'ultima soglia? Esiste la possibilità di un'alleanza tra medicina e spiritualità, in una realtà sanitaria sempre più tecnologica e standardizzata su grandi numeri ed efficienza delle prestazioni? Con un'analisi rigorosa dei sistemi ma anche dei bisogni profondi espressi dai pazienti e dalle famiglie, gli autori sottolineano che è possibile inaugurare nuovi percorsi di formazione, nuovi modelli di collaborazione e nuove routine nelle équipe sanitarie, in cui l'ascolto e la presa in carico della dimensione spirituale del paziente diventano un elemento capace di sostenere nei momenti più difficili e di offrire prospettive alla domanda di senso che accompagna ogni essere umano.
«Un tema certamente attuale e sempre più coinvolgente e che interpella e positivamente stimola quanti si riconoscono nella fede cristiana a porre quelle domande vere che abitano il cuore di ciascuno». Dalla Prefazione di Papa Francesco
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La spiritualità nella cura di Carlo Alfredo Clerici,Tullio Proserpio in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Psicologia e Teoria, pratica e riferimenti medici. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
A tutti coloro che, in povertà e sincerità di cuore,
accompagnano e condividono il percorso della fatica, della sofferenza,
delle domande vere.
PREFAZIONE
Con particolare gioia accolgo l’invito rivoltomi da don Tullio Proserpio e dal dott. Carlo Alfredo Clerici, entrambi impegnati nel servizio di aiuto e sostegno alle persone ammalate, così come i familiari e l’intero personale che opera all’interno dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
Un tema certamente attuale, sempre più coinvolgente e che interpella e positivamente stimola quanti si riconoscono nella fede cristiana a porre quelle domande vere che abitano il cuore di ciascuno. Sappiamo di non avere risposte pienamente persuasive davanti a questi grandi interrogativi, soprattutto vicino al letto dei pazienti stessi. Anche questa è una forma di povertà, ma proprio perché ci riconosciamo poveri, ci rivolgiamo alla parola sempre buona e promettente del Vangelo, capace di aprire il nostro cuore alla speranza, quella speranza grande che attraversa il cuore di chi percorre il cammino dell’esistenza.
Il titolo del libro: “La Spiritualità nella cura”, pone a tema un argomento particolarmente delicato e importante, quale la spiritualità nel momento della malattia. Il testo evidenzia un segnale certamente positivo di attenzione da parte della comunità scientifica che riconosce, per il bene dei pazienti, dei familiari, oltre che dello stesso personale, un aiuto come quello spirituale, che forse in questi ultimi anni è stato un po’ trascurato.
Come è opportunamente sottolineato, da parte di quanti sono o saranno coinvolti in questo settore così specifico, occorre un’adeguata preparazione e formazione sul campo, cioè concretamente vicino al letto delle persone ammalate, per essere in grado di muoversi in profonda sinergia con l’intera comunità curante.
La pandemia di Covid-19 ha sottolineato con forza la necessità di non lasciarsi trascinare da sole logiche economiche, incapaci di soddisfare pienamente i profondi bisogni dell’uomo. L’attenzione alla prospettiva spirituale aiuta a rispondere, in sintonia con le altre realtà coinvolte, a questa domanda.
Proprio lo sguardo dalla periferia della condizione umana, segnata dalla precarietà dell’esistenza, favorisce la costruzione di quei ponti necessari a non dimenticare l’umano che ci caratterizza e a individuare sempre nuovi, spesso imprevisti percorsi.
Auguro che questo proficuo dialogo tra l’ambito teologico-pastorale e clinico-psicologico possa proseguire con sempre maggiore efficacia, avendo la costante disponibilità ad affrontare aspetti tanto complessi. Lo Spirito Santo accompagni quanti condividono l’esperienza di aiuto e sostegno alle persone ammalate. Molto apprezzo la lodevole sensibilità posta nella cura dei malati considerati nella loro integralità di persone ad imago Dei. Possa tale saggio contribuire al promuovere una rinnovata attenzione in chi assiste le persone ammalate, in modo da far loro assaporare prossimità amorevole e conforto sull’esempio di Gesù buon samaritano dell’umanità.
Affido il buon esito del vostro servizio alla celeste intercessione di san Giuseppe e della Vergine Maria, Salute degli infermi, invio la Benedizione Apostolica, accompagnata dal ricordo nella preghiera per l’intera comunità dell’Istituto dei Tumori di Milano, in modo speciale per i ricoverati e i rispettivi familiari.
Roma, 23 settembre 2021
+ Francesco
INTRODUZIONE
La mattina presto, in ospedale, è un momento in cui la mente è sgombra e molte preoccupazioni sembrano distanti. Il distributore automatico del caffè è un luogo particolare. Si incontrano infermieri che iniziano il turno e quelli che stanno smontando, il personale della manutenzione e delle pulizie. Dal volto del medico di guardia si apprende, già da lontano e senza bisogno di tante parole, se la notte dell’ospedale è stata serena o travagliata. È qui che, accomunati dalla curiosità verso questo mondo e desiderosi di iniziare la giornata prendendo contatto con l’anima dei luoghi, sono avvenuti i nostri primi incontri.
Uno di noi è un religioso. Svolge la funzione di cappellano rettore in ospedale. Era stato incaricato di questo ruolo vent’anni fa, dal cardinale Martini, la cui eredità è ancora viva nell’ospedale e nella cultura della città. Il secondo di noi è un medico, specialista in psicologia clinica, docente universitario alla Statale di Milano. Ha avuto un’educazione cattolica in gioventù, ma si è poi progressivamente distanziato dalle prospettive religiose, non trovando nei riti e nelle parole alcun conforto agli interrogativi rispetto al senso della vita e di fronte al dolore delle persone malate che quotidianamente incontra.
Ci siamo incontrati da posizioni in apparenza tanto diverse, per poi scoprire che in realtà non erano così distanti, come avremo modo di raccontare in questo libro. Proprio al distributore del caffè è iniziato anni fa un dialogo fatto di parole, suggerimenti di letture, molti interrogativi, poche risposte e alcune speranze: il frutto di tutto questo lo trovate tra queste pagine.
Tullio Proserpio
Carlo Alfredo Clerici
1
CHI ERAVAMO E CHI SIAMO ORA
Aspetti storici dell’evoluzione della medicina e dei sistemi sanitari
Un certo giorno, uno di noi si è ritrovato tra le mani un vecchio volume dimenticato. Alcune pagine gli hanno suscitato una certa curiosità: erano dedicate alla preparazione all’Eucaristia in ospedale nei primi anni Sessanta. Ecco un piccolo passaggio:
Nei locali dove passerà il sacerdote e soprattutto nella stanza del malato, tutto deve essere pulito. Nella stanza l’infermiera deve aggiungere un corporale, un purificatoio e, se necessario, un libro o un manuale per le preghiere del rito. Devono essere inoltre preparate in sacrestia una cotta, una stola bianca, una candela accesa ed un campanello, col quale chi accompagna il sacerdote lungo i corridoi dell’ospedale debba segnalare con lo scampanellio il passaggio del sacerdote con l’ostia consacrata. Inoltre, ancora l’infermiera deve suggerire ai presenti brevi atti di fede, di umiltà, di dolore, di desiderio e specialmente di carità, ed infine badare che all’arrivo del sacerdote col Santissimo i presenti si mettano in ginocchio e, assieme al malato, assistano piamente alla comunione. L’infermiera, poi, ha un ulteriore dovere: nel caso incontri il sacerdote che porta la Comunione ai malati, riconoscibile per l’accompagnamento della candela e soprattutto dello scampanellio che lo preannunciava da lontano, deve fermarsi, inginocchiarsi per “adorare Nostro Signore”, e può rialzarsi solo dopo che il sacerdote si è allontanato.
Oggi ci troviamo a leggerlo insieme più volte, medico e sacerdote dell’ospedale, ragionando su quanto sembrino distanti queste raccomandazioni e queste stesse esperienze, descritte e certamente vissute in corsia soltanto pochi decenni fa, forse proprio negli anni in cui noi siamo nati. In passato la figura del cappellano ospedaliero, i suoi compiti e il suo ruolo erano codificati in modo preciso con una serie di norme da rispettare, come quelle riportate in questo manuale di medicina e morale che abbiamo citato (Paquin, 1962). Assistere all’ingresso in una stanza, per il rito dell’eucaristia, del cappellano che avanzava preceduto da una suora con una candela accesa in mano, nel silenzio generale dei presenti, era esperienza comune in ospedale fino agli anni Sessanta. Ora paiono passati secoli.
Va detto che il cappellano è ancora presente in molte strutture sanitarie del territorio nazionale, e la sua presenza e il suo ruolo sono previsti e disciplinati dai vari protocolli d’intesa tra Stato e Chiesa, ovvero stipulati dalle singole regioni con le rispettive Conferenze Episcopali regionali1.
Dalla nascita del servizio sanitario nazionale, nel 1978, si sono verificati grandi cambiamenti sociali e la realtà degli ospedali ha avuto varie trasformazioni. È necessario conoscere questi mutamenti della società e della medicina per comprendere le nuove esigenze dei malati e le possibilità di prestare assistenza spirituale in ospedale.
Per guardare avanti facciamo dunque un passo indietro, e proviamo a riassumere qui alcuni aspetti storici essenziali, per meglio inquadrare la questione.
Nell’età antica la medicina era una disciplina sospesa tra empirismo e filosofia, basata sul diretto contatto col paziente, dal quale si ascoltavano attentamente la descrizione dei sintomi e la storia della malattia, per poter formulare una diagnosi. Dato che si ritenevano corrispondenti sintomi e malattia, il contatto tra medico e paziente aveva un ruolo diagnostico fondamentale, prima ancora che relazionale e psicologico. In tale modo, si potrebbe dire che relazione e terapia coincidevano inscindibilmente.
In epoca cristiana la cura e l’assistenza erano legate alla carità, e l’ospedale è stato per molti secoli un luogo nel quale si accoglievano non solo i malati ma anche i bisognosi: i poveri, i pellegrini, i mendicanti, i disabili, le prostitute e infine, sì, anche chi aveva una malattia. I grandi ospedali, nel passato, nascevano ed erano organizzati con una funzione di accoglienza e di edificazione morale e spirituale: dunque gli aspetti relazionali di supporto e quelli spirituali, in qualche modo, facevano parte delle cure che si ricevevano quando si veniva ricoverati.
Teorie che rivoluzionano la medicina
L’evoluzione scientifica, avvicinandoci al nostro secolo, modifica questa visione della medicina e trasforma la diagnostica in un’operazione esclusivamente clinico-scientifica, più concentrata sicuramente sulla cura del corpo. La svolta più consistente si ha nella seconda metà dell’Ottocento, quando le intuizioni del medico Rudolf Virchow (1821-1902) fondano la patologia cellulare. Questa prospettiva identifica come elementi essenziali della malattia le alterazioni morfologiche e funzionali che si verificano a livello della cellula, portando un’inarrestabile evoluzione in senso scientifico della medicina, che assumerà una nuova identità in una cornice biologica e clinica.
La semeiotica, tradizionalmente basata sul contatto fisico diretto col paziente – ovvero la sua osservazione, le manovre di palpazione, auscultazione e percussione – può basarsi ora su nuovi elementi. Nell’indagine diagnostica i dati oggettivi diventano privilegiati rispetto ai sintomi soggettivi riferiti dal malato. La diagnosi del medico è poi sempre più fondata sui risultati degli esami microscopici e delle analisi chimico-fisiche praticate nei laboratori, di cui ben presto tutti gli ospedali si dotano.
Si assiste poi a un’importante dislocazione che da allora in poi contrassegnerà la gestione dei malati: il centro della cura è sempre meno la casa, e sempre di più l’ospedale. Nel contempo, mentre la medicina diventa “scienza della malattia”, l’esperienza personale del malato sulla sua malattia diventa un dato progressivamente svalutato, e che è persino possibile ignorare. Ai clinici interessano i dati obiettivi necessari alla diagnosi e non i vissuti e l’esperienza dei singoli. Si finisce per ascoltare i racconti del malato tutt’al più per buona educazione, ma la pratica della relazione non è più determinante nella metodologia di cura.
D’altra parte, la diagnosi medica fondata su elementi oggettivi, procedure e nuovi strumenti tecnici permette sempre maggiori successi delle terapie, con risultati straordinari di cura e guarigione per un gran numero di malattie, contribuendo ad aumentare decisamente la durata e la qualità della vita media. In parallelo, però, si assiste all’aumento della distanza tra medici e malati, una distanza che si fa sempre più significativa nel corso del Novecento, con lo sviluppo di tecniche diagnostiche e metodi di cura che prescindono dalla considerazione degli aspetti personali, della dimensione relazionale, in una parola dell’ascolto del malato.
L’allontanamento dell’attenzione della medicina dalla soggettività del paziente non è tuttavia completo, e durante il Novecento numerose voci segnalano una necessità di “umanizzazione” della clinica. Ricordiamo qui solo alcuni tra i molti autori che hanno offerto stimoli importanti alla medicina, per indirizzarla verso una rinnovata considerazione della soggettività del paziente. All’interno del movimento psicoanalitico lo psichiatra Michael Balint (1876-1970) svolge importanti esperienze sulla comunicazione e la relazione con il medico, figura che l’autore definisce come “la prima medicina” per il paziente (Balint, 1957). Da questa concezione nasce il metodo di formazione e di ricerca dei “gruppi Balint”, col proposito di offrire ai medici formazione e strumenti per comprendere le dinamiche coinvolte nella relazione di cura. Anche il filosofo e psichiatra tedesco Karl Jaspers (1883-1969) ha offerto contributi critici a proposito dell’allontanamento della medicina dal contatto con la soggettività del paziente.
Jaspers ha messo in luce una trasformazione della medicina che ha penalizzato la relazione con il malato, essenziale per la cura (Jaspers, 1986), e ha ricordato che la tecnica, mentre ha contribuito all’aumento delle guarigioni, ha però avuto il sopravvento sull’ascolto e sulla comprensione umana. Il pensiero di Jaspers offre spunti critici anche sulle discipline psicologiche, e in particolare la psicoanalisi, che avrebbero cercato di colmare il vuoto lasciato dalla medicina rispetto alla relazione con i pazienti. Nel tentativo di salvare l’essere umano dal finire ridotto a mero oggetto della cura, queste discipline si sarebbero però affermate in modo fideistico, come una specie di religione. Jaspers ha invece auspicato un recupero degli aspetti fondamentali dell’attività medica: da una parte la conoscenza scientifica e l’abilità tecnica, dall’altra parte il carattere umanitario. Ma, naturalmente, mentre gli aspetti tecnici possono essere insegnati e appresi, l’attenzione all’umano è una caratteristica personale da sviluppare nel corso dell’esercizio della professione.
I numeri orientano la conoscenza
Al termine della seconda guerra mondiale la medicina attraversa un’altra crisi. Il valore della medicina clinica è in parte oscurato dalla prospettiva della ricerca scientifica. La forza delle conoscenze fondate sulla ricerca prende rapidamente il sopravvento rispetto alla clinica, basata sull’esperienza individuale, per effetto anche del forte sviluppo dei metodi di ricerca empirica di provenienza anglosassone. In altre parole, si cambia scala. All’esperienza dei clinici si sostituisce l’obiettività dei “trial randomizzati controllati” (RCT), ovvero gli studi sperimentali basati sul confronto degli esiti di due o più trattamenti ai quali i soggetti sono sottoposti con un’assegnazione in base al caso (random, in inglese). La medicina inizia quindi a fondare le sue conoscenze sull’efficacia dei trattamenti, a partire dall’impiego della streptomicina nella tubercolosi polmonare (Hill, 1952), su un uso sempre più ampio dei trial randomizzati.
Su questa spinta si sviluppano protocolli di terapia sempre più s...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Quarta
- Autore
- Frontespizio
- Colophon
- Indice
- Prefazione di papa Francesco
- Introduzione