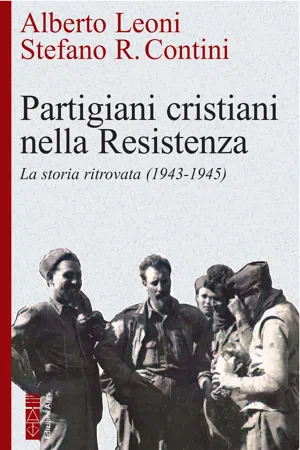
eBook - ePub
Partigiani cristiani nella Resistenza
La storia ritrovata (1943-1945)
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Stefano Contini e Alberto Leoni hanno riportato alla luce centoquarantacinque volti di resistenti disarmati e di partigiani combattenti, credenti in Cristo che, «ribelli per amore», si sono giocati la vita contrastando il nazifascismo. Ed essi, per quanto numerosi, sono solo una rappresentanza del mondo cattolico che rifiutò l'idea fascista di un cattolicesimo senza Cristo, rivendicando la bellezza di un cristianesimo «senza scorta armata», combattendo con giustizia, financo con misericordia verso il nemico, nemici delle ideologie e spesso assassinati dagli ex alleati partigiani. Un'opera importante che riporta alla luce la commovente, straordinaria testimonianza di questi martiri che, ancora oggi, solo che la si ascolti, ci insegnano con che cuore si possano affrontare sfide epocali quali sono quelle che ci aspettano.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Partigiani cristiani nella Resistenza di Alberto Leoni,Stefano Contini in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Seconda guerra mondiale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Seconda guerra mondialeCapitolo 1
L’alba della Resistenza:
da settembre a dicembre 1943
I CADUTI A ROMA, I MILITARI PARTIGIANI ALL’ESTERO
Erano le quattro di notte del 9 settembre 1943, l’armistizio era stato dichiarato da poche ore e le divisioni tedesche intorno alla città avevano iniziato a muoversi con rapidità e decisione per disarmare le forze italiane. Va ricordato che agire in tal modo era, per i tedeschi, un diritto incontestabile, esattamente come avevano fatto gli inglesi quando le loro corazzate avevano affondato o danneggiato parte della flotta francese a Mers-El-Kebir nell’estate del 1940 perché non cadesse in mano tedesca. D’altra parte, gli italiani avevano tutto il diritto e il dovere di resistere, esattamente come avevano fatto i francesi nel 1940 contro gli inglesi.
La Resistenza cominciò allora, da subito, e fu iniziata dai militari per obbedienza agli ordini. I morti nella battaglia di Roma furono centinaia: secondo una stima prudenziale, vi furono 171 morti fra i militari e 241 tra i civili: altri, in modo più realistico, elevano tale cifra a 414 militari e 156 civili.
Eppure, Ruggero Zangrandi, sia pure avvertendo dell’approssimazione delle proprie ricerche, parla di 1.000 militari e 500 civili1.
Tutto ciò dà solo un’idea di quel che significò quella battaglia, beninteso per chi vi prese parte: i generali che si arresero o fuggirono hanno sempre avuto altre storie da raccontare, cercando di far dimenticare coloro che combatterono e morirono in quei due giorni di lotta, come Ettore Rosso, sottotenente del genio, facente parte della divisione «Ariete». La sera dell’8 settembre, il giovane ufficiale era stato incaricato di minare la strada nei pressi di Monterosi a Nordest del lago di Bracciano. Una colonna corazzata tedesca cercò di passare, ma Rosso piazzò di traverso i camion carichi di ordigni. Iniziarono le trattative, Ettore non cedette e il comandante tedesco diede quindici minuti di tempo per sgombrare il passaggio. Rosso ne approfittò per completare lo sbarramento e far ripiegare i suoi uomini a eccezione di quattro volontari: Pietro Colombo, Gino Obici, Gelindo Trombini e Augusto Zaccani. Quando iniziò lo scontro a fuoco, Ettore Rosso si accorse di non avere alcuna speranza di resistere: così, quando ormai i tedeschi gli erano addosso, in un gesto che oggi può apparire inconcepibile ed è ignorato dagli italiani, si lanciò su una mina con tutto il peso del proprio corpo e la fece esplodere, provocando la deflagrazione di tutto il convoglio e polverizzando anche la testa della colonna tedesca.
Questi erano gli italiani che secondo la vulgata anti-resistenziale «salirono sul carro del vincitore». E il punto è che non furono gli unici. Fra i tanti caduti tra settembre e ottobre del 1943 (circa 22.000), ne abbiamo scelti due: il tenente Raffaele Persichetti e il capitano Luigi Viviani.
Raffaele Persichetti: l’eroe in giacca e cravatta
Se c’è una figura rappresentativa della difesa di Roma è quella del tenente Raffaele Persichetti, romano di ventotto anni.

Raffaele Persichetti
La sua famiglia aveva fortissime tradizioni cattoliche e il padre, medico chirurgo, pluridecorato nella Grande guerra, era sempre stato oppositore del fascismo, subendo minacce e persecuzioni. Non diversamente dal padre, Raffaele osteggiava il regime e nel 1932, a diciassette anni, scriveva a proposito di una grande adunata di intellettuali: «Buffoni! Per dieci anni hanno mantenuto la stessa ipocrisia. E per die-ci anni un popolo intiero di stomachi vili ha detto di sì e sì e sì. Miserabile vita! A poco a poco rimango solo. Ma finirà male. Finirà che un giorno o l’altro mi ribello agli uomini e alla vita. Mio Dio perdonami! Fa’ che io non mi ribelli mai alla Tua legge».
Raffaele si laureò in Lettere e filosofia alla Sapienza col massimo dei voti nel 1937 e partecipò alle attività della Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci), ma nel 1939 svolse il servizio di leva e divenne sottotenente dei granatieri di Sardegna. Dalle sue note caratteristiche emerge la figura di un giovane eccezionalmente dotato:
Ha vasta, eclettica, elevata cultura che gli permette di spaziare in ogni campo; conosce, tra l’altro, ottimamente il francese, il tedesco e lo spagnolo. Tale cultura, unita alle elette doti morali, fanno guardare a lui con ammirazione. Il carattere adaman-tino, la forza d’animo, lo spirito di sacrificio che non lo farebbe arrestare di fronte a nessun ostacolo, le elette doti intellettuali fanno di lui un Ufficiale veramente distinto. Egli ha veramente le doti del trascinatore. Lo giudico un ottimo Sottotenente di complemento.
Specializzatosi in storia dell’arte, insegnò negli istituti Visconti e De Merode pubblicando saggi e articoli. Questa tensione intellettuale non fece venir meno l’impegno politico e lo portò a prendere una posizione sempre più decisa nei confronti del regime. Nel maggio 1940 non permise ai suoi studenti di partecipare a un’adunata fascista durante le sue ore di docenza. Immediata la spedizione punitiva di graduati della milizia che entrarono nel liceo e aggredirono i docenti che non avevano fatto uscire i ragazzi. Anche il professore di religione, padre Antonio Giorgi, fu minacciato e questo scatenò la reazione di Persichetti, che buttò fuori dalla scuola i facinorosi. Il prezzo di tale atto fu una bastonata che lo lasciò tramortito.
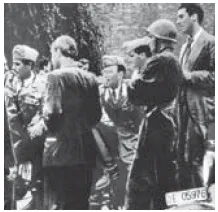
In borghese con i granatieri
Nonostante ciò, Persichetti fece comunque il proprio dove-re di soldato quando fu richiamato alle armi, combattendo sul fronte greco, dove venne ferito così gravemente da rimanere invalido e collocato in conge-do assoluto. Ciò gli permise di tornare all’insegnamento e, nel 1943, di prendere parte all’attività politica del Partito d’azione. La mattina del 9 settembre uscì di casa e si recò alla caserma del suo vecchio reggimento riorganizzando gli sbandati e portandoli in combattimento.
C’è una foto di quel giorno che lo ritrae in giacchetta ac-canto ai granatieri: un combattente improbabile, ma colmo di uno spirito che, oggi, è più raro di un diamante. Lui è là sulla destra, alto, prestante e con un cuore impavido. Indossò le giberne e a mezzogiorno cominciò a sparare e a dirigere il fuoco dei suoi uomini nei pressi della piramide di Caio Cestio. In una pausa dei combattimenti riuscì a telefonare alla madre da un bar, rassicurandola e mettendo una mano sul microfono per non farle sentire il fracasso della sparatoria. Ma la madre udì comunque gli spari e attese invano il figlio. La mattina del 13 la sua salma venne identificata. Era stato colpito alla testa e gli era stata risparmiata la vergogna della resa ai tedeschi, trattata da Giacomo Carboni e, per necessità, dall’anziano maresciallo Enrico Caviglia, che in un qualche modo era stato chiamato a rappresentare il re2.
Luigi Viviani: da «Avanguardia cattolica» alla Resistenza
La biografia di Luigi Viviani descrive compiutamente un cattolicesimo che non si era fatto irretire dal fascismo e che era stato ben deciso a lottare su ogni fronte, senza compromessi.
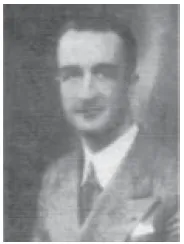
Luigi Viviani
Nato a Crema nel 1903 da famiglia benestante, si laureò in Ingegneria al Politecnico di Milano il 30 dicembre 1926. Fin dall’adolescenza Luigi aveva fatto parte di quella formazione, oggi dimenticata dalla nostra tradizione religiosa, che era l’«Avanguardia cattolica» sulla quale è necessario compiere un breve approfondimento.
Nessuno oggi ricorda più che all’inizio del XX secolo i cattolici erano ormai avvezzi a subire aggressioni fisiche durante congressi o manifestazioni religiose, da parte di liberali, democratici e poi dagli stessi socialisti. La reazione del cardinale arcivescovo di Milano, Andrea Carlo Ferrari, era stata quella di promuovere nel 1906 l’Unione giovani cattolici milanesi e, nel 1919, l’Avanguardia cattolica, a vente come obiettivo la difesa fisica delle manifestazioni e delle istituzioni cattoliche, religiose come sociali. Secondo il cardinal Ferrari i cattolici, oppressi dalla paura, non osavano più professare pubblicamente la propria fede, perdevano mordente e andavano limitando l’attività all’interno delle sedi e degli oratori. Nel biennio rosso 1919-1920 le forze dell’ordine non proteggevano i cattolici. Gli avanguardisti cattolici erano scelti fra i migliori, più spiritualmente preparati, battaglieri e dotati di una certa prestanza fisica. Dovettero resistere anche a opposizioni interne alla Chiesa che vedevano nella pura non violenza l’unica risposta alla persecuzione, ma costituirono reparti con nomi che riecheggiavano la storia della Chiesa e dell’Italia come «Carroccio», «Pontida», «Alberto da Giussano», «Lepanto» con il motto «Cristo o morte».
Grazie alla loro azione, e al sostegno delle animose ragazze della Gioventù femminile cattolica, le processioni religiose poterono tornare a essere svolte all’aperto, sfidando sia le aggressioni, anche omicide, dei socialisti, sia quelle dei fascisti. Le regole d’ingaggio dello scontro fisico furono enunciate nella seguente massima: «Non percuotere se basta trattenere la mano che vuol colpire; non ferire se è sufficiente percuotere; non uccidere se è sufficiente ferire». Regole che permettevano di abbassare la violenza di quel periodo e che le ideologie del tempo non hanno mai preso in considerazione. Si prenda per esempio il motto dei Requetés, la milizia cattolica e tradizionalista che combatté contro i repubblicani nella guerra civile spagnola (1936-1939): «¡Requetés! ¡Al insulto contestad con la bofetada; a la bofetada con el palo; al palo con el tiro!» («All’insulto rispondi con lo schiaffo; allo schiaffo con il bastone; al bastone con una pallottola!»).
Luigi Viviani a diciassette anni prese parte ai primi scontri coi socialisti e si prese le prime bastonate meritando riconoscimenti per il valore dimostrato. Vennero poi le aggressioni fasciste e il suo giudizio, nel maggio del 1922, fu ben chiaro in un articolo scritto per l’Azione cattolica:
Di nuovo in ogni parte d’Italia, come tre anni fa, è uno scoppio di violenza anticlericale, feroce e sacrilega. Ma non è più come nel 1919 e nel 1920, la violenza disordinata, incomposta, improvvisa della plebaglia socialista, infatuata di idee rivoluzionarie. Oggi è un piano d’attacco premeditato, un’offensiva preparata con tutte le regole della tattica [...]. Come due anni fa sapemmo vincere la violenza rossa, oggi vinceremo la violenza fascista. Sapremo imporre al fascismo prepotente il rispetto delle cose sacre, dei nostri ideali, della nostra Fede».
Il vigore, il coraggio, l’intelligenza di Luigi lo portarono ad assumere prima la carica di presidente della Gioventù cattolica di Crema, nel dicembre del 1923, di tutta la Federazione giovanile diocesana e, nel 1926, di tutta la giunta diocesana di Ac, a soli ventidue anni.
Esporsi in questo modo poteva costar caro e Luigi lo sapeva bene. Proprio perché temeva per la propria vita, scrisse un testamento spirituale rivolto ai genitori. Non temeva di morire, se non per il dolore che avrebbe causato, ma era ben deciso ad accettare la volontà di Dio, dicendosi felice di sacrificare la propria giovinezza. Riuscì a trascorrere indenne quel periodo, dopo di che iniziò la sua vita professionale e, per il servizio di leva, militare, diventando sottotenente di complemento al 7° Centro contraerei. Il suo impegno con l’Azione cattolica non diminuì e lo vide in prima linea nell’opposizione al regime, tanto che subì un provvedimento di diffida per non aver impedito una manifestazione inneggiante al vescovo e al papa.
Nel 1935 sposò Jolanda Barbaglio, una giovane dirigente diocesana, poi qualche anno dopo giunse la guerra e con essa la destinazione come capitano al comando di una batteria contraerea nell’isola di Rodi. Il 9 settembre 1943 la guerra arrivò anche in quel settore così tranquillo e fu una lotta all’ultimo sangue. Dal 9 all’11 settembre 1943 la sua batteria lottò aspramente, infliggendo dure perdite al nemico fino alla resa finale. In una delle ultime lettere alla moglie così descrisse quei giorni:
Ho passato ore in cui, solo, isolato, ho dovuto decidere della sorte dei miei uomini. Essi però mi hanno seguito tutti quando la decisione è stata presa. Si sono battuti da leoni e così sono stati chiamati da un colonnello. Ora siamo in condizione di prigionieri e attendiamo di ora in ora la decisione della nostra sorte».
Portato ad Atene, venne fucilato senza processo il 29 settembre del 19433.
GLI INTERNATI MILITARI ITALIANI
In Italia è sempre esistita una considerazione negativa su coloro che cadevano prigionieri, come se su di loro gravasse una presunzione di viltà. E così fu anche per un milione di soldati italiani che furono fatti prigionieri all’indomani dell’8 settembre. In Storia della Resistenza4 questa cifra risulta dalla somma dei seguenti dati: 500.000 catturati in Italia, 60.000 in Francia, 430.000 in Grecia e nei Balcani. Di essi solo 190.000 decisero di continuare a combattere con la Germania. Le privazioni cui furono sottoposti per piegare la loro resistenza furono spaventose e il tasso di mortalità altissimo. Un prigioniero ha, se si vuole, il diritto di parlare a no-me di tutti: il cattolico, battagliero Giovannino Guareschi che nel suo Diario clandestino così descrive quella terribile prova:
Non abbiamo vissuto come i bruti. Non ci siamo rinchiusi nel nostro egoismo. La fame, la sporcizia, il freddo, le malattie, la disperata nostalgia delle nostre mamme e dei nostri figli, il cupo dolore per l’infelicità della nostra terra non ci hanno sconfitti. [...] Ci stivarono in carri bestiame e ci scaricarono, dopo averci depredati di tutto, fra i pidocchi e le cimici di lugubri campi, vicino a ognuno dei quali marcivano, nel gelo delle fosse comuni, diecine di migliaia di altri uomini che, prima di noi erano stati gettati dalla guerra tra quel filo spinato5.
A questi crudi maltrattamenti i tedeschi alternavano iniziative di bassa propaganda che non sfuggivano all’umorismo di Guareschi. Nel suo diario ricorda un colonnello germanico in visita alla loro baracca che, saputo del trattamento cui erano sottoposti gli italiani, in tutto simile a quello dei polacchi esclamò: «I polacchi sono polacchi! Questi sono ufficiali italiani!». In breve, si viene a sapere che la stessa battuta veniva recitata in ogni baracca. Il commento di Guareschi fu fulminante: «Quando fanno della propaganda i tedeschi sono di una stupidità commovente»6.
Francesco Besso: martire della satira
Guareschi non era il solo umorista prigioniero dei nazisti. Francesco Besso, di Vignale Monferrato, era nato nel 1921 ed era disegnatore, avendo frequentato l’Accademia di Brera a Milano. Aspirante maggiore di Azione cattolica a Vignale, fu inviato a Samos dove venne fatto prigioniero nel settembre 1943 e detenuto con altri italiani sull’isola di Rodi. La Resistenza al nazismo si faceva anche con le vignette umoristiche e Besso produsse una decina di quaderni satirici che risollevarono il morale dei prigionieri. Era un leader che spingeva a non collaborare in a...
Indice dei contenuti
- Presentazione
- Capitolo 1: L’alba della Resistenza: da settembre a dicembre 1943
- Capitolo 2: Inverno e primavera 1944: da un difficile inizio all’illusione della vittoria (gennaio-giugno 1944)
- Capitolo 3: Un’estate di fuoco (luglio-settembre 1944)
- Capitolo 4 La resistenza disarmata
- Capitolo 5: Inverno e primavera 1945
- Conclusioni
- Ringraziamenti
- Indice dei nomi