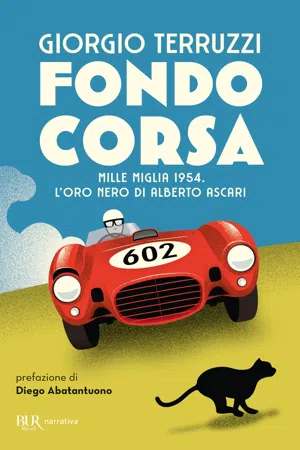(Bourton on the Water, 14 luglio 2003)
Puntava i piedi. Piede destro soprattutto. Frenava, lungo rettilinei neri e stretti come imbuti nella nebbia. Frenava in curva. In curva moltissimo. Il cuore: una pompa affannata. Pompava così forte da sollevare la giacca. Da svenire. Panico.
Ecco, si trattava di fare andare anche il cervello. Pensare che l’avevano già fatto ed erano tornati a casa. Pensare che da questa curva, come dalle altre, sarebbero usciti, trasportati da una magia, da un mistero. Soprattutto, smetterla di puntare i piedi così, di frenare con il destro visto che il pedale del freno non c’era. Il pedale stava dall’altra parte, lato guidatore. E il guidatore lo usava pochissimo.
L’automobile era grigia ed era un’Aurelia. Lancia, gran macchina. Il passeggero era un uomo mite che aveva persino pensato di fare il pilota prima di conoscerli i piloti veri, di avere un’idea, vaga nella sua intensità, di cosa significhi correre davvero, cacciare dentro la quarta accelerando a tutta birra, nell’esatto momento in cui chiunque, dotato di un minimo di autoconservazione, avrebbe cominciato a frenare. Meglio fotografarlo quello lì. Più portato. Si chiamava Corrado Millanta e aveva giurato a se stesso una volta, a sua moglie due volte o tre, che una cosa del genere non l’avrebbe rifatta mai più. «Ma sì, capirà anche lui, troverà un altro, figurati.» Lui, il guidatore, era un pilota, un campione, il campione del mondo. Era Alberto Ascari.
Quella cosa lì, una pazzia, sembrava passata. Riguardava un’altra epoca, una diversa frenesia. Anni Quaranta, alla fine. Ascari aveva ancora qualche dubbio da smaltire e una Fiat 1900 da guidare. L’aveva comperata, quella Fiat. L’Aurelia, invece, era un regalo. Come una dote per un matrimonio, concessa dalla Lancia alla firma del contratto. Di diverso non c’era soltanto l’automobile. Ascari adesso aveva quasi trentasei anni, aveva vinto due titoli mondiali di fila, 1952, 1953. Ferrari. Formula 1. Era ricco, celebre e celebrato. Era consapevole. Perché diavolo voleva ripetere quel viaggio assurdo e notturno?
Allora, ai tempi della Fiat, Millanta poteva capirlo. Alberto si era spiegato benissimo: «Provo i riflessi, li alleno, li sveglio un po’». Aspettava la nebbia, la covava dalla finestra del salotto. Stava lì, scostando le tende a intervalli regolari, sino a quando vedeva solo anice, nuvole di anice rischiarate da un alone di luce, dai lampioni di corso Sempione. Scendeva in garage con il giacchino di pelle, le scarpe morbide, i guanti di camoscio, respirava la propria elettricità e quel sapore denso di inverno, di Milano. Si cacciava in quel nulla ed era euforico, pronto. «Sciur Milanta, andemm?» Telefonava appena prima di uscire. Parlava in dialetto, levando una L dal cognome. «Andiamo?»
Da Milano a Lodi, chilometri 75, andata e ritorno. Strada statale, illuminazione zero. Velocità: 100, 110, 130. Ogni segno apparso all’improvviso, un cancello, un paracarro, un bivio, erano ordini. Cervello, gesti. Ascari: muto, assorto. Ma contratto, nervoso, mai. Guidava, ed era come stesse leggendo. Asfalto come carta, grumi come righe. Acceleratore, colpo di freno, cambio, volante. Nei movimenti, morbido, preciso. La velocità prendeva forza solo se riferita a punti fermi da fissare. Altrimenti, un velluto. Un tuffo nel nulla.
Millanta i punti fermi li fissava tutti. Li guardava sbalordito, come attratto. Muto, pure lui, annientato la prima volta da quello spettacolo che pure aveva immaginato come non immaginabile e che andava oltre la sua fantastica immaginazione. I tratti di retta, le brevi sequenze rischiarate dalla luce di un borgo, la fine di un banco valevano un patrimonio. Regali. Ne approfittava subito, respirando profondo, allentando la pressione sul suo freno inesistente. Come stalli di pace durante un mal di denti, un dolore addominale. Osservava il suo pilota e anche lì, un poco, si calmava. Ma era comunque una tortura, con linea di traguardo a Porta Romana. I riflessi? Ottimi, strepitosi, dai Alberto, non ti pare? Macché. Una settimana, dieci giorni, e arrivava la chiamata: «Allora, sciur Milanta…». E lui andava.
Ci fu una seconda volta, una terza, una decima. Non se lo spiegava del tutto mentre sua moglie non se lo spiegava affatto. Eppure, una parte di se stesso era sempre pronta a pagare il biglietto per Lodi, andata e ritorno, con nebbia. Era una smania mischiata alla paura, alimentata dalla fifa. Era persino arrivato a un’impazienza, a sperare in quella telefonata, a mangiare leggero nell’attesa, visto che pareva la sera giusta. Perché di quell’abisso era ormai un elemento decisivo, portante. Un protagonista. E in qualche modo guidava pure lui, attraverso l’altro. Raggiungeva il suo limite e lasciava che fosse Ascari a superarlo, godendosi, ipnotizzato dal terrore, una dimensione non raggiungibile. Uno spettacolo vissuto dal palcoscenico, altro che prima fila. Un’intimità eccellente. Alla fine, si sentiva come dopo una doccia. Fradicio nella notte invernale ma saturo, sazio. Pronto, in definitiva, a rifarlo.
Alberto Ascari l’aveva fatto, per l’ultima volta, sei, forse sette anni prima. Era stato un suo gioco, un passatempo. Utile, certo, ma dimenticato. Adesso, questa urgenza improvvisa. Si era alzato da tavola come rispondendo a un comando meccanico, aveva percorso il corridoio, spalancato la porta della camera di Tonino ed era rimasto lì, in silenzio, a osservare il sonno di suo figlio. Poi, indietro, avanti, indietro. Passi senza senso. Si era fermato, sorpreso da quell’inquietudine, aveva scostato le tende ed era comparso quel buio coperto di ovatta. Ma certo, ma sì.
Tutto, ricordava tutto alla perfezione. Aveva persino cercato quel paio di guanti, dati via, buttati chissà da quanto, come se non lo sapesse, proprio lui così attento alle sue cose. Eppure rovistava nervosamente, chiedendo notizie a Mietta, la moglie, un po’ stranita e poi nervosa a sua volta nel vederlo così, a fare i capricci. «Ma cos’è? Dove vai?» Andava a Lodi, di nuovo, ma non era il caso di dirlo. A lei, se non altro. Piuttosto, il Millanta.
Che fosse invecchiato non si vedeva granché. Non lo vedeva lui, abituato com’era a stargli insieme, a cenare in compagnia dopo un giorno di prove, una corsa. Continuava a chiamarlo «Milanta» con una L in meno, a parlargli in dialetto, a scherzare, anche se poi, in sostanza, lo ammirava davvero. Bravo come nessuno. Fotografie esatte, radiografie di uno stile di guida, di un difetto meccanico, di un enigma agonistico.
«Ma no, cosa dici, sono già a letto. No che non posso e comunque non voglio. Ma cos’è che ti salta in mente? Pronto? Alberto? Ci sei?» Non c’era, già fuori, a cavare l’Aurelia dal garage.
Per capire e parlare, buttar fuori quel grumo, ci vollero cento e passa chilometri. Di ritorno, quasi a Milano, smaltita per strada una furia, con il sedere dell’Aurelia che scappava nelle curve. Sbandate, niente di che, da correggere con leggerezza mentre Millanta lo osservava, seguiva la sua mano sul volante pensando all’archetto di un violino. Poche parole, come allora, come un copione da ripassare, ma era evidente che qualcosa c’era, se non altro per la proposta, per quella corsa così fuori squadra, una stramberia.
Millanta aveva ripetuto le sue domande sotto casa, prima di salire. Ascari, tacendo, aveva fatto una smorfia, un mezzo sorriso, dei segni, dai, salta su, nemmeno fosse il complice, il palo della banda, lì che aspetta, infreddolito sul marciapiede: motore acceso, a bordo, alè…
Di tirar fuori quel poco, quel tutto, Ascari nemmeno lo decise. Capitò così, all’improvviso, mollando il gas quasi di colpo, rilassando il busto, i nervi, in un istante, come se fosse finita la benzina: «Tocca correre un’altra Mille Miglia, caro Milanta». Aveva detto: «Tocca correre».
Millanta disse: «Ah, bene no? Perché, non sei contento?».
Ascari disse: «Insomma, mica tanto».
Millanta disse: «Allora non farla, nessuno ti obbliga più a nulla».
Ascari disse: «Bisogna. Con la Formula 1 la Lancia è in ritardo, per la Mille Miglia la macchina c’è. È deciso, fuori discussione».
Millanta disse: «Non ti piace, vero?».
Ascari disse: «È un assurdo, una corsa spaventosa. Speravo di non farla mai più».
«Intanto mi presento: conte Pierino Cereda. Possidente. Pierino Cereda. Basta e avanza: “conte” e “possidente” sono cose che interessano solo i villani. I ricordi? Una folla, tutti qui, in disordine ma qui, tra la testa e il cuore. Dunque: MG. Piccola, verde scuro, una lucertolina, un fascio di nervi. Con l’MG ho bucato in corsa. E il cric non si trovava. Perché lo spazio ai piedi del pilota era tanto così. Minimo. Assurdo. C’erano: tavolette di cioccolata, chiavi inglesi, candele usate, olio in latta, olio rovesciato, sandwich schiacciati. Tutto, tranne il cric. Allora, per fortuna, c’era della gente. C’era sempre della gente, una marea umana lungo la strada. Di notte, di giorno, sempre.
«Con il mio secondo, durante la corsa, parlavo in dialetto. Quella volta ho parlato italiano. “Venite, aiuto.” Avevano visto la macchina. Macchina inglese. Devono aver pensato: inglesi. Figuriamoci. Si sono mossi di colpo, sono arrivati ed erano in troppi. Hanno tirato su la macchina, saranno stati venti. Gridavo: “Piano, piano, che fate un disastro. Piano, che bastano quattro persone”. Sì, ciao. La tenevano su e ho cambiato la ruota. Così, siamo arrivati in fondo. Prima macchina a finire la corsa. Entusiasmo. Io, non tanto. Aspettavo quello che era partito tre minuti dopo e che poteva prendermi. Passa un minuto, ne passano due. Si sono visti i fari lampeggiare. Ho pensato: oh, santa Madonna. Ho detto: “Oh, Cristo santissimo”. Abbiamo vinto per quaranta secondi. Primo di categoria, che non è come vincere davvero ma insomma, un bell’andare.
«Ho corso anche l’anno dopo. L’avevo detto a quelli della MG: guardate che non va, non ce la facciamo. Infatti c’era Taruffi con la Maserati quattro cilindri. Mi hanno dato retta? Per niente. A un privato, a uno che pagava per correre, non davano credito. Sorridevano, una pacca sulla spalla, così, tanto per non mortificare. Ascoltavano i professionisti anche quando di quella corsa lì non sapevano cosa dire, mai fatta, incomprensibile. Morale: sono arrivato secondo. Ma ha vinto Taruffi! Sono stato tre volte primo di categoria, tre volte secondo. Una volta terzo. Ero sempre lì, sempre in lizza. Perché a me piaceva fare il pilota.
«Mi era venuto in mente in un modo stranissimo. Ero un secchione a scuola, primo della classe, figlio unico di madre vedova. Educato nella bambagia come king l’erede. A quell’epoca non si faceva sport. Sport? Che roba è? Si lavorava e basta, quelli che dovevano lavorare, quasi tutti. Oppure si faceva flanella, un bel niente, quelli che potevano, che i soldi li avevano in famiglia. Pochissimi. Ecco, l’unico sport obbligatorio era tirare di scherma. Perché se eri un signore dovevi tirare di scherma.
«Io odiavo la scherma. Tiravo solo con il maestro. Non avevo amici. Vivevo in un piccolo paese. Passo avanti e a-fondo; passo avanti e a-fondo: non ne potevo più. Poi, la ginnastica. La ginnastica era noiosissima. Io ero anche esonerato: stretto di spalle. Debolino. Prima facevo il privatista, perché un signore doveva studiare a casa con gli insegnanti tutti per lui. Privilegio? Mi sembrava una punizione, guai a distrarsi, tutti e due lì, stessa stanza. Anche l’insegnante si seccava. Vuoi mettere la scuola? Parli, leggi un giornalino, guardi le figure, pensi ai fatti tuoi. Stai con gli altri, impari sul serio. L’ho detto a mia madre. L’ho buttata sulla solitudine come fatto negativo, per dopo, s’intende.
«Mi ha iscritto. Scuola pubblica. Ero ultimo in tutto. Italiano: ultimo. Algebra: ultimo. Salto in lungo: ultimo. Tutto così. Mi sono detto: qui bisogna darsi da fare. Scuse? Finite, esaurite, ciao. L’avevo chiesto io di andare lì, mica potevo tornare indietro. Ho cominciato con il ciclismo. E dopo, diciamo subito dopo, ho trovato che era meglio avere sotto un motore.
«Stavo a Bormio, Valtellina, in mezzo alle montagne. Vacanza. Ero ancora un ragazzino. Leggo sul cartello: COPPA DELLE ALPI. Leggo: CORSA DI AUTOMOBILI. Disegno del percorso, scacchi bianchi e neri sullo sfondo. Passavano di lì. Sono arrivato sul posto, lungo la strada. Ho scelto un punto, un masso. Rettilineo breve, curva, rettilineo lungo. Li ho visti passare. Rossi, metallici, meccanici, velocissimi. Magnifici. Li ho visti in un baccano d’inferno. Li ho visti sparire giù, in fondo, con la polvere che volava dappertutto. Li ho visti passare e mi sono detto: io correrò in automobile. È stato proprio così: patapam! Colpo di fulmine.
«La Mille Miglia… cos’era la Mille Miglia! Era un’avventura che non scordavi più. Era un filo di seta che passava nel cervello. Ed era una festa totale. Per chi correva, per chi guardava. Si partiva uno alla volta, da Brescia, sempre, perché l’avevano inventata lì. Prima le macchine piccole, cilindrate basse, e poi avanti, sino ai campioni con le macchine più potenti, quelle delle Case. Ferrari e Mercedes, Alfa Romeo, Lancia, Maserati. Da Brescia a Roma e indietro. Mille Miglia, 1600 chilometri, più o meno.
«Acqua, grandine, luce e buio: niente. Partivi e tornavi, a razzo. Miglior tempo vince. Solo che le strade erano stradacce, buche e terra, curve da incubo, imprevisti, oh, mamma, che roba. E poi la gente. Una massa impressionante. A Ferrara come a Pescara, sulla Futa, in mezzo ai campi della Padana. Dieci del mattino o tre di notte: tutti lì, in piedi, eccitatissimi. I fari abbagliavano gli sguardi, li sfilavano, un attimo, come colpi di flash. Occhi, a migliaia, innamorati, rapiti, presi. Morti: una quantità. Si moriva guidando, si moriva guardando. Sbagliavi ed era fatta. Ti ammazzavi e ammazzavi chi stava lì attorno, facevi una strage. Per questo l’hanno chiusa, nel ’57. Troppi morti.
«La prima volta fu nel ’27. Dico: millenovecentoventisette. Presente? Preistoria. Cari ragazzi, sapete cosa succede? Si parte con le automobili, si attraversa l’Italia e si torna indietro. Ma va’ là! Automobili? Fantasie. Meccanismi lunari. C’erano i cavalli, nel senso degli animali. Le automobili erano meraviglie raccontate da chi sapeva leggere e poteva leggere il giornale. Non dico a Milano o a Roma, nelle città. Dico in generale. Campagna, silenzio, carri e carrozze. Ecco, un mondo antico dentro il quale esplodeva una tempesta, un fuoco artificiale. Velocità e rumore. No, era qualcosa di più: sangue, velocità e rumore. Perché il sangue serviva alla causa, era un altro rosso, una tinta dominante. L’avevano dentro i corridori e poteva uscire, scappare fuori da un momento all’altro, come capita agli eroi che vanno in battaglia.
«Di questo si trattava, per tutti. Tranne che per chi correva: non ci pensavi, non ci pensavi affatto. Avevi in mente altro, lanciato com’eri in una specie di ipnosi futurista. Dominato da una passione e da un’attitudine che il rischio lo calcolava, lo controllava. In linea di principio, è ovvio. Ovvio, capivi: qualcosa poteva capitare ma non sarebbe certo capitato a te. E comunque dai, che si può forzare, si può andare più veloci, più veloci, ancora di più.
«Ho cominciato con i libri di tecnica nel 1921. Automobili: circolava poca roba. Riviste inglesi soprattutto. Prima macchina posseduta: 1923. Senza patente perch...