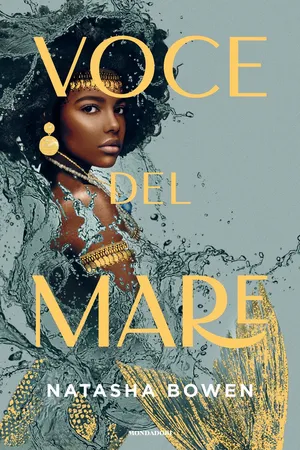Aggiro inosservata la nave tra le onde scure, assieme agli squali. Al di sopra delle correnti fredde e delle creature marine, il vascello fende la superficie dell’acqua, la stiva colma di persone strappate alla loro terra. Nuoto al di sotto dei flutti, lontano dallo sguardo degli uomini e a dovuta distanza dalle fauci dei predatori dei mari.
Resto in attesa.
Sopra di me si staglia l’ombra dello scafo e, mentre seguo la linea della chiglia, mi si stringe il petto e vengo assalita da una furia incontrollata. Con un colpo di coda mi allontano quando un banco di pesci mi guizza intorno, e allungo le dita verso i raggi di sole velati dall’acqua. Sono trascorse settimane dall’ultima volta in cui ho sentito sulla pelle il sole ardente di mezzogiorno. Mi manca crogiolarmi nella sua luce, lasciare che il calore mi penetri nelle ossa. Chiudo gli occhi e tento di evocare un ricordo che, come un serpente di fumo, si attorciglia e si contorce. Sono seduta sulla terra rossastra sotto l’ombra pezzata di un mogano, sprazzi di luce sulla mia pelle calda. Trepidante, mi aggrappo a quell’immagine nel tentativo di scorgere dell’altro, ma come al solito, svanisce nel nulla.
La delusione mi attanaglia, tagliente come il rosso del corallo. Ogni volta provo la stessa sensazione di perdita, quasi bastasse tendere la mano per raggiungere quella parte di me, solo per poi vederla dissolversi come la bruma che lambisce le onde.
Mi giro nell’acqua, un turbinio di pelle e mulinelli, di ciocche e squame che scintillano come un tesoro sepolto. Abbracciando la corrente, lascio scorrere le mani tra le scie di alghe, sento esaurirsi il flusso indistinto di ricordi. Mi fermo per qualche istante quando i pesci mi circondano ancora una volta, di un giallo sfavillante con delicate strisce rosa, e mi lascio confortare dalla loro bellezza.
Immergendomi, mi allontano ulteriormente dalla nave. So che dovrò tornare indietro, ma per ora chiudo gli occhi e accolgo la sensazione vellutata dell’acqua, il suo refrigerio mi scivola lungo la pelle. Questa parte del mare è più buia, e provo riconoscenza verso l’oscurità che mi avviluppa e nasconde.
Sotto di me, un’anguilla sguscia negli abissi, il suo corpo muscoloso solo di poco più nero dell’acqua che lo circonda.
“Vai” le dico, e in un unico movimento strisciante la creatura color inchiostro arretra. Scendo ancora di più in profondità. Abbastanza perché il freddo mi penetri nelle ossa. Abbastanza perché il luccichio della mia coda venga inghiottito dalle tenebre.
Sento la corrente che mi trascina e, per un istante, sono tentata di lasciare che mi porti via con sé, ma poi mi ricordo della nave e sollevo il viso, verso il sole e il dominio degli uomini che respirano aria. Nuoto di nuovo verso la superficie, con ben chiaro in testa il mio obiettivo mentre osservo lo scafo di legno che solca l’oceano. Sono restia ad accostarmi troppo, per timore di essere vista da qualcuno appartenente al genere umano; invece mi nascondo nell’ombra di mezzanotte del mare, sopra di me il baluginio dei ventri degli squali bianchi. Si avvicinano lievi, gli occhi piatti color ossidiana e i denti pronti. Rabbrividisco e mi tengo lontana dai loro grandi corpi che seguono la nave, anche se il nostro scopo è lo stesso: andare alla ricerca di coloro che entrano nel nostro dominio.
Mentre lo scricchiolio del vascello riecheggia nelle profondità, accarezzo la pesante catena d’oro che porto al collo, le maglie fredde sulla pelle. Passo le dita sullo zaffiro che luccica nelle tenebre.
E poi ci siamo: l’acqua si infrange e sibila sotto il peso di un corpo che affonda, le bolle si sollevano e scoppiano, rivelando la discesa di arti divaricati e pelle macchiata di cremisi. Quando uno squalo si scaglia verso la preda, nuoto più in fretta. Il sangue vortica nel mare, nastri rossi che si dipanano negli abissi. Mi inoltro tra le creature bianche e grigie, verso l’alto, cercando nel frattempo di ignorare il pungente sapore di rame nell’acqua.
“Aspettate” ordino agli squali mentre il corpo sprofonda. Lo attorniano impazienti, gli occhi neri guizzanti. Mi volto verso la persona e intravedo il suo sguardo assente e la bocca aperta, livida e gonfia.
Una donna, la pelle di un bruno scuro nell’acqua. Il movimento delle ciocche nere che fluttuano nella corrente rivela altre ferite sul lato del viso. Ruota lentamente e qualcosa nella linea del suo corpo mi parla. Non ha avuto una morte serena, penso, chiudendo per un attimo gli occhi. Ma del resto, non ce l’hanno mai.
Non appena le afferro la mano, grande quanto la mia, mi sale la rabbia al pensiero di un’altra morte celata dal mare. La tengo sempre più stretta; il suo corpo urta contro il mio, i nostri capelli si intrecciano. Le sollevo il mento e indugio sul suo viso.
La sua bocca ha un non so che di familiare, il modo in cui è inclinata, le labbra generose incorniciate da guance piene. Le trecce in stile k
lés
1 si sono sciolte e i capelli fluttuano liberi, ciocche nere che voglio toccare, sistemare. Torno a guardarle il viso e un ricordo affiora. Qualcosa mi ritorna alla mente... Provo a mettere a fuoco, a delineare meglio l’immagine, ma si rifiuta di venir fuori e gli squali si fanno sempre più vicini. Mi obbediscono solo per un tempo limitato.
Il mio sguardo si posa ancora una volta sulla donna, ma la sensazione di familiarità è svanita. La lascio andare e ripeto a me stessa che non ha importanza. È meglio così, penso, richiamando le parole di Yemoja. Meglio non ricordare chi ero prima. Invece mi concentro sul debole bagliore che la donna emana dal petto, appena sopra il cuore. Allungo la mano verso il vortice d’oro sempre più luminoso non appena fuoriesce dal suo corpo. Tocco l’essenza con la punta delle dita e chiudo gli occhi per prepararmi.
“Mo gbà yín. Ní àpéjọ, ìwoọ yóò rí ìbùkún nípas
eọ Ìyá Yemoja tí yóo sọe ìr
rùn ìrìn àjò reọ. Kí Olodumare mú oọ dé ilé ní àìléwu àti àláfíà” pronuncio, e poi ripeto la preghiera che accoglierà l’anima della donna. “Accolgo il tuo spirito. Tra le braccia di Madre Yemoja, protetta dalla sua benedizione, compirai il tuo viaggio. Possa Olodumare riportarti a casa in pace e tranquillità. Vieni a me.”
Il calore della vita della donna mi inonda la mente. La vedo da bambina, che ride quando avvolge le braccia intorno al collo della madre. Poi da grande, gli occhi che bruciano di un amore diverso mentre porge a qualcuno una ciotola di riso e pesce gatto speziato. La pelle scura e lucida, il sorriso ampio, l’uomo davanti a lei è bellissimo. Sento il suo cuore gioire quando lui prende il cibo e le loro mani si sfiorano. Poi la vedo dissodare un piccolo campo vicino a un villaggio. Le dita spargono semi nei solchi che ha scavato nella terra mentre intona una canzone a Oko, l’orisha dell’agricoltura. La sua voce è dolce e risonante, e s’innalza con il calore del giorno. Più avanti tiene in braccio una neonata con il suo stesso sorriso. Preme la faccia nelle pieghe del collo della bambina, odorandone il profumo di latte. Sorrido, pervasa da tutta l’esultanza che ha provato e dall’amore che le riempie l’anima.
Quando apro gli occhi, l’essenza della donna galleggia sulle mie mani chiuse a coppa. Mi concentro sulla gioia nei suoi ricordi mentre induco la sua anima a uscire e la guido verso lo zaffiro della mia collana. La pietra assorbe la sua essenza, riscaldando sempre di più la mia gola. Trattengo le immagini della vita di questa donna nella mente e mi domando se il villaggio da cui proviene esiste ancora. Se la sua gente, nell’attesa che ritorni, continua a controllare ogni giorno l’orizzonte.
Brandelli della sua veste si lasciano trasportare dalla corrente, un arancione sbiadito che una volta era luminoso come il sole di metà pomeriggio. Abbasso lo sguardo sulla mano che ancora stringo, le unghie pallide strappate e le cicatrici irregolari. Riceverà la benedizione di Yemoja prima di tornare a Olodumare; è l’unica cosa che posso fare per lei.
Che tu possa essere in pace, sorella. Yemoja ti accompagnerà nel tuo viaggio di ritorno a casa.
Lascio le dita della donna e mi volto, senza guardare il suo corpo che affonda negli abissi.
Una figlia, una moglie, una madre.
Le mie lacrime si mescolano al sale dell’oceano.
Yemoja può essere evocata solo il settimo giorno, ma nuoto comunque fino alla sua isola il pomeriggio precedente. Il piccolo affioramento di sabbia, roccia e fronde mi concederà un breve riposo dal mare e da tutto ciò che inghiotte. Mi piace ancora sentire il sole sulle gambe, sui capelli, a volte dormire e sognare.
Mentre mi avvicino all’isola, un guizzo di una pinna caudale mi coglie di sorpresa. Mi fermo, lo zaffiro della mia collana emette una luce soffusa che annuncia la presenza di qualcuno della mia specie.
“Simidele.” La voce è come una pianta rampicante che serpeggia nel mare, e mi strappa un lieve sorriso.
Mi giro, le braccia che formano archi nell’acqua, e contemplo le squame di un viola intenso e il viso rotondo di Folasade. Trasformata da Yemoja all’inizio di quest’anno, quando hanno iniziato a deportare le prime persone, è minuta, ma ha un gran sorriso, e i suoi occhi riflettono ogni sentimento che la attraversa.
“Che bello vederti, Simidele” dice, premendosi la mano sul petto, mentre le nostre pinne si sfiorano nell’acqua, le squame luccicanti. “Anche se di solito nelle tue ricerche non ti spingi fino a questa parte di mare.”
Ricambio il suo gesto di benvenuto, prima di accarezzare con delicatezza il mio gioiello. “Lo so. Sono tornata con un’anima da benedire.”
Folasade annuisce, i suoi riccioli corti in una morbida aureola nera. “Che sia lode a Yemoja per il suo amore sconfinato.” Si tocca lo zaffiro al collo, uguale al mio, e poi inclina la testa, scrutandomi da vicino. “Che succede? Non sembri... non sei in te.”
“È che...” Ma le parole mi muoiono in bocca e ammutolisco, cercando di non far tremare le labbra. Guardo lo zaffiro freddo che tengo tra l...