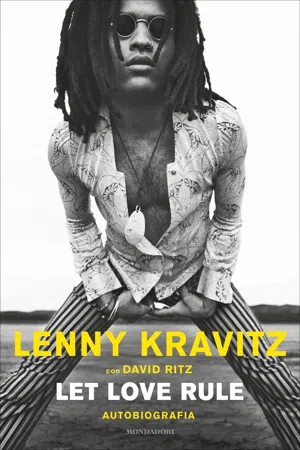Il mio amore per Lisa Bonet era nato come fantasia adolescenziale, ma poi, in modi che non riuscirò mai a comprendere del tutto, il mondo complottò per far avverare quella fantasia.
Iniziò tutto con Jheryl Busby, la cui strada avevo incrociato sia alla A&M sia alla MCA. Era diventato promoter dei New Edition, arrivati al successo con Candy Girl e Mr. Telephone Man. Da sempre fan del mio talento, aveva il potere di offrirmi un contratto discografico, ma non mi riteneva commerciale: secondo lui, il mio stile era troppo fuori dagli schemi. I New Edition erano in cerca di un batterista, e Jheryl mi chiese se ne conoscevo uno. Gli raccomandai Dan Donnelly. Cercavano anche un chitarrista, così dissi che avrei fatto il provino.
Non volevo mollare il nostro gruppo senza nome; ero convinto che, se i New Edition mi avessero preso, avrei trovato il modo per onorare entrambi gli impegni. Dan e io arrivammo all’Audible Sound di Burbank. Avevo ancora il mio look new wave: capelli stirati con una coda di cavallo che da color oro era diventata verde.
Feci del mio meglio, ma non mi presero. La cosa non mi stupì. Di sicuro avevano pensato che il mio stile non fosse adatto. Dan, invece, li conquistò. Con il suo backbeat potente e il suo carattere istrionico, fu ingaggiato all’istante. A quel punto iniziò a costruirsi un esuberante personaggio di nome Zoro. Dovevamo trovarci un nuovo batterista, ma io ero contento per mio fratello Dan, e tornai a dedicarmi al gruppo con Raf e gli altri.
I New Edition avevano un grosso concerto all’Universal Amphitheatre. Naturalmente Zoro procurò dei pass a me e a Rockwell (alias Kennedy Gordy). Mentre ci preparavamo per uscire, lui non sapeva cosa mettersi. Provò almeno quattro completi diversi. Io ero impaziente, morivo dalla voglia di vedere suonare Zoro. Pur essendo una star emergente – Somebody’s Watching Me era già un successo – Rockwell era incerto sul look. Alla fine si decise, e partimmo.
Era l’epoca del new jack swing, una variante dell’R&B fondata su ritmi staccati. I pionieri dello stile erano maestri dello studio di registrazione come Teddy Riley, futuro produttore di My Prerogative, la clamorosa hit solista di Bobby Brown, e di Jam di Michael Jackson. Jimmy Jam e Terry Lewis stavano mettendo a punto “Control”, l’album della consacrazione di Janet. E per quei ritmi non c’era batterista migliore di Zoro.
Il concerto fu una bomba. Alla fine, armato del mio pass, arrivai all’ascensore privato che scendeva ai camerini. Quando le porte si aprirono entrai, e stavano per chiudersi quando un uomo infilò dentro un braccio. Le porte si riaprirono. L’uomo, in giacca e cravatta, si fece da parte per lasciare entrare la sua ragazza. La sua ragazza era Lisa Bonet.
Sentii il cuore impazzire nel petto. Non sapevo cosa dire, ma dovevo dire qualcosa. Sapevo che quell’incontro fortuito era la mia unica chance. Non potevo sprecarla.
«Bei capelli» le dissi.
Un approccio goffo, un approccio stupido, uno degli approcci peggiori nella storia dei pessimi approcci. Eppure dissi proprio così.
«Anche i tuoi» replicò Lisa con un sorriso. Un sorriso! Lisa Bonet mi aveva sorriso!
Poco dopo, mentre erano tutti assiepati intorno al camerino in attesa che uscissero i New Edition, mi avvicinai a lei. Mi presentai come Romeo Blue. L’intesa fu immediata. Il tempo si fermò. Senza bisogno di dire chissà cosa, scattò l’attrazione. Non mi era mai capitato prima. Appartenevamo alla stessa tribù.
Prima di andarmene, riuscii a farmi dare il suo numero.
Iniziai a chiamarla, e poco alla volta intrecciammo una relazione telefonica. Alla fine delle sue lunghe giornate sul set dei “Robinson”, parlavamo fino a notte fonda. Sapevo che aveva un ragazzo, anzi, dei ragazzi. Io avevo Mitzi.
Lisa e io ci vedevamo come semplici amici. Era un revival dei miei vecchi rapporti platonici. In quanto figlio unico, la dinamica fratello-sorella mi aveva confortato e accompagnato per tutta l’infanzia. In questo caso la dinamica era fratello maggiore - sorella minore: io avevo ventun anni, Lisa diciotto.
Inutile dire che ricordavo il momento in cui, indicando la foto sulla copertina di “TV Guide”, avevo detto ad Alvin Fields che un giorno l’avrei sposata. Ma quella era una fantasia. Nella realtà, era già abbastanza pazzesco averla conosciuta e percepire l’intesa che ci univa. Non c’era bisogno di premere troppo sull’acceleratore, e non lo feci.
Lisa tornò ai Kaufman Astoria Studios, nel Queens, dove giravano “I Robinson”. Anch’io ero tornato a New York, con Mitzi e il gruppo.
Lisa mi apprezzava e sapeva che la vedevo per quella che era. Con i suoi completi di Norma Kamali e Betsey Johnson, i suoi cilindri e i suoi occhiali da nonna psichedelici, era assolutamente unica: brillante, suadente, misteriosa. Non si radeva le ascelle, il che mi piaceva. Indossava vecchi abiti sbrindellati presi nei negozi che vendevano capi usati per beneficenza, il che mi piaceva. Ma soprattutto amavo la sua mente e il suo spirito. Era libera.
Lisa Bonet era una delle donne più desiderate al mondo, ma non mi importava. Tra noi era sbocciato all’improvviso un legame potentissimo, ci capivamo al volo. E il fatto che fossimo entrambi sentimentalmente impegnati non faceva che rafforzare la nostra amicizia.
Mitzi sembrava convinta che Lisa e io fossimo solo amici. Tra noi non c’era quell’energia che si sprigiona quando un uomo ci prova con una donna o una donna fa la corte a un uomo. Nonostante il successo, lei era un’anima pura che, come me, aveva adottato l’etica peace and love di un’era precedente. Era ansiosa di sondare territori inesplorati. Era coraggiosa e impavida, ma allo stesso tempo fragile e severa. Era una randagia, ma anche una roccia.
Eravamo accomunati anche dalle origini multirazziali: Lisa era figlia di un’ebrea bianca e di un nero. Ci trovavamo entrambi a nostro agio in culture diverse. E il fatto che fossi cresciuto nell’ambiente delle sit-com televisive mi aiutava a capire cosa doveva sopportare ogni giorno. Sapevo quanto era faticoso, sapevo quanto costava.
Quando “Interview” pubblicò un profilo di Lisa – pochi mesi dopo il nostro incontro – eravamo già abbastanza legati perché lei citasse «mio fratello Romeo». Di lì a poco, però, cambiai idea su quel nome. Mi resi conto che quello che cercavo era sempre stato lì, sotto i miei occhi.
In Lisa non c’era nulla di finto. Più pensavo al mio nome d’arte, più mi sembrava fasullo. Io non ero Romeo. Non ero Blue. Non aspiravo a diventare una star immaginaria. Ero un musicista decisissimo a essere sincero. All’improvviso, mi resi conto che il mio pseudonimo me lo impediva. Era il me immaturo che si sforzava di essere cool. Ma la coolness viene da dentro. Non puoi simularla. Non puoi crearla con un nome. Devi coltivarla.
Avevo investito molto in Romeo Blue. Lo vedevo come un alter ego senza i problemi di Lennie. Adottare quella nuova identità mi aveva dato sicurezza. Ora però mi sembrava falsa. E quindi, addio Romeo Blue.
Quale nome scegliere, però?
All’inizio mi venne un’idea diametralmente opposta: Leonard Kravitzky, il cognome di mio nonno prima che arrivasse a Ellis Island. Feci persino stampare dei biglietti da visita, ma vedendolo scritto mi parve troppo classico, stile “Igor Stravinskij”.
No, la soluzione migliore era la più semplice: il vero me, il vero nome. Con una piccola variante, però: “Lennie” diventò “Lenny”, perché su carta la y mi piaceva più di ie. Mi sembrava più forte.
Insomma, ero Lenny Kravitz. Nonostante il nome e l’immagine che mi ero inventato, ero sempre stato Lenny Kravitz. Ma ci era voluta Lisa perché riuscissi a trovare me stesso.
Fu dunque Lenny quello che continuò a dedicarsi al nostro gruppo senza nome. Una sera suonammo al China Club di New York, un ingaggio di livello che fece notizia. Pensavamo di essere vicini a ottenere un contratto. Venne anche Lisa, che aveva un appartamento in Mott Street, e nell’occasione conobbe Mitzi, che la squadrava con sospetto.
Lisa si era lasciata con un ragazzo, ma usciva già con un altro. A volte mi invitava a casa sua, però non eravamo mai soli. Guardavamo film come Taxi Driver con il videoregistratore, ascoltavamo dischi di Jimi Hendrix, giravamo a piedi per il Village: amici, nient’altro che amici. Facendo la spola tra le due coste, non ruppi il fidanzamento con Mitzi. E perché avrei dovuto? Lei sapeva del mio affetto per Lisa, e andava tutto bene. O forse no?
Se era destino che per Lisa rimanessi un fratello, io mi accontentavo. Aveva la sua vita, e io volevo stare con lei, in qualsiasi modo. Potevo accantonare i miei sentimenti più forti: la priorità non ero io. Avrei fatto qualsiasi cosa solo per godere della sua energia, tanto la adoravo. Per dirla con i Rolling Stones, “you can’t always get what you want”.a
Un weekend, Mitzi e io andammo a Idyllwild, in California, con Lisa e alcuni suoi amici. Quella sera, al chiaro di luna nell’aria frizzante di montagna, molti di noi si fecero di funghi allucinogeni. Il trip fu tranquillo, ma fra Mitzi e Lisa si iniziò a respirare una certa tensione. Era indescrivibile ma innegabile.
Un’altra volta, mentre Mitzi era a New York e io a L.A., Lisa partecipò a una festicciola nel mio loft a Downtown. Vedendola scalza su una poltrona, mi venne naturale massaggiarle i piedi. Avete presente la famosa scena di Pulp Fiction in cui John Travolta dice a Samuel Jackson che un massaggio ai piedi può sembrare innocente ma non lo è? Un massaggio ai piedi può cambiare tutto.
Nel 1986 Lisa accettò un ruolo da protagonista nel film Angel Heart con Robert De Niro e Mickey Rourke. Era un noir psicologico che comprendeva riti vudù con teste di pollo mozzate e una sanguinosa scena di sesso. Il film infastidì Bill Cosby, che aveva coltivato con cura il suo integerrimo marchio hollywoodiano. Inoltre aveva già in programma “Tutti al college”, uno spin-off dei “Robinson” in cui Lisa avrebbe continuato a interpretare Denise.
Spirito fiero e indipendente, Lisa non batté ciglio. Apparire nuda nel film non le creava alcun problema, e non aveva intenzione di lasciarsi intimidire da Cosby. Qualche mese dopo, mi portò con sé a Orlando in un viaggio sponsorizzato dalla Disney, solo per farle compagnia. Alloggiammo in stanze separate.
Malgrado Lisa non avesse rinunciato a Angel Heart, Cosby e la NBC tirarono dritto con “Tutti al college”, in cui Denise lascia la casa dei Robinson a Manhattan per iscriversi all’Hillman, università nera immaginaria. Nel cast della sit-com c’erano anche Marisa Tomei e Jasmine Guy. La prima stagione fu un grande successo e vinse il People’s Choice Award come miglior nuova commedia.
Lisa mi invitò a trovarla sul set agli Universal Studios. Attraversandoli in macchina per raggiungere la location, ebbi un déjà vu. “Tutti al college” veniva girato nello stesso teatro di posa in cui ero cresciuto: quello dei “Jefferson”. Mi sentivo a casa.
Non appena mi vide, Lisa corse fra le mie braccia. Ero veramente a casa. Mi accorsi subito che si era fatta il piercing al naso. Sembrava una dea indiana.
Dopo le riprese andai al Gauntlet, uno studio di body piercing in Santa Monica Boulevard, e mi feci fare il buco al naso da Jim Ward, un pioniere di questa tendenza.
Sul fronte musicale avevo qualche difficoltà. Le major avevano mostrato interesse per i demo registrati con Raf e Danny, e io avrei dovuto esserne entusiasta. Ma non lo ero. Esitavo. Di nuovo, una voce mi diceva: “Aspetta”. Ma cos’era quella voce? Gli altri non capivano cosa stessi aspettando. Non lo sapevo nemmeno io. Era sempre la solita sensazione viscerale.
Quelle canzoni non mi rappresentavano. Cominciai a tergiversare, ma più mi allontanavo dal gruppo, più gli altri si incazzavano. Viceversa, più tempo trascorrevo con Lisa, più cambiavo emotivamente. Nel mio cuore prendevano forma sentimenti nuovi. Sentimenti che piano piano si traducevano in canzoni, il cui spirito però non aveva nulla a che fare con il gruppo. Quelle canzoni riflettevano le profondità della mia anima.
Le cose erano in rapida evoluzione. Quattro o cinque volte alla settimana partivo dal loft per correre da Lisa nella sua casetta di pan di zenzero a Venice. Lei mi leggeva poesie. Io le suonavo la chitarra. Ascoltavamo dischi e guardavamo film. Lei mi raccontava della sua infanzia, della madre che l’aveva amata e sostenuta, del padre che l’aveva abbandonata. Come me aveva dei fratellastri ma, sempre come me, era figlia unica. Era in cerca dell’altra metà. Lo ero anch’io.
Mentre ero in preda a una violenta tempesta di emozioni, la casa di Lisa diventò il mio...