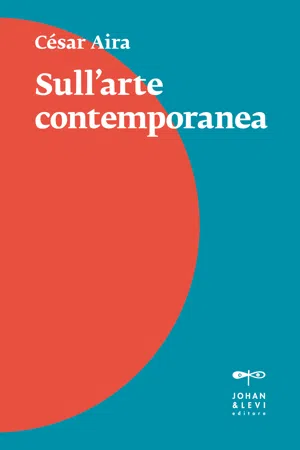Il mio punto di vista è quello dello scrittore che cerca ispirazione, stimoli, procedimenti e contenuti nella pittura. Un tipo classico, insomma, quasi banale e più o meno inevitabile. Uno dei possibili esordi della storia della letteratura – un mito di fondazione, se vogliamo – è quello della prima poesia, il primo racconto, come descrizione o interpretazione mitica di un disegno o di una scultura. Raccontare ad amici e vicini di caverna come ho catturato un bisonte è un semplice atto di comunicazione, in cui il linguaggio è puramente funzionale; ma raccontare loro la storia evocata dal bisonte e dal cacciatore raffigurati sulla parete della caverna è già un’avvisaglia di letteratura. La mediazione delle immagini impone una distanza, e questa distanza apre uno spazio in cui le parole risuonano e moltiplicano la loro espressione oltre ogni funzione utilitaristica.
Come mito di fondazione è piuttosto discutibile e, comunque, non siamo più alle origini. Forse siamo addirittura alla fine. Per quanto nel nostro mestiere la fine, o il fine, equivalga a trovare le origini. Qualsiasi origine andrà bene, basta che funzioni. Quanto a me, avventurandomi in questa personale e dubbia epica delle mediazioni, ho trovato nelle tendenze dell’Arte Contemporanea una fonte inesauribile e ineguagliabile di fruttuose fantasticherie fin dal giorno in cui vi entrai in contatto per la prima volta. Un giorno del 1967, in una libreria di Buenos Aires, acquistai il libro Marchand du sel, la prima raccolta di scritti di Marcel Duchamp, a cura di Michel Sanouillet. Questo volume, pubblicato nel 1959 da Eric Losfeld di Le Terrain Vague, conteneva un inserto trasparente su cui era riprodotto Il Grande Vetro (1915-1923) e da allora è diventato un prezioso pezzo da collezione, al punto che ho dovuto comprare un’edizione tascabile per non continuare a maneggiarlo e poterlo così conservare in buono stato nel caso un giorno volessi venderlo. I contenuti di un libro, con tutto il loro carico di qualità e informazione, possono essere trasferiti dalla prima edizione pregiata alla dozzinale ristampa tascabile senza perdere nulla. A differenza dell’immagine, la parola scritta non ha avuto bisogno di ulteriori sviluppi tecnici per raggiungere la perfetta riproduzione di se stessa.
Ecco però che subentra il feticismo, che rappresenta il superamento dialettico della riproduzione. Ed è per un feticismo sentimentale o autobiografico che non intendo vendere, per ora, il mio Marchand du sel. A diciott’anni, quando lo comprai, volevo fare lo scrittore; volevo scrivere romanzi come quelli che mi avevano accompagnato fin dall’infanzia, esprimere opinioni sui miei colleghi scrittori, battere a macchina fino a consumarmi i polpastrelli, dire cose importanti e intelligenti, fare il poeta, il saggista, vincere il premio Nobel. E in più, come se questo fosse poco, sentivo di essere ancora in tempo per diventare Arthur Rimbaud. Ma il sortilegio esercitato da Duchamp, quella fredda attrazione di cui lui solo conosceva il segreto, interruppe quei sogni per sempre. La mia era una intuizione priva di contorni chiari ma impossibile da ignorare, e resa ancora più irresistibile dalla mancanza stessa di una definizione. Mi ci sono voluti oltre quarant’anni per cominciare a intuire che cosa ci fosse dietro a quelle fantasticherie adolescenziali, ma non mi è ancora chiaro se scoprirlo fosse esattamente quel che mi ero proposto, né se è possibile che ci sia qualcosa di esatto in questa faccenda, e nemmeno se sia importante capirlo. Credo che quello che mi si è rivelato, grazie a quell’inserto trasparente, sia stata la futilità dello scrivere libri, perfino per uno che li amava quanto li amavo io, o forse proprio perché li amavo. Era giunto il momento di fare altro. E questo altro (che era già stato fatto ed era stato lo stesso Duchamp a farlo) è esattamente quel che dopotutto ho fatto, travestendomi da scrittore per non dover dare troppe spiegazioni: scrivere le note a piè di pagina, le istruzioni immaginarie o scherzose, ma coerenti e sistematiche, per certi meccanismi di mia invenzione, che facessero funzionare la realtà a mio beneficio.
Questo programma era antidiscorsivo senza tuttavia rinunciare a essere loquace. Appagava sia il piacere della segretezza sia l’avversione per il silenzio opportunistico; mi evitava di dover parlare, spiegare, interpretare, esprimere opinioni, insegnare, comunicare, ma non di scrivere, perché sradicava la scrittura dal terreno delle chiacchiere saccenti e la collocava sulla stessa lunghezza d’onda dei giochi di intelligenza e di invenzione attraverso i quali era passato Duchamp e con lui la sua considerevole scia; scia che di lì a breve avrebbe preso il nome di Arte Contemporanea.
Queste premesse lasciano intuire che sono un assiduo lettore e che sono abbonato a riviste che divulgano nuove idee in arte: Artforum prima di tutte, che colleziono dagli anni settanta, poi Art in America, Flash Art, Frieze, art press… Tiro in ballo le riviste per via di un fatto che ho notato e che molti altri avranno osservato, e che diventa più palese con il passare del tempo. Queste riviste, la cui qualità di stampa migliora di anno in anno e che presentano riproduzioni fotografiche sempre più perfette, offrono apparati iconografici via via più poveri e deprimenti. Quando arriva Artforum, la mia prima impaziente occhiata incontra fotografie di stanze buie con schermi che mostrano immagini sfocate, gallerie vuote, una donna seduta a un tavolo, indumenti appesi agli attaccapanni, frame in cui si riesce appena a distinguere qualcosa che ha una vaga somiglianza con del fogliame, nuvole o una pozzanghera, una stanza con assi di legno buttate sul pavimento o appoggiate a una parete, un’istantanea di una famiglia su una spiaggia, un cocktail, un ufficio… È possibile arrivare all’ultima pagina senza aver incontrato nulla che parli per sé visivamente. Si è costretti a tornare all’inizio per scoprire, leggendo, a cosa si riferissero quelle foto deludenti; e, una volta informati, si riconoscerà che erano la miglior documentazione possibile di opere d’arte che con ogni probabilità sono innovative, intelligenti e degne di nota, ma che si intestardiscono nel non lasciarsi fotografare.
Lasciamo perdere, per il momento, le solite critiche del Nemico dell’Arte Contemporanea, secondo le quali i ciarlatani che millantano di essere artisti non possono prescindere da un discorso legittimante che convalidi il nonsenso che producono. Cerchiamo invece di pensare alla logica e alla storia della riproduzione – senza entrare nella questione filosofica dell’“aura” che, personalmente, non ho mai trovato troppo convincente. Un’opera d’arte ha sempre contenuto in sé la propria riproduzione. Esposta alla percezione e alla memoria, è inevitabile che sprigioni fantasmi nel tempo e nello spazio. In questo senso, l’opera d’arte non è che il modello per le proprie riproduzioni, e quasi nulla di più (altrimenti, è un mero oggetto di prestigio, soggetto come tutti gli altri alle intemperie e alle manipolazioni del caso). Per giunta, l’opera d’arte è sempre stata accompagnata da riproduzioni concrete e tangibili. I greci riproducevano statue (ricordo la mia sorpresa quando lessi nel saggio di Kenneth Clark che gli originali erano in bronzo e il marmo era usato per le copie, avevo sempre pensato che fosse il contrario). La preistoria delle riproduzioni erano le copie, realizzate scrupolosamente, una alla volta. Ma già in quella preistoria c’erano gli stampi e le colate, di cui la stampa è una forma bidimensionale. Con la fotografia, la riproduzione di un’opera d’arte raggiungeva uno stato che poteva dirsi definitivo, e che ormai ammetteva sol...