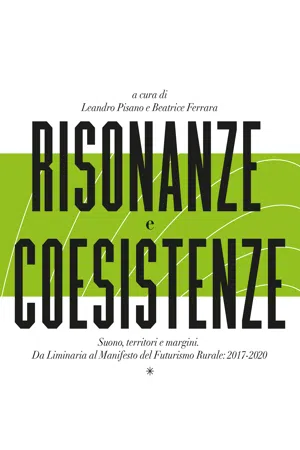
eBook - ePub
Risonanze e Coesistenze. Suono territori e margini
Da Liminaria al Manifesto del Futurismo Rurale: 2017-2020
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Risonanze e Coesistenze. Suono territori e margini
Da Liminaria al Manifesto del Futurismo Rurale: 2017-2020
Informazioni su questo libro
Il 4 novembre 2018 si concludeva a Palermo l'edizione di Liminaria inserita nel programma degli eventi collaterali della biennale internazionale di arte contemporanea Manifesta12.Con l'intervento in Sicilia, Liminaria chiudeva un ciclo di cinque anni di studio, ricerca e azione in diversi territori del Sud Italia: dall'Irpinia al Sannio beneventano, dalla Puglia al Molise, dal Cilento alla Sicilia. Aree rurali, luoghi abbandonati, zone ai margini attraversate tramite modalità di ascolto e pratiche artistiche che ne connotano una dimensione di alterità sia dal punto di vista sensoriale che delle risonanze del pensiero.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Risonanze e Coesistenze. Suono territori e margini di AA.VV., Leandro Pisano,Beatrice Ferrara, Leandro Pisano, Beatrice Ferrara in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Mezzi di comunicazione e arti performative e Arte performativa. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Categoria
Arte performativaDare forma a un’atmosfera di margine
Un percorso di ricerca-creazione attraverso l’ambiente sonoro di Guardia Sanframondi
di Nicola Di Croce
Qual è il futuro delle aree interne italiane? Lo spopolamento e il graduale impoverimento dei comuni dell’entroterra alpino e appenninico pongono due possibilità divergenti: accettare l’abbandono come inevitabile, o immaginare un rinascimento dei borghi e delle comunità più isolate.
Osservando il fenomeno dalla valle, ovvero dalla prospettiva della città diffusa, si intuisce solo in parte la perdita di complessità derivante da questo graduale abbandono – complessità che per secoli ha segnato il rapporto tra abitanti e territorio – e si fatica a elaborare nuove narrative capaci di riportare il dibattito pubblico e l’attenzione progettuale verso il tema del limen. Dall’altra parte, sul fronte collinare e montano, si avvertono invece sentimenti contrastanti, scissi tra speranza e disfatta. I piccoli paesi delle aree interne, infatti, non si trovano tutti nella stessa situazione economica e sociale: alcuni subiscono pesantemente gli effetti della marginalità geografica, altri invece provano ad elaborare la sofferenza causata dallo spopolamento degli ultimi decenni come stimolo per immaginare nuove strategie di sviluppo locale. Difficile in ogni caso per un borgo trovare una sintesi tra modelli ed ecologie del passato e nuove possibilità economiche, tra frammenti di tradizione ancora rintracciabili nella cultura locale e orizzonti di riscatto legati alle possibilità offerte dal turismo, tra ineluttabilità del presente e vocazioni future.
In un simile quadro, sembra che alcuni paesi delle aree interne cerchino di sfuggire da questa impasse aprendosi al nuovo, assecondando la necessità di internazionalizzarsi, di richiamare un pubblico ‘altro’; forse perché il territorio è ancora in grado di offrire al visitatore qualcosa di inatteso: il fascino della rovina, un’atmosfera sospesa e indecifrabile, la controparte dimenticata di quella città diffusa da cui si cerca spesso di fuggire, l’equilibrio tra forme di coesistenza passate e germi di futuro, di retro-innovazione.
Si può dire – e ne è testimone il sentimento che esercita l’edera quando si arrampica su un edificio abbandonato – che lo spopolamento abbia riavvicinato i borghi alla natura, ovvero a un modello culturale di relazione con la natura del quale iniziamo a provare una strana forma di nostalgia. Ci ritroviamo, anche solo a distanza di qualche decennio da quando questi borghi hanno iniziato a perdere abitanti, a sentire la necessità di non rinnegare l’abbandono ma di esplicitarlo, e così facendo tracciare i contorni di un nuovo equilibrio, di una nuova ecologia critica.
La mia esperienza di residenza artistica a Guardia Sanframondi è partita da queste suggestioni cercando nell’atmosfera, nell’immaginario, e nell’ambiente sonoro del borgo campano una chiave di lettura per interpretare le trasformazioni delle aree interne italiane, e invitare gli attori di tali trasformazioni (istituzioni, organizzazioni, abitanti) a una riflessione critica sul futuro del proprio territorio.
Il fascino, l’attrazione esercitata dall’abbandono è evidente a Guardia Sanframondi così come in altri paesi dell’entroterra campano, dove un certo numero di artisti provenienti da tutto il mondo – dagli Stati Uniti all’Australia – hanno deciso negli ultimi anni di trasferirsi, comprando e risistemando molte case disabitate del centro storico. Cambiare vita, per persone nate e cresciute in contesti molto distanti da quello del mezzogiorno italiano, ha significato aderire a nuovi modelli culturali, legami sociali e ritmi di vita, avere accesso alla qualità dei prodotti agricoli locali, e soprattutto a un contatto privilegiato con una vasta gamma di elementi naturali, tutto questo senza perdere di vista i vantaggi dati dalla prossimità di attività antropiche e alla relativa vicinanza a grandi centri urbani.
Ho iniziato a studiare l’atmosfera del paese – a pormi come un ricettore sensibile del rapporto tra il mio corpo e l’ambiente che mi circondava – dedicandomi all’ascolto del suo ambiente sonoro. Seguendo questo approccio, sono stato subito attratto entro i confini del centro storico, posizionato in un’area panoramica che domina la valle tra i parchi del Taburno e del Matese, e delimitato da aree pedonali o di difficile accesso carrabile. Attraversando gli stretti vicoli lastricati mi sembrava evidente come la difficile permeabilità carrabile del centro abbia rappresentato uno dei fattori che hanno contribuito ad accelerare lo spopolamento e l’abbandono dell’area a partire dagli anni ’80. Mi accorgevo così che, paradossalmente, l’esclusione del centro dai processi di trasformazione che hanno segnato il borgo negli ultimi decenni gli ha permesso di mantenere intatte le sue caratteristiche, ha dato tempo all’edera di arrampicarsi sui muri e alle case di diventare spesso rovine.
L’arrivo degli artisti stranieri, inizialmente osteggiato dagli abitanti, ha presto innescato un interessante processo di rigenerazione urbana, che è coinciso con un importante progetto di riqualificazione del centro storico da parte del Comune (Programma integrato di riqualificazione del 2002 e integrazioni del 2007). Dopo decenni di disinteresse verso le sorti del centro, il Comune ha intuito il potenziale sviluppo economico dell’area e si è imposto come attore di primo piano, avviando la ristrutturazione di molti spazi di sua proprietà, e concedendo le prime autorizzazioni per l’apertura di attività ristorative e commerciali.
Una simile operazione ha avuto un grande valore sia sul piano strettamente architettonico che su quello atmosferico e sonoro; ha segnato infatti l’inizio di una nuova stagione per il centro storico, che aveva perso tutte le sue attività ricettive e commerciali, e che dopo decenni si preparava ad ospitarne di nuove. Un simile passaggio segna quindi il ribaltamento di quell’immaginario che finora aveva portato a considerare possibile il progresso del borgo solo fuori dai confini del suo centro (“scomodo” perché inaccessibile soprattutto alle auto), e che aveva infatti portato all’espansione edilizia del paese al di fuori dei suoi confini e al graduale abbandono dell’area storica.
Strano pensare che la generazione dei figli di quella narrativa legata alla crescita economica degli anni ‘80 siano proprio i nuovi assegnatari dei locali commerciali del Comune: i primi forse a intuire che gli artisti avevano trovato nel centro disabitato qualcosa di prezioso. Così, grazie alla spinta iniziale degli stranieri e alle occasioni offerte dal Comune, un gruppo di giovani di Guardia Sanframondi ha iniziato a riconsiderare il ruolo strategico del centro storico, e si è dimostrato attento a sfruttare tale opportunità per valorizzare il territorio (i suoi prodotti, e le sue tradizioni e vocazioni) e per costruire nuove opportunità economiche capaci di garantirgli un futuro nel territorio.
Mentre indagavo le trame di questa storia, l’ascolto mi ha guidato verso i dettagli di quella atmosfera preziosa, in bilico tra abbandono e nuove istanze di rinnovamento. Ho intuito in che misura i segni di quello che resta di un paese in rovina rappresentavano un viaggio nelle intimità di chi resiste, di chi è assuefatto, di chi custodisce ancora questi spazi, se ne impossessa e guarda lo straniero con diffidenza. Mi sono fermato ad ascoltare l’acqua che scorreva sotto una scalinata voltata, scivolava sul pavimento di pietra dopo essere stata spruzzata con una pompa da una mamma che si divertiva a bagnare il suo bambino nudo tra i vicoli. Ho assorbito le cantilene monotone delle anziane signore che recitavano il rosario sintonizzate su Radio Maria. Mi sono fermato ad ascoltare gli interni delle case e le loro abitudini, le voci dei programmi televisivi, i discorsi disarticolati delle convivenze domestiche. Sono riuscito ad ascoltare la voce di un telegiornale locale che parlava di spopolamento dei paesi, dei sindaci che vendono edifici abbandonati a pochi euro per frenare l’emorragia di abitanti. È stata una strana coincidenza, il segno di un momento forse irripetibile, in bilico tra abitudini radicate e idee di sviluppo ancora da esplorare.
Seguendo gli indizi di chi ancora abita quest’area sospesa, mi sono accorto che l’atmosfera del centro storico non rappresentava un vuoto, non era semplice assenza di attività umane e di “oggetti sonori” ascrivibili al contemporaneo, non si poneva in antitesi con gli elementi di “modernità” circostanti. Al contrario, mi accorgevo di come l’atmosfera del centro permettesse di percepire (di filtrare) il “mondo di fuori” da una certa distanza critica; quasi senza parteciparvi direttamente, consentiva di guardare al quotidiano e ai modelli di sviluppo che gli hanno dato forma con un atteggiamento disincantato. Il centro storico era allora un filtro dei discorsi: qui ritornano d’estate i giovani che studiano o lavorano nelle grandi città vicine, riempiono di nuovi significati i vuoti che hanno lasciato, cercano una mediazione tra il loro presente e i residui del loro passato. Pensavo allora che vivere tra questi vicoli – così come hanno iniziato a fare gli artisti che hanno scelto questa come nuova casa – non significa entrare in un convento di clausura, ma porsi in una dimensione critica verso lo sviluppo compulsivo, l’immaginario che ha dominato il secondo dopoguerra italiano, che ha promesso (e spesso concesso a caro prezzo) progresso e crescita ma ha svuotato di senso il cuore sociale delle aree interne italiane.
Ascoltare questa atmosfera rarefatta è stato un esercizio di equilibrio tra quello che resiste e quello che scompare, ha rappresentato un invito a considerare con attenzione le trasformazioni di un paese – e delle aree marginali italiane – e i possibili “interventi” (sull’ambiente sonoro, sull’atmosfera) capaci di interrogare lo spostamento di immaginario che spinge oggi a investire in quelle rovine fino a ieri dimenticate. Cosa sarà di quelle rovine? Cosa sarà dell’atmosfera (instabile, forse irripetibile) che hanno ricercato tutti i nuovi residenti del centro? È possibile, tutelare il carattere di un’atmosfera in continua trasformazione? Difficile suggerire una risposta proprio perché, paradossalmente, una atmosfera è il risultato delle mutevoli relazioni tra “soggetti” e “oggetti”, tra abitanti e rovine, tra società e territorio. Da queste premesse, durante la residenza ho provato a interrogare la municipalità e i nuovi assegnatari dei primi spazi che rivitalizzeranno il centro storico avviando un dialogo riguardo l’evoluzione dell’atmosfera dell’area centrale di Guardia Sanframondi.
Nella retorica istituzionale – quella di un piccolo comune meridionale che vive tuttavia meno di altri il peso dello spopolamento – il centro storico rappresenta, oggi a differenza di ieri, un importante driver di sviluppo economico. Contemporaneamente, l’apertura di nuove attività, che lo stesso Comune ha stimolato, non può non avere un impatto sull’atmosfera del luogo. Proprio questo sembra infatti l’aspetto più interessante da considerare, dal momento che il carattere sospeso del centro storico – il suo parziale abbandono, il fascino delle sue rovine riconquistate dalla natura, e ancora il suo rappresentare un “altrove” rispetto alla modernità – è stato un fattore di richiamo per gli artisti stranieri ed è poi diventato un elemento su cui si è innestata una nuova attenzione, una nuova economia. Potranno allora le scelte che saranno prese per il governo di questo borgo contribuire a supportare le condizioni per l’emergere di questa atmosfera? Si riuscirà, in altre parole, a mantenere uno sguardo critico su una atmosfera così fragile, e forse proprio per questo, in grado di ispirare un senso di equilibrio tra passato e futuro? Si intravede qui un primo conflitto tra gli usi e le forme di cura del territorio e gli approcci tesi al profitto, laddove una mediazione tra queste istanze appare molto difficile da raggiungere. Mettere a profitto il centro (e “quella” sua atmosfera, finché resisterà) richiama ancora una volta il complicato confronto tra prospettive e modelli di sviluppo, ma invita tuttavia a uno sforzo collettivo di sintesi. Una sintesi collaborativa che coinvolga tutti gli attori delle trasformazioni urbane e che inviti ciascuno e ciascuna a dare peso al proprio rapporto col luogo, che sottolinei l’emergere di quel...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Introduzione
- Ontologie ed epistemologie rurali / Rural Ontologies and Epistemologies
- Geografie udibili della ruralità (e oltre) / Audible Geographies of Rurality (and beyond)
- In conversazione
- Manifesto del Futurismo Rurale / The Manifesto of Rural Futurism
- MANIFESTO OF RURAL FUTURISM / (2019)
- MANIFESTO OF RURAL FUTURISM
- Risorse in rete
- Note biografiche sugli autori