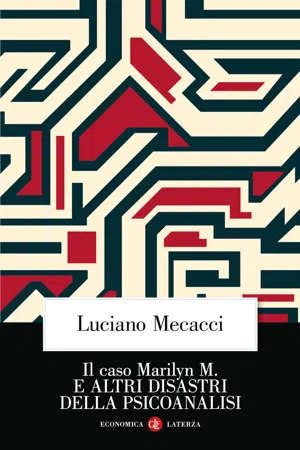1. Da Hollywood a Vienna
Il caso di Marilyn Monroe non è quello che propriamente si definisce un caso psicoanalitico. Diventano veri casi quelli che uno psicoanalista ha reso noti, perché magari ne ha scritto la storia, illustrando l’analisi e i rapporti con i suoi pazienti. Marilyn, invece, è un caso artistico, sociologico, poliziesco, persino politico, ma nessun psicoanalista ne ha scritto la storia.
Norma Jeane, nata a Los Angeles il 1° giugno 1926, prese il nome di Marilyn Monroe nel 1946. Quella scelta agli esordi della carriera di attrice nasceva da motivi professionali, ma rivelava anche il desiderio di una nuova identità.
Alcuni anni prima, ricorderà Marilyn nelle sue memorie, aveva avvertito come una frattura dentro di sé:
Provavo una strana sensazione, come se fossi due persone. Una delle due era la Norma Jeane dell’orfanotrofio, la figlia di nessuno, l’altra era una di cui ignoravo il nome. Ma sapevo qual era il suo posto. Lei apparteneva all’oceano, al cielo, al mondo intero...
Marilyn usava anche il nome di Zelda Zonk, quando girovagava per le strade di Manhattan o di Santa Monica, senza trucco e con una parrucca nera per non farsi riconoscere.
Fino a quando non si sposò sedicenne con James («Jim») Dougherty, la vita di Marilyn fu un continuo peregrinare da una famiglia adottiva all’altra, e tra i nove e gli undici anni approdò anche all’orfanotrofio di Los Angeles. Dove furono inutili le sue proteste che non era orfana, che la madre era viva e quindi poteva rimanere con lei. Marilyn non aveva ancora compreso che sua madre, Gladys, era malata di mente ed era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico.
Con diagnosi che andavano dalla psicosi maniaco-depressiva alla schizofrenia, Gladys peregrinò da un ospedale all’altro, alternando fasi di lucidità a periodi di follia costellati da tentativi di suicidio. Anche la madre di Gladys, Della, era affetta da psicosi maniaco-depressiva e morì in un ospedale psichiatrico. Alcuni giorni prima della morte, con un cuscino aveva tentato di soffocare la nipotina Marilyn. Per non dire del primo marito della nonna di Marilyn, che finì i suoi giorni in un ospedale psichiatrico. E della fine altrettanto tragica del padre di Della, cioè il bisnonno di Marilyn, che si suicidò.
Altri episodi tristi, e non meno devastanti per Marilyn, furono le molestie sessuali subìte da bambina: a otto anni ci pensò un attore che stava a pensione a casa sua; a undici le attenzioni le furono rivolte da un nuovo «papà» in una delle tante famiglie adottive; a tredici anni, infine, a molestarla fu un cugino più grande.
Il primo matrimonio, quello con Jim, liberò Marilyn dall’incubo delle famiglie adottive e di un possibile rientro in orfanotrofio, ma significò anche il primo incontro con una figura maschile protettiva. Marilyn la trovava solo adesso: il padre non aveva sposato la madre quando rimase incinta, e neppure in seguito volle riconoscere la figlia, che pure provò più volte ad avvicinarlo. Ma anche la figura della madre, Marilyn la surrogò nelle varie mamme «adottive» e, divenuta attrice, nelle colleghe di lavoro e nelle sue collaboratrici. Il primo marito, Jim, cinque anni più grande di lei, descrisse con precise osservazioni la personalità della giovanissima moglie:
Ero innamoratissimo, e lei era molto acuta e aveva un bel viso e un bel corpo. Quando ci sposammo era la sedicenne più matura che avessi mai conosciuto [...]. C’era qualcosa di maturo e di terribilmente speciale in lei, qualcosa che poteva aver ereditato. In seguito notai questo tratto in sua madre, anche se questa soffriva di disturbi emotivi. Altre volte, poi, si comportava come una bambina. Non aveva avuto una infanzia e lo dimostrava. C’erano due Norma Jeane; una era la bambina che teneva le bambole e gli animali di peluche sulla cassettiera, «perché possano vedere quello che succede». L’altra Norma Jeane aveva umori mutevoli che spesso facevano un po’ paura. C’erano sprazzi di una persona che per troppo tempo non era stata amata, per troppi anni era stata trascurata.
Per anni Marilyn soffrì di balbuzie, un disturbo che insorse durante il periodo dell’orfanotrofio, probabilmente dopo il primo caso di molestie sessuali. Quella balbuzie, sintomo della sua insicurezza, non l’abbandonò neanche quando fu un’attrice ormai affermata, manifestandosi durante riprese cinematografiche che l’impegnavano oltremodo o in altre condizioni di tensione. Le accadeva anche, a volte, di vomitare, per esempio poco prima d’iniziare una trasmissione radiofonica o un’intervista. Più gravi si rivelarono gli incubi notturni, che cominciarono anch’essi mentre era in orfanotrofio.
Un amico degli anni Quaranta, David Conover, raccontò di essere stato svegliato dalle grida di Marilyn nel mezzo della notte. Marilyn era seduta sul letto, fradicia di sudore e tutta tremante:
«È quell’i-incubo», balbettò lei. «Che cosa è successo?» chiese lui. «Mi mettono la camicia di forza e mi portano via da casa. Io grido: “Non sono pazza! Non sono pazza!”. E quando arriviamo a un e-edificio di mattoni che somiglia al mio vecchio orfanotrofio, passiamo per una porta di ferro dopo l’altra, e ogni porta si chiude sbattendo alle mie spalle. “Io non devo stare qui!”, urlo. “Cosa volete farmi?” Loro mi spi-spingono in una tetra stanza con le sbarre alle finestre, escono e chiudono a chiave la porta di ferro, lasciandomi la camicia di forza. “Io non devo stare qui!” grido ancora e ancora, fino a restare senza fiato».
In un altro degli incubi ricorrenti, Marilyn sognava di trovarsi in un cimitero, all’alba, e di correre nuda, per cercare una via d’uscita. Al risveglio, conservava un vivido ricordo delle tombe in mezzo alle quali era passata e dell’erba irrorata di rugiada su cui erano corsi i suoi piedi nudi. L’ultima governante di Marilyn, Eunice Murray, ricordava come, anche nell’ultimo periodo della sua vita, gli incubi notturni fossero ricorrenti. Poco dopo essersi addormentata, Marilyn si svegliava emettendo un urlo, tutta tremante e sudata. Si alzava dal letto e restava seduta su una sedia fino a quando non si calmava.
Marilyn colpiva per i suoi comportamenti bizzarri o anomali. Anzitutto, il cronico ritardo con cui si presentava sul set. Come ogni attrice, si sarebbe dovuta alzare presto, passare al trucco e vestirsi per essere pronta per le riprese intorno alle otto o alle nove. Ma spesso arrivava a mezzogiorno, frastornata dagli psicofarmaci contro l’insonnia e l’ansia. Oppure non si faceva neanche vedere, causando ritardi notevoli nella produzione del film, motivo di continui dissapori e litigi con la casa produttrice, il regista e gli altri attori.
Marilyn, peraltro, non aveva grande cura dei suoi oggetti. Abituata a passare da una casa all’altra, forse non aveva l’idea di cosa fosse un luogo stabile dove gli oggetti vengono conservati per tramandare la memoria storica della famiglia. La sua stanza era piena di vestiti ammucchiati. Un «copioso», ma «semplice» guardaroba, ricordava la sua governante di New York, Lena Pepitone:
Pantaloni di velluto neri e marrone, molte paia di pantaloni a scacchi bianchi e neri, camicette di cotone e di seta beige e bianche, una sfilza senza fine di abiti da sera dalle esilissime spalline con scollature vertiginose, un intero negozio Ferragamo a tacco basso. Possedeva quattro pellicce di visone, marrone e bianche, una gran quantità di fazzoletti ma, naturalmente, nessun capo di biancheria intima. Nel bagno immagazzinava bottiglie su bottiglie del suo profumo preferito, Chanel n. 5, insieme al più costoso Joy. Si profumava di rado, per non parlare del fare il bagno o la doccia.
Era a tutti noto, inoltre, che Marilyn si sentiva a suo agio soprattutto nuda: a casa o in giardino girava senza abiti, dormiva senza niente addosso, e faceva a meno delle mutande. Il corpo nudo era stato uno dei sogni ricorrenti della Marilyn adolescente:
Sognavo che stavo in chiesa senza abiti addosso e che tutta la gente giaceva ai miei piedi sul pavimento della chiesa, e io camminavo nuda, con un senso di libertà, sulle loro forme prostrate, attenta a non calpestare qualcuno. Il mio impulso ad apparire nuda e i miei sogni relativi non avevano niente di vergognoso o peccaminoso. Sognare la gente che mi guardava mi faceva sentire meno sola. Penso di aver desiderato che la gente mi vedesse nuda perché mi vergognavo degli abiti che indossavo: lo sbiadito vestito blu della povertà che non cambiavo mai. Nuda, ero come le altre ragazze.
Altre volte accadeva che la stessa nudità, fonte d’ammirazione per la sua bellezza, metteva in imbarazzo quanti avevano il privilegio di conoscerne le abitudini private: se ne stava sdraiata nuda sul letto, bevendo champagne e mangiando braciole di vitella, per poi pulirsi le dita unte con le lenzuola su cui aveva lasciato gli avanzi.
Con una Marilyn che non portava né mutande né assorbenti, le lenzuola erano un problema quando arrivavano le mestruazioni. «Dovete capire che a Marilyn», notava la sua governante, «non andavano a genio i pannolini più di quanto non andassero a genio le vasche».
Ma non erano solo queste le abitudini fastidiose di Marilyn. «Qualsiasi cosa e ovunque mangiasse», ricorda ancora Lena Pepitone, «non si preoccupava mai del galateo. Fra le sue abitudini sgradevoli c’era quella di emettere rutti e peti in continuazione». Per lei erano comportamenti del tutto naturali, e l’imbarazzo dei commensali la divertiva.
La donna che da molti fu definita sesso allo stato puro, archetipo della libido, e che in tali vesti fu presentata nei film, nei servizi fotografici e nelle interviste, visse una vita sessuale a dir poco complessa. Non ebbe solo tre mariti (il marinaio James Dougherty, il campione di baseball Joe DiMaggio, lo scrittore Arthur Miller) – e forse anche un quarto, per pochi giorni, il giornalista Robert Slatzer –, ma intrecciò molte altre relazioni con noti personaggi dello spettacolo: da Marlon Brando a Elia Kazan, da Yves Montand a Frank Sinatra; senza disdegnare uomini meno noti. Un discorso a parte merita la relazione con i fratelli Kennedy.
Queste storie non godevano del piacere dell’«esclusività», come sapevano bene giornalisti e biografi, spesso sguinzagliati alla ricerca delle fughe clandestine che Marilyn ordiva per visitare l’uno o l’altro amante mentre «ufficialmente» era impegnata con Jim, con Joe o con Arthur. In qualche caso si trattò anche di rapporti-limite, come l’orgia in cui Marilyn sarebbe stata filmata mentre intrattiene più rapporti sessuali alla presenza di Sinatra e del boss dei boss Sam Giancana.
Alla sfrenata vita sessuale s’accompagnava un forte desiderio di maternità. Gli aborti naturali subìti facevano cadere l’attrice in uno stato di profonda depressione, che solo l’alcol e gli psicofarmaci riuscivano ad alleviare. Per non ricordare la controversa storia (ripresa da Donald H. Wolfe) della figlia che Marilyn avrebbe avuto da John F. Kennedy (JFK) nel novembre 1947. Si racconta che le sarebbe stata sottratta per non compromettere e bloccare con un grave scandalo la promettente carriera del futuro presidente degli Stati Uniti. Marilyn avrebbe fatto, seppur raramente, riferimento a questa figlia, talvolta per piangere sulla sua maternità mancata, talvolta per minacciare JFK e poi Robert F. Kennedy.
Da questo sfondo emerge una figura di grande interprete di fronte alla cinepresa, ma di altrettanto fragile protagonista della propria vita psichica. La debilità mentale di Marilyn si incrociò con quasi tutte le forme di terapia: il trattamento analitico ortodosso (la cura attraverso le parole e il transfert, alla Freud), gli psicofarmaci in dosi massicce, la camicia di forza e l’internamento in manicomio. In altri termini, se non bastavano le parole, si ricorreva ai farmaci, e se anche questi si rivelavano insufficienti a sedare l’umore di Marilyn, era pronta la camicia di forza.
Marilyn fu curata da cinque psicoanalisti: Margaret Herz Hohenberg, Anna Freud, Marianne Rie Kris, Ralph S. Greenson e Milton Wexler. Negli anni in cui Marilyn s’avviava alla carriera di attrice, la psicoanalisi era di moda a Hollywood. Sicché attori, attrici, registi, produttori erano in analisi presso psicoanalisti famosi che risiedevano nelle zone più ricche di Los Angeles: Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica.
Come hanno documentato Stephen Farber e Marc Green nel loro libro – Hollywood sul divano suona il titolo in italiano, ma altrettanto eloquente è il sottotitolo: Uno sguardo imparziale sui frenetici affari d’amore tra gli psichiatri e la gente di cinema – gli psicoanalisti ricoprirono posizioni importanti nello stesso ambiente cinematografico. Fino a divenire consiglieri delle case cinematografiche oltre che consulenti per le sceneggiature di film che sempre più ritraevano la figura dello psicoanalista in lotta con i tormenti dell’anima.
Fu proprio il suo insegnante di recitazione all’Actors Studio, Lee Strasberg, a consigliare a Marilyn di entrare in analisi. Il metodo che stava apprendendo – fu la motivazione addotta da Lee – non sarebbe stato efficace se lei non avesse sbloccato le emozioni che covavano nel suo inconscio. Il «metodo», come veniva chiamato, si fondava sul principio che l’attore avrebbe potuto riproporre i più svariati stati emotivi solo se fosse riuscito a ricondurli alla propria storia emozionale, alle proprie esperienze affettive.
Così, nel febbraio del 1955, a ventinove anni scarsi, Marilyn cominciò le sue sedute con Margaret Herz Hohenberg, una professionista consigliatale dal suo amico fotografo Milton Greene. Lo stesso Greene era in analisi dalla Hohenberg, un’immigrata di origine ungherese che, dopo aver studiato medicina a Vienna, Budapest e Praga, era divenuta psicoanalista e nel 1939 si era trasferita a New York. Le sedute di Marilyn erano frequenti: tre, quattro, anche cinque volte a settimana. Allo stesso tempo, Marilyn ricorreva agli psicofarmaci per alleviare la sua ansia e vincere l’insonnia....