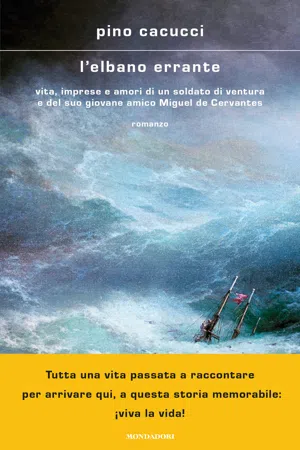Il sole si muterà in tenebra, e la luna in sangue.
Lucero rimase attonito di fronte a quella sfera di fuoco che sorgeva sull’orizzonte nero.
La luna rossa.
Non l’aveva mai vista così smisurata, tanto da avere l’impressione che fosse vicinissima: incombeva nel cielo oscuro come un cattivo presagio.
Angiolina lo scosse tirandolo per la mano: la sorella minore, lo aveva sempre saputo, sembrava possedere in abbondanza quel senso pratico che a lui faceva difetto. Gli porse il capo della cima e, senza bisogno di parole, lo esortò a tirare la barca in mare. Lucero fece un profondo sospiro e si accinse alla fatica notturna che li attendeva: il passaggio dei calamari prometteva cibo per diversi giorni, per la loro famiglia e, con un po’ di fortuna, abbastanza da rivenderne in paese e pagare qualche piccolo debito.
La baia sabbiosa a poca distanza dall’abitato di Longone, allora non aveva un nome: presto sarebbe diventata la famigerata “spiaggia del Barbarossa”. Da quella notte, nulla sarebbe stato come prima.
Lucero tirò il vecchio gozzo per la cima di prua, aiutato dalla sorella che spingeva a poppa. Quando le prime onde lambirono lo scafo Lucero si bloccò. Il suo sguardo fu attirato da una serie di punti luminosi nel mare aperto. Minuscole braci, come lucciole. E annusò l’aria: micce accese. Micce di archibugio. Conosceva quell’odore di zolfo, polvere di carbone e salnitro: frequentando la guarnigione di Longone, gli erano state insegnate molte cose delle pratiche guerresche, e adesso lui vagheggiava di farsi soldato, anziché sputare l’anima a pescare di notte e a zappare l’orto di giorno. Si voltò indietro di scatto: scorse la sagoma scura delle cataste di fascine e legna secca piazzate sui litorali per lanciare l’allarme. Ciascuna aveva alla base una piccola quantità di polvere pirica perché si incendiassero di colpo: il falò avrebbe avvisato dell’attacco.
Angiolina, che aveva un intuito da animaletto tutto istinto, lo fissò con i sensi all’erta e i nervi tesi. Lui si mise un dito sulle labbra: silenzio assoluto. Afferrò il coltellaccio con cui squarciava e puliva i calamari, sempre ben affilato, e prese la sorella per mano. Abbandonata la barca sulla riva, corsero verso la catasta. Lucero, freddo e determinato, prese l’acciarino e sfregò più volte la rotella di ferro sulla pietra focaia. Scintille. Sull’innesco. All’improvviso, la fiammata. E subito la pira si incendiò. Il giovane toccò fugacemente la medaglietta con l’arcangelo Michele che portava appesa al collo.
Dalle galee turche, quel bagliore anticipò l’ordine di attacco. Erano stati scoperti. Ora tutto si giocava sulla celerità nello sbarco e nell’assalto all’abitato. Miglia da percorrere. Non molte, per le gambe allenate del contingente di giannizzeri imbarcati sulle galee corsare che battevano bandiera del sultano ottomano. Diverse scialuppe erano già in mare e i vogatori aumentarono forsennatamente il ritmo, in breve tempo i Turchi calarono anche le altre e sbarcarono sulla spiaggia che da allora in poi, nei secoli, sarebbe stata ribattezzata con il soprannome del sanguinario comandante corsaro che si apprestava a invadere l’isola d’Elba: in realtà si chiamava Khayr al-Din, invitto ammiraglio di Solimano il Magnifico, raffigurato in ogni dipinto celebrativo con la folta barba rossa.
Alcuni archibugieri scorsero una figura che si stagliava contro le fiamme del falò. Soffiarono sulle micce accese, le avvicinarono alle pesanti armi che tenevano appoggiate a sottili aste di ferro e presero la mira. Una scarica di detonazioni lacerò il silenzio della notte nel dormiente paesino di Longone.
Sulla torretta che sovrastava il porto, l’armigero di guardia avvistò il falò. E cominciò a urlare a squarciagola: «Pira! Pira! Laggiù! All’armi!».
Un suo commilitone si mise a suonare la campana a martello. Di lì a poco, le campane di bronzo della chiesa di Longone lacerarono l’aria fresca della primavera elbana con i lugubri rintocchi che annunciavano la sventura, preti e sacrestani a tirare le corde frenetici, disperati, senza sosta.
I balestrieri di turno quella notte afferrarono le armi e balzarono in sella. Era un drappello di appena una dozzina di veterani, nulla avrebbero potuto contro un’invasione dal mare, ma non esitarono: le vite loro e dei famigliari, comunque, sarebbero state soltanto faville al vento, se i Turchi fossero entrati in paese... E subito due messaggeri partirono a spron battuto per raggiungere Ferraio e allertare la guarnigione più consistente sull’isola, che a sua volta avrebbe comunicato con i fuochi accesi l’allarme ai difensori dell’inespugnabile fortezza del Volterraio, la postazione militare più alta e scoscesa. Ma ci avrebbero impiegato almeno mezz’ora, e solo l’accensione di altri falò poteva avvisarli alla distanza, cosa che fecero decine di soldati mettendosi a correre verso le alture, dove altre pire erano allestite per la catena di allarmi predisposta da tempo.
Lucero ebbe un attimo di smarrimento: abbagliato dalle fiamme che divampavano crepitando, non vide accanto a sé Angiolina.
«Sono qui» bisbigliò lei, poco più in là, tendendogli la mano per invitarlo a correre via insieme.
Lucero fece una strana piroetta su sé stesso.
Un colpo di archibugio gli aveva trafitto un fianco. L’impatto lo fece cadere sulla sabbia, un bruciore intenso gli annebbiò la vista, ma nel pieno vigore dei suoi sedici anni – e neanche li aveva ancora compiuti – le energie della giovinezza e l’adrenalina lo rimisero subito in piedi.
I Turchi sbarcarono correndo come indemoniati, e nessuno di loro lanciava urla come d’abitudine durante un assalto. Erano stati scoperti, senza dubbio, ma procedere in silenzio era ancora il modo migliore per non farsi individuare dai difensori.
Lucero, zoppicando, ansimando, con la mano destra premuta sul costato da cui sgorgava sangue, e il coltellaccio nella sinistra, seguì Angiolina, che si mordeva il labbro inferiore per trattenere il pianto e intanto continuava a tirare il fratello per una manica.
I giannizzeri erano l’élite dell’esercito ottomano. Addestrati al combattimento corpo a corpo, si allenavano nella lotta, nella scherma, ma soprattutto nella corsa. Quando l’obiettivo era occupare una città immersa nelle tenebre, la capacità di percorrere miglia in poco tempo, a perdifiato, senza emettere un suono, socchiudendo gli occhi perché il sudore non offuscasse lo sguardo, li rendeva famigerati guerrieri capaci di incutere timore nelle schiere armate cristiane, e terrore nelle popolazioni di tutto il Mediterraneo. E ancor più del Mar Tirreno, dove le loro imprese avevano da tempo costretto molti abitanti a lasciare i litorali e a rifugiarsi sulle alture, rinunciando a fare i pescatori – il mestiere tramandato da secoli – per adattarsi a coltivare terre aride, pietrose e avare, e ad allevare capre. I Turchi segnarono il destino degli Elbani: genti di mare che divennero, a forza di massacri e razzie, genti di montagna. Ma non tutti si rassegnarono, e non pochi si ostinarono a rimanere nei piccoli centri abitati sulle frastagliate coste dell’isola, vivendo in una sorta di stato d’allarme permanente.
Il primo giannizzero si avventò su Angiolina e la sollevò di peso. Una ragazza poco più che quattordicenne era preda ambita: venduta all’asta ad Algeri, avrebbe fruttato una buona somma per allietare un harem, specie se vergine.
Lucero agì d’istinto: mancino, scattò in avanti con la sinistra descrivendo un semicerchio nell’aria con il coltellaccio. E recise di netto la gola del turco.
Il fiotto di sangue schiumoso colpì in faccia Angiolina, che rimase impietrita.
«Fuggi! Corri!» urlò Lucero con tutto il fiato che aveva in corpo, malgrado la fitta che gli arrivò dal costato ferito.
Una mazzata lo sbatté a terra. Un corsaro tunisino che seguiva l’avanguardia dei giannizzeri, già arrivati alla fine della spiaggia, gli aveva calato sulla schiena l’archibugio, ormai scarico, che brandiva al posto della scimitarra nel fodero. E che a quel punto impugnò, sguainandola. Ma prima che potesse mozzare la testa a Lucero, un dardo gli trafisse il petto.
I balestrieri della guarnigione di Longone prendevano la mira, calmi, rassegnati alla malasorte che li aveva spinti lì, centrando le figure nere che si stagliavano contro la luce del falò. Ricaricavano infilando la punta del piede nella staffa della balestra, tendevano la corda con entrambe le mani, prendevano la mira, scoccavano. Se ne portarono all’Inferno non pochi, ma uno dopo l’altro, vennero scannati dai giannizzeri.
Lucero, intontito, agitando vanamente il coltellaccio davanti a sé, in ginocchio, poté soltanto vedere Angiolina trascinata via, verso le barche degli invasori, la prima preda di un bottino che si preannunciava cospicuo. Perché il principale obiettivo di quelle incursioni era procurarsi giovani schiave per il sollazzo del sultano e dei suoi signori, tra i quali il pascià di Algeri, e giovani schiavi per i remi delle galee, e poi chiunque potesse essere venduto, o chiunque potesse rappresentare un riscatto da farsi pagare. Intere comunità sulle coste del Nord Africa lucravano su quel sordido traffico, e buona parte dei proventi andavano a Costantinopoli.
Lucero tentò di rimettersi in piedi, ma il dolore lancinante alla schiena e al costato lo piegò a terra. Strinse tra le dita la medaglietta dell’arcangelo Michele. L’ultima cosa che scorse, prima di perdere i sensi, fu quella maledetta luna rossa.
Il sole si muterà in tenebra, e la luna in sangue.
Jacopo V della dinastia degli Appiano, Signore di Piombino e delle isole toscane, teneva molto al dominio dell’Elba: da secoli e millenni forniva ferro in abbondanza, miniere a cielo aperto sfruttate fin dai tempi degli Etruschi e poi dai Romani, che avevano persino coniato un modo di dire, ad metalla, come minaccia per chi rischiava di essere deportato schiavo all’Elba a scavare minerali ferrosi.
Per i capricci della Storia, Jacopo V si ritrovava a corte un giovinetto “turco”, fatto prigioniero anni addietro: veniva trattato non da ostaggio bensì educato e istruito quasi fosse un membro del casato. Il problema era che quel ragazzino risultava essere figlio di Sinan Rais, corsaro ottomano detto il Giudeo di Smirne, nonché cognato di Khayr al-Din, il famigerato Barbarossa.
E questi era disposto a radere al suolo l’intera isola d’Elba se Jacopo V, da Piombino, non gli avesse restituito il rampollo.
Ma come era finito alla corte degli Appiano di Piombino il figlio di Sinan, che molti cristiani definivano “un Satana in carne e ossa”, veterano di mille scorrerie nel Mediterraneo, rapitore di innumerevoli donne e giovani uomini sulle coste del Tirreno dalla Calabria a Marsiglia?
Di fatto, quel ragazzino era più elbano che “barbaresco”, essendo figlio di Emilia d’Hercole, rapita dal Barbarossa in una precedente invasione dell’isola, nel 1534: dopo aver raso al suolo il villaggio di Gràssera, da allora mai più ripopolato, occupò l’abitato di Rio dove, tra i tanti catturati, c’era la giovane Emilia. L’ammiraglio ottomano l’aveva “donata” a Sinan, che ne avrebbe fatto la Favorita del suo harem, stuprandola e mettendola incinta. L’anno seguente Sinan Rais risiedeva a Tunisi, espugnata da Khayr al-Din: il governatore Muley Hassan, della dinastia berbera degli Hafsidi, alleato degli Spagnoli, era stato spodestato grazie a una flotta d’invasione di settanta galee. L’intento del Barbarossa era fondare a Tunisi una solida base per agevolare Solimano il Magnifico nella conquista della Sicilia, e nel frattempo si dedicò ad assaltare Capri, dove incendiò il castello, poi Ischia, che devastò, quindi occupò Procida e si spinse sulle coste laziali saccheggiando Sperlonga e Fondi. A quel punto, l’imperatore Carlo V, su accorata richiesta del viceré di Napoli Pedro Álvarez de Toledo, decise che bisognava porre un freno alle mire di Solimano sulla zona meridionale della penisola italica, e soprattutto frustrare l’impeto di quella coppia di assatanati, Barbarossa e Sinan.
Carlo V d’Asburgo, re di Spagna e arciduca d’Austria – dove, nel 1529, aveva difeso vittoriosamente Vienna assediata dai Turchi capeggiati dal solito Solimano –, nonché principe dei Paesi Bassi e duca di Borgogna, blasoni a cui avrebbe aggiunto il vanto di aver concesso la cédula real per la fondazione della prima università delle Americhe, quella del Messico, allora detto Nueva España... insomma, imperatore di tanta alcurnia y linaje, organizzò un’armata di venticinquemila fanti e duemila cavalieri, da imbarcare su una flotta di ben trecentotrentacinque legni tra galee da combattimento e caravelle da trasporto. Ottenuto l’appoggio dei Genovesi, che dispiegarono una temibile squadra da guerra al comando di Andrea Doria, salpò da Cagliari il primo giugno 1535.
Sbaragliata la ben più esigua flotta ottomana, già il giorno 15 gettarono le ancore di fronte alle rovine di Cartagine – dove non si era estinta la memoria dei Romani intenti a spargervi sopra il sale – e subito cinsero d’assedio La Goletta, fortezza a difesa di Tunisi. Furono settimane di bombarde che sparavano incessantemente e di furibondi assalti all’arma bianca. Khayr al-Din si era trincerato nella fortezza con cinquecento giannizzeri della guardia personale e poteva contare su un buon numero di bocche da fuoco in bronzo. In quanto alla soldataglia, ammontava a circa novemila uomini, ma una buona parte dei nordafricani, al momento di ingaggiare battaglia, si sarebbe tirata indietro. Quando la pioggia di palle sparata da colubrine, sagri e bombarde aprì una breccia nelle mura della Goletta, un cavaliere dell’Ordine di San Giovanni si mise alla testa di un manipolo di ardimentosi e arrivò a piantare la sua bandiera sugli spalti.
Fu un primo segno di imminente sconfitta: per quanto Sinan avesse tentato tre contrattacchi, mentre Barbarossa guidava la cavalleria nell’abitato di Tunisi per respingere gli Spagnoli, l’avanzata dei cristiani era ormai inesorabile. Il non più giovane ammiraglio di Solimano, abituato da molti anni a vincere su ogni fronte, meditò una rappresaglia feroce: aveva fatto ammassare circa settemila schiavi cristiani nei magazzini del sale e propose ai suoi di farli saltare in aria seppellendoveli dentro. Fatto singolare, fu proprio colui che i cristiani ritenevano un “satanasso” a salvarli: Sinan si rifiutò di accend...