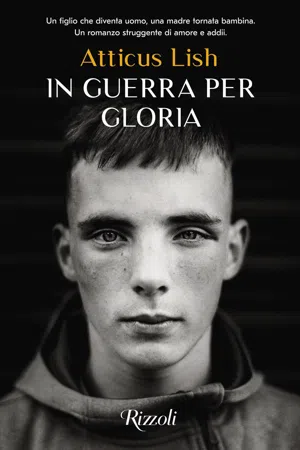Non si pensa mai ai nervi e al respiro. Lo si dà per scontato, il respiro. Si danno per scontati i nervi sotto la propria pelle o sotto la pelle di un altro animale.
Sua madre gli voleva bene. Diceva: «Mi fai ridere». Gloria sapeva cogliere il lato umoristico della loro vita, a quanto pareva. Era una madre single e lui l’aiutava a mettere insieme una biblioteca per le strade di Boston e non se ne lamentava mai. Insieme spulciavano casse di libri e condividevano le loro scoperte. Il ragazzo non si annoiava mai, neanche di vivere in macchina.
Gloria veniva da Springfield, che chiamava la sua piccola città di merda. Era arrivata a Boston per andare al college. Voleva seguire le orme di Germaine Greer, l’autrice di Sesso e destino. Mise al mondo Corey al Mass General Hospital durante quello che avrebbe dovuto essere il suo ultimo anno di studi.
Finì a Cleveland Circle, Jamaica Plain, Mission Hill – lei, il figlio e un turbinio di coinquilini. Per qualche tempo vissero in una villetta a schiera a Dorchester e lui frequentò una scuola in cui una buona metà degli altri bambini veniva dalle isole del Capo Verde. Corey mostrò alla madre le isole sulla cartina, Boa Vista e Santiago, al largo della costa senegalese, e le disse che un giorno, da grande, avrebbe preso il largo e ci sarebbe andato.
Aveva afferrato il concetto di nave vivendo nell’auto di sua madre. Ci aveva familiarizzato molto presto. Forse l’aveva sempre avuto in testa, uno dei concetti fondamentali con cui era nato – donna, terra, sole, barca.
Il suo nome completo era Gloria Goltz. Nella mente del figlio era sempre biondissima. Credeva che avesse la mandibola di vetro – la sistemava in continuazione e in continuazione si rompeva. Quando si trattava di lui, però, era fortissima. Una volta lo portò a un Kentucky Fried Chicken e il direttore non voleva darle un altro biscotto non previsto per la sua ordinazione, ma lei insistette perché Corey adorava i biscotti – aveva letto che i marinai mangiavano gallette e maiale salato – e il direttore con le braccia magre e la camicia a righe finì per cedere.
«Mamma, mi dai sempre qualcosa.»
«Tu non chiedi mai niente.»
Gloria e Corey tagliarono i biscotti sul vassoio di plastica marrone e li mangiarono con burro e miele.
«Ti dispiacerà quando divento marinaio?»
«Oh, no. Ma voglio che tu sia un marinaio intelligente. Non voglio che tu sia uno stupido.»
«Ma ti dispiacerà quando dovrò andarmene da casa?»
«Dovrò farmene una ragione.»
«Tornerò a trovarti. I viaggi durano circa tre anni, di solito. Quelli delle baleniere anche fino a sette.»
Seguivano uno schema, fra loro: lei cadeva in depressione e lui l’aiutava. Cadeva in depressione pensando a se stessa. Non aveva realizzato le sue ambizioni di diciassettenne, quando fumava una sigaretta davanti al dormitorio di cemento del Lesley College, all’ombra di Harvard – precisamente all’ombra della sua biblioteca di legge a forma di lapide e coperta d’edera –, di pensare e scrivere e stupire il mondo, condannarlo, sintetizzare tutte le prove disponibili – arte, storia, film, pellicole fotografiche e messaggi dei media, la sua educazione, il suo corpo allo specchio, i suoi pensieri, perfino le minime cose, come la sigaretta che aveva in bocca – in un solo urlo di rabbia contro il patriarcato. Invece aveva fatto la cameriera, la barista, a raccogliere le bottiglie sul bancone dopo la chiusura, mentre la band staccava gli amplificatori ed era troppo tardi per fare altro che non fosse dormire fino al giorno dopo. Ed era andata avanti così per anni – anni in cui si diceva che stava trovando la sua voce, che si stava preparando –, anni a leggere senza scrivere, pomeriggi di intontimento, un libro femminista fra le mani sulla T, Sesso e destino, Doc Martens ai piedi, a leggere all’Au Bon Pain, a saltare su dalla sedia intrecciata e mettersi in punta di piedi sugli stivali di pelle rossa per abbracciare i musicisti di strada che arrivavano coi piccioni, le chitarre, le bombette in testa e i trench militari tedeschi, gli effluvi del bagno dietro l’angolo e gli strani tipi che giocavano a scacchi tutto il giorno; i barboni di Seattle, gli skinhead in bretelle che facevano il saluto per strada, un taglio da moicano sbiondito grande come la lama circolare di una segheria su una testa magra e pelata, ragazzini delle ricche città di Concord e Lexington che esploravano nuove identità di orfani amareggiati, di notte un branco multietnico di giovani lupi di Dorchester, fra cui quello bianco con la scritta THAT FUNKY CYPRESS HILL SHIT sulla maglietta, lì per vendere droga. Le sue gambe sottili. Aveva mollato la scuola. Si era aggirata per il Pit di Harvard Square, seduta a gambe incrociate con le calze a righe sul muretto di granito, il mascara sugli occhi, il rossetto nero sulla bocca, a discutere con altri anarchici, a mostrare il dito medio alla piazza – alla banca, ai mattoni, alla Coop, all’orologio, al privilegio e all’ipocrisia. L’urlo di rabbia era rivolto a se stessa.
Sicché a volte, col passare degli anni, Gloria si guardava e il peso del tempo e la realtà della sua condizione la colpivano, si faceva una canna e chiedeva: «Mi andrà mai bene?». E per qualche ragione suo figlio le rispondeva: «Dai, mamma, non essere triste. Sei una grande. Più grande di quello che credi».
Gloria non si limitava a raccogliere cose; ne abbandonava anche. Non poteva tenerle, quando traslocavano. Perdevano i giocattoli del figlio, i suoi vestiti. Lei ci teneva più di lui, per quegli stupidi soldi. Nel periodo in cui dipingeva si fece un autoritratto e lo lasciò in uno sgabuzzino di Jamaica Plain. Anche delle poesie. Sulla parete bianca di una stanza, in una casa affittata da altri, aveva scritto con il pennello: PERDONATE. QUESTA È L’INDISCUTIBILE VOCE DI DIO. CHE LA VOSTRA VISTA E IL VOSTRO UDITO VENGANO DALL’IO TOTALE. Aveva perso e guadagnato. Uno scambio con la città. Un andirivieni. La parola chiave era tanti – lavori, coinquilini, letti, pensieri –, talmente tanti che ci voleva uno storico per ricordarli tutti. Ogni anno era una ministoria che costringeva a distacco e sorpresa. Le sue ossessioni e le ricerche di soluzioni duravano un po’ e si esaurivano – anch’esse una schiera. E poi lei ci tornava su come avrebbe potuto tornare in un negozio di dischi usati di Allston. Poteva scrivere una canzone o riprendere in mano i pennelli, e la sensazione che provava per qualche tempo le faceva pensare che non avrebbe mai dovuto smettere, che farlo era stato il suo errore più grande; lì c’era la risposta, dopotutto.
Man mano che cresceva, il figlio cominciò a sviluppare lineamenti affilati da adolescente. A lei ricordava un’ascia primitiva, di pietra scheggiata come quelle degli Algonchini, per esempio. Aveva il cranio piccolo, tondo e aerodinamico di un ghepardo. Il volto – naso, mascella, narici, mandibola – proteso in avanti come il muso di un cane; un antropologo l’avrebbe definito prognato. I capelli biondi corti simili a una cuffia stretta sulla testa, ricordavano quelli di Giulio Cesare o di Eminem. E aveva le lentiggini.
Eccola la sua poesia, pensava. Come aveva fatto a dimenticarsene?
Era già una donna magra, come se le cose fondamentali tipo il cibo o l’amore le fossero già state portate via quando ne aveva bisogno. Ma così aveva scelto di mangiare: era vegana. Forniva la solita duplice motivazione: era più sano per lei/meglio per il pianeta. L’allevamento distrugge le foreste, inquina i fiumi, contribuisce all’effetto serra. Il suo bel mondo azzurro di vento, aria, foreste era in ritirata di fronte al rovente, rosso, urlante mondo di morte del sanguinoso macello.
Aveva paura della rabbia o del corpo di suo padre? O al cuore di tutto c’era il suo odio per il proprio sangue e la propria carne – quella goccia di sangue sul pavimento del bagno? O poteva dipendere dalla genetica. Era senza seno e con le spalle strette, perfetta per lo yoga.
Yoga, lo sapeva, era una parola indoeuropea che significava «giogo» – sottomettere allo stesso giogo il corpo e lo spirito mediante il respiro. Il respiro conteneva l’energia chiamata prana. Il prana circolava nel corpo come una corrente marina. La circolazione della corrente-prana manteneva sano il corpo, così come la circolazione delle correnti marine manteneva sano il pianeta. Se si fermassero le maree, la terra morirebbe.
La circolazione era come il sangue, ma non era il sangue. L’energia fluiva attraverso i meridiani d’argento e un sole che non era il sole ardeva nel plesso sacrale. Era una luna. Per lei sacrale voleva dire «sacro», la sacra luna femminile.
Le uova si potevano mangiare, purché fossero prodotte umanamente.
Queste erano alcune delle sue convinzioni allorché si avvicinava al termine della sua vita.
Aveva lunghe gambe bianche e quando si metteva i fuseaux e faceva yoga le si vedevano le costole e le vertebre fino al cranio, con i rami anteriori dei gangli cervicali.
I ricordi di lui erano frammentari e disordinati. Se si addentrava nel mare dei suoi ricordi, trovava una serie di isole sparse, come biscotti sbriciolati, e nessuno era il primo, non c’era alcun ordine cronologico.
In uno dei suoi primi ricordi vedeva sua madre in una cucina e sentiva odore di fumo e di formaggio bruciato. Lei indossava un grembiule enorme. Aveva le braccia nude, le ascelle non depilate, si intravedevano i seni. Stava cuocendo würstel di tofu in una padella. I suoi capelli biondi erano coperti da una bandana come quelli di Zia Jemima sulla scatola dei pancake. Per terra c’erano dei sacchetti di carta marrone, pieni di foglie di tè e di bucce di carota. Si sentiva l’odore della carta umida dei sacchetti.
Gloria si sedeva per terra con lui e metteva le gambe nella posizione del loto. Un cane ansimante entrava e leccava la padella mentre loro mangiavano, e lei lo abbracciava e gli dava un würstel di tofu.
Vivevano con dei musicisti che avevano barbe bionde e ricce, dreadlock biondi e dilatatori di legno nei lobi delle orecchie come il Gautama Buddha. Sembravano gli Spin Doctors nei video di Little Miss Can’t Be Wrong e Two Princes – uomini bianchi alti, dinoccolati, che dicevano che il loro sogno era metter fine al razzismo.
Abitavano in un brutto quartiere – l’appartamento doveva essere a Mission Hill – e avevano paura di essere derubati. Corey dormiva da solo in una stanza sul retro dove i musicisti tenevano gli strumenti. La sua brandina era davanti a una finestra con le sbarre di protezione; la finestra dava su un vicolo. Qualcuno era salito dalla scala antincendio e aveva tentato di entrare per portare via le chitarre e le batterie dei musicisti mentre sua madre era in casa da sola.
Corey si ammalò e dovette restare a letto per molto tempo. Mentre era sdraiato lì, sua madre entrò, si arrampicò sul davanzale e si mise in punta di piedi per appendere sopra di lui delle bandiere di preghiera tibetane. Piantò dei chiodi nel soffitto e assicurò i fili delle bandiere ai chiodi. Il sole entrava dalla finestra con le sbarre e splendeva attraverso il suo vestito.
Gloria prese dai musicisti un televisore e lo mise ai piedi del letto. Lui guardò un cartone animato intitolato Action Man. I supereroi erano atleti formidabili e davano la caccia a uno scienziato malvagio che aveva uno yacht di lusso armato di un missile nucleare. L’eroe faceva sci d’acqua dietro a un motoscafo con propulsione a razzo che si trasformava in un sottomarino. Sfrecciava sott’acqua e aggirava a tutta velocità una barriera corallina. Guizzava fuori dall’acqua e si trasformava in un aereo da guerra. Sbandando per la forza di gravità, l’eroe solcava gli elementi – acqua, aria e terra – con la scia che si allungava dietro di lui. Il suo successo dipendeva dal controllo acrobatico del fisico. Si verificavano degli incidenti: le macchine da corsa finivano in testacoda, gli aerei precipitavano, e lui doveva espellersi. Quando l’eroe rimaneva ferito, diceva che il suo braccio era messo male. Usava quello ancora sano per risolvere la situazione. «Metticela tutta, Action Man!» dicevano i suoi compagni. Corey amava il loro modo di parlare. Le loro voci erano così forti e sicure.
C’era qualcosa che toccava Corey nel modo in cui Action Man parlava del suo braccio ferito come se fosse il pezzo di un ingranaggio che si poteva riparare. L’espressione messo male circoscriveva il danno, lo limitava a un arto, mentre dire «sono ferito» potenzialmente implicava l’intera persona e tutta la sofferenza che poteva provare, solitudine e paura comprese.
Mentre era ammalato aveva fatto un sogno, un sogno che tornava spesso nella sua infanzia. Immaginava di essere intrappolato in uno sgabuzzino di legno; lui era molto piccolo e non poteva uscire. Sua madre era davanti alla porta chiusa a chiave e lui non poteva raggiungerla; era bloccato dentro – o fuori, piuttosto –, bloccato lontano da lei. C’era un silenzio soffocante. Tentava di uscire dalla finestra, ma non riusciva a raggiungere il davanzale. Sapeva che sua madre era in difficoltà perché sentiva la sua voce supplichevole – la persona a cui si rivolgeva però non voleva ascoltarla. La casa era fatta di pino laccato, che poteva prendere fuoco e ridurli in cenere in un attimo. L’aria era infiammabile per i vapori di trementina. Erano isolati in campagna, a chilometri da qualunque soccorso.
Il sogno non se ne andava. Sembrava un ricordo. Lui era convinto che fosse un frutto dell’immaginazione dovuto alla febbre, ma non era mai sicuro che non fosse reale.
C’era sempre qualcosa che avrebbe dovuto sapere, ma che per qualche ragione ignorava. C’era sempre stato un mare che non riusciva ad attraversare nella sua mente.
Ricordava sua madre che da piccolo lo portava a una prima comunione nella cripta di una chiesa. Dove fosse la chiesa, non avrebbe saputo dirlo; da qualche parte vicino a Boston, forse a Saugus. Ricordava di aver chiesto a sua madre che cos’era una comunione e Gloria gli aveva detto: «È una cerimonia religiosa cattolica». Si era messa i tacchi alti e il rossetto per l’occasione. Alla festa avevano conosciuto un uomo. Tutti stavano in piedi accanto a un tavolo con ciotole di patate in insalata e vassoi di panini e palloncini di elio, tranne l’uomo, che si teneva da parte, non come un ospite, ma come se fosse il custode, lì. La madre disse a Corey di salutare, di non fare il timido. L’uomo gli rivolse la parola e Corey non capì quello che diceva. L’uomo spiegò che era perché gli stava parlando in alfabeto farfallino.
Gloria invitò l’uomo a casa loro per una partita a scacchi. Corey chiese chi era e lei...