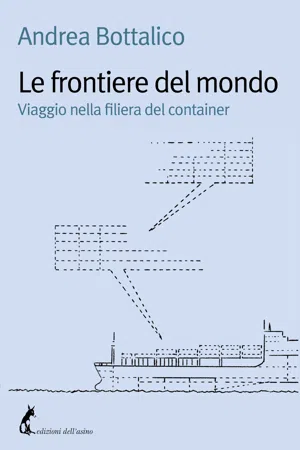![]()
Genova
Il signore che ho di fronte mi squadra dalla testa ai piedi dopo aver preso il documento d’identità. Guarda la foto, poi guarda me, poi riguarda la foto.
Nell’attesa di attraversare il varco mi guardo intorno. Da un lato Sampierdarena. Dall’altro un mondo blindato e un movimento che a quanto pare va avanti da secoli: gente che muove o manipola merci per conto di qualcun altro. Alle mie spalle i camion entrano ed escono dal varco, carichi o scarichi, coi rimorchi o senza. Navi alla rada o in banchina e ovunque recinzioni e cancellate, cisterne e mezzi meccanici. Silos. Uomini con gli abiti catarifrangenti sporchi, puzza di nafta. Un rumore di fondo di motori accesi e sirene di ralle in movimento. Si alzano nuvole di fumo e il sole brucia l’asfalto.
Qualcosa si nasconde nella penombra di questo sottobosco, si sottrae allo sguardo fino a scomparire al di qua dei divieti di accesso. A prima vista sembra uno spazio con delle attività opache, con le sue operazioni soggette alle inesorabili leggi dell’economia, con i suoi implacabili mutamenti e la sua comunità umana che ci ruota intorno. Si dà un tono misterioso, questo luogo. E intanto le tracce della Merce fuggono via. Ognuno la trova ovunque e nessuno la vede arrivare. Sono già oltre il varco coi miei pensieri quando il signore che ho di fronte mi passa il documento e mi fa un cenno con la testa: “Può entrare”.
I protocolli di sicurezza dopo l’11 settembre 2001 hanno reso difficile l’accesso. Le banchine sono frazionate come tanti lotti di terra, date in concessione a operatori logistici più avidi dei vecchi proprietari terrieri, privi di quella che gli addetti chiamano con un eufemismo “cultura della trasparenza”. Una volta ottenuta la concessione di una banchina, è come se si barricassero dentro alle stesse recinzioni che hanno alzato con l’aiuto dei loro agrimensori. Sulle reti metalliche appendono cartelli: vietato l’accesso. Ho appena attraversato la prima frontiera di una fortezza ermetica e inespugnabile, i cui padroni sono noti per il loro profilo basso e la proverbiale filosofia di vita secondo cui una parola è poca e due sono troppe. Bisogna quindi avere una ragione precisa per giustificare l’accesso. Ci vuole il cavallo di Troia. L’ambiente è chiuso come quello di una massoneria, coi suoi simboli e i suoi rituali, per cui delle due l’una: o appartieni all’ambiente o non appartieni ma qualcuno ti offre un lasciapassare temporaneo, una giustificazione valida e credibile. E quel lasciapassare ti definisce e t’identifica al cospetto dell’ambiente, come una faccia tagliata in mezzo alla folla.
È stato il professore a farmi entrare, e se non fosse per lui a quest’ora sarei ancora senza una chiave, alla ricerca della serratura, a guardare verso la linea dell’orizzonte e a camminare avanti e indietro per venti chilometri di costa in cerca di un appiglio per cominciare. A guardare il porto al tramonto con la stucchevole sensazione di provare un qualsivoglia sentimento. Malinconia a occhio e croce. Tutte banalità. Il porto è una macchina inesorabile, una miniera infernale. È l’immagine stessa del capitalismo globale nel ventunesimo secolo. Chiudi il libro di poesie. Apri quello di gestione aziendale. In inglese suona meglio, fa scattare l’immaginario: supply chain management.
L’ho conosciuto da poco e mi sono un po’ informato sul suo conto. Da quel che ho capito è considerato da molti come un vecchio saggio. Frequenta l’ambiente dagli anni Settanta e gode del rispetto del portuale, del sindacalista, del funzionario e del dirigente. Le sue competenze in passato lo hanno portato fin dentro al Comitato scientifico della consulta per l’autotrasporto e la logistica, un organismo di pianificazione strategica istituito nell’ambito del ministero delle infrastrutture, di cui al momento ignoro la precisa funzione.
Il professore a quanto pare conosce chiunque. Dopo tutti quegli anni è diventato un esperto dotato di spirito critico e iconoclasta. Ha viaggiato per i porti, i distretti logistici e le infrastrutture di trasporto di mezzo mondo, ha svolto consulenze per organismi pubblici e privati, studiato ogni dettaglio e incontrato tanti esperti del settore come lui. Ha accumulato anni di esperienza. Appartiene alla vecchia scuola, il professore. Tra le tante cose che ha scritto e che dovrò prima o poi costringermi a leggere, una in particolare ha colpito la mia attenzione, forse perché non ha niente a che vedere con questa faccenda. È una recensione al film di Wim Wenders che ha per protagonista un marinaio dell’asfalto. Un camionista e riparatore di proiettori. A quanto pare da giovane il professore aveva la fissazione dei camionisti.
La chiave per entrare me l’ha data durante una conferenza nel palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale di Genova. Mi ha dato appuntamento là dopo che gli ho scritto una mail di presentazione. Ha risposto subito e in maniera perentoria, indicando il luogo e l’ora del nostro incontro.
Così ho fatto. Ho preso il treno da Milano e sono arrivato a Genova. Da piazza Principe ho camminato lungo via Balbi e poi in direzione del porto antico tagliando per le vie del centro. Sono arrivato fuori a questo edificio mezzo medievale e mezzo rinascimentale nei pressi del molo, a due passi dal porticato di Sottoripa e di fronte a una sopraelevata che taglia la vista verso il mare. Ho ammirato per qualche minuto la facciata dell’edificio, poi sono entrato e ho ricevuto l’accoglienza di una giovane che mi ha invitato a prendere alcuni dépliant sul programma della conferenza. Ho intravisto un ricco buffet prima di entrare in un’ampia sala luminosa, affollata e affrescata, dopodiché ho preso posto in fondo.
Il tema della conferenza era la riforma della governance nel sistema portuale italiano. Il parterre era composto da addetti ai lavori, funzionari, burocrati, sindacalisti, qualche politico. Seduti in prima fila, degli uomini attempati in giacca e cravatta armeggiavano sui loro tablet nell’attesa che gli attori entrassero in scena. Erano i rappresentanti delle associazioni di categoria. A un certo punto il sottosegretario ai trasporti si è alzato in piedi e ha raccolto i fogli sparsi sul tavolo davanti a sé. Il brusìo di voci è calato di colpo. Il fisico slanciato, i capelli bianchi ben pettinati, l’abito impeccabile, il sottosegretario si è schiarito la voce con un colpo di tosse e si è rivolto alla platea: “Vengo subito al dunque perché purtroppo non potrò trattenermi a lungo con voi. L’obiettivo di questa iniziativa parte da un presupposto che tutti noi conosciamo: il nostro paese è notoriamente caratterizzato da inefficienza logistica. Non esiste, per intenderci, un made in Italy della logistica. In questa legislatura abbiamo cambiato approccio, abbiamo sbloccato la costruzione di importanti infrastrutture. Certo, la congiuntura economica non è ottimale, ma bisogna guardare avanti e pensare positivo. I tempi della politica non coincidono con i tempi di realizzazione delle infrastrutture. Il nostro obiettivo è di individuare le azioni prioritarie. Siamo convinti che aumentando l’efficienza logistica riusciremo a recuperare quote di traffico che oggi, purtroppo, stiamo perdendo, perché i nostri concorrenti nel nord Europa sono più competitivi di noi. È indispensabile condividere questi obiettivi con esperti e addetti ai lavori per poi riuscire a proporre alla politica ragionamenti concreti, un disegno attraverso il quale la logistica diventi fattore di sviluppo. Ecco perché siamo qui oggi. La riforma della governance portuale è un primo passo. Abbiamo una responsabilità nei confronti del Sistema Paese e del futuro”.
Gli applausi al termine del discorso hanno ridestato dal torpore quelli che fingevano di ascoltare nelle ultime file. Il professore sembrava non perdere di vista il parterre, le presenze rilevanti e degne di nota. Qualche giornalista scattava le foto. A quel punto il moderatore ha dato la parola ai rappresentanti delle associazioni di categoria, in una modalità che sembrava piuttosto una conversazione da salotto.
Il dottor Chiaffredo Arcese, presidente dell’associazione nazionale imprese trasporti automobilistici, ha preso la parola per primo. Basso e paffutello, le gambe accavallate e un sorriso smaliziato sul volto, Arcese si è tolto gli occhiali, ha salutato gli astanti e dopo un lungo panegirico ha chiesto al sottosegretario se fosse possibile sapere qualcosa di più rispetto al provvedimento sulla riduzione del costo del lavoro.
“Ci stiamo lavorando” ha risposto quello perentorio, evidenziando così quanto il tema fosse scivoloso e controverso. Gli attimi successivi di silenzio hanno creato un po’ d’imbarazzo, il dottor Arcese si è guardato intorno, con il microfono in mano che non sapeva a chi dare. Il moderatore sembrava dormire. Nel giro di qualche secondo altri hanno alzato la mano in prima fila chiedendo chiarimenti in merito a fondi predisposti per il settore dell’autotrasporto, preoccupazioni relative alla finanziaria, agli interporti, alle norme, alle intenzioni del governo rispetto al finanziamento di certe infrastrutture, agli incentivi sulla digitalizzazione. Qualcuno ha accennato alla nuova Via della Seta e agli investimenti cinesi, qualcun altro ha ricordato che il tema della conferenza era un altro.
Non capivo niente, ma quelli che dovevano capire, in prima fila, hanno capito che la presenza del sottosegretario era una buona occasione per discutere su come e dove spendere i soldi e dividere i budget in un settore frammentato tra spedizionieri, autotrasportatori, operatori logistici, terminalisti portuali, armatori, ognuno con poteri e interessi diversi e contrastanti, in perenne conflitto tra loro.
Il sottosegretario aveva la capacità di schivare ogni colpo e di soddisfare con quelle sue risposte nette i rappresentanti dei diversi settori. Ma forse erano quelle domande a dire più di ogni sua risposta, perché da quelle domande si riusciva a percepire il polso della comunità imprenditoriale, i malumori e le aspettative, le pressioni dell’ambiente. Le sue risposte spaziavano dal consueto “ci stiamo lavorando” al più diretto “il governo prenderà in considerazione questa ipotesi”, ma nel frattempo prendeva appunti.
Dopo vari botta e risposta ha chiesto la parola l’ingegner Emilio Ruffini, presidente della confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica. Ho notato a quel punto che il professore ha iniziato a prestare attenzione non appena ha sentito il suo nome. Un personaggio eccentrico con una cravatta sgargiante ha preso il microfono in mano. Un’eccentricità che, a dire il vero, mi ha dato l’impressione di nascondere una mente raffinata e piuttosto fredda, dotata di razionalità economica e abilità strategiche. Una figura perfetta per rappresentare gli interessi degli operatori portuali in quell’ambiente di squali famelici. “Innanzitutto vorrei esprimere l’apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dal sottosegretario”, ha detto l’ingegner Ruffini con un tono di voce nasale e un accento napoletano. Un giornalista gli ha scattato una foto a distanza ravvicinata. “Dal mio punto di vista però mancano due punti fondamentali: primo, i finanziamenti. Negli ultimi anni il governo ha sottratto ai porti cinquanta milioni di risorse. Secondo, l’inefficienza lungo la filiera del trasporto. Dobbiamo lavorare per ottimizzare le varie soluzioni e per favorire l’integrazione. Se consideriamo l’intera filiera, vediamo che movimentare un container in un porto italiano costa molto di più che in nord Europa. Allora mi chiedo: dove sta l’inefficienza? Se non si parte da un’analisi corretta della filiera diventa difficile mettersi d’accordo sui provvedimenti da adottare e sulle risorse da distribuire”.
Degli applausi sono partiti da una parte della platea, mentre altri hanno espresso qualche tacito dissenso tramite scambi di occhiate e smorfie di disapprovazione. L’intervento di Ruffini alle orecchie di alcuni uomini seduti nella fila davanti alla mia è suonato come una frecciata. Con chi ce l’aveva? Inefficiente a chi?
È intervenuto di nuovo il sottosegretario, che si è alzato, ha atteso che gli applausi e il vociare terminassero e ha detto: “Il governo sta lavorando sull’analisi dei dati relativi allo stato di salute dei trasporti e della logistica in Italia. Abbiamo un anno a partire da ora”.
Alla fine della conferenza sono andato verso il professore e il buffet, preso d’assalto dalla folla che sgomitava per accaparrarsi le focacce calde tagliate a strisce. Alto almeno un metro e novanta, gli occhi chiari, inespressivi e disincantati ma vigili, sembrava che il tempo non gli avesse fatto pagare il debito. Ottant’anni, aveva l’aria distaccata di chi sente di non appartenere più a questo mondo. Gli acciacchi non mancavano, ma tutto sommato sembrava in forma e, almeno all’apparenza, di buon umore.
Forse era sarcasmo. Conosceva a fondo l’ambiente e i retroscena di ciascun intervento, ed è probabile che mi abbia da...