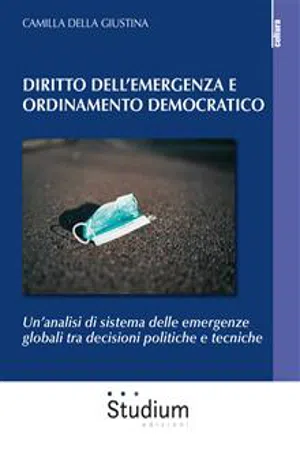Nel momento in cui ci si approccia alla nozione [1] di “stato di eccezione”, è necessario rapportarsi con diverse definizioni possibili, determinate dalle diverse sensibilità giuridiche e politiche nonché dalle diverse interpretazioni giuridiche, filosofiche e politiche.
Partendo dalle prime, si nota che la giuspolitica germanica utilizza il concetto di Ausnahmezustand [2] , la dottrina inglese preferisce l’utilizzo di termini quali martial law [3] , emergency power e l’ordinamento italiano, infine, allude alla nozione di decreto d’urgenza. L’espressione “stato di eccezione» viene altresì utilizzata per indicare il fenomeno caratterizzato dall’ampliamento del potete dell’esecutivo che si traduce nella possibilità, per quest’ultimo, di adottare decreti aventi forza di legge [4] .
Per quanto concerne l’interpretazione giuridico-filosofica, è da segnalare come diversi filosofi e giuristi abbiano fornito la propria interpretazione dello stato di eccezione.
Il primo a cui fare riferimento è Carl Schmitt il quale sostiene come, lo stato di eccezione, non può essere assimilato al concetto di dittatura ma diviene anche espressione di una sospensione del diritto. A questo si deve aggiungere il rapporto intercorrente tra stato di eccezione e sovranità [5] : il sovrano è colui che decide sullo stato di eccezione. Il paradosso che emerge, nella ricostruzione schmittiana dello stato di eccezione, è che questo sembra essere sottratto dal “mondo” del diritto e appartenere a una dimensione extra-giuridica [6] . Al fine di superare questa possibile antinomia Schmitt distingue tra dittatura commissaria e dittatura sovrana.
La prima sospende l’applicazione concreta della Costituzione conservandone il vigore formale, la seconda è incardinata sul rapporto tra potere costituente [7] e potere costituito: il primo «ha con ogni costituzione vigente un nesso tale da apparire come potere fondante [...] un nesso tale da non poter essere negato neppure nel caso che la costituzione vigente lo neghi» [8] .
A questo si deve aggiungere un’ulteriore distinzione ossia, quella tra norma [9] e decisione. Per il giurista tedesco, la struttura del diritto è composta da questi due elementi che coesistono in una situazione ordinaria a vantaggio della norma riducendo, quindi, al minimo il momento della decisione. Codesto rapporto, fondato sull’equilibrio appena descritto, viene spezzato dallo stato di eccezione il quale fa assumere alla decisione piena autonomia [10] . Il sovrano, titolare del potere decisionale, nel momento in cui esercita questa sua prerogativa, decidendo sullo stato di eccezione, garantisce l’osservanza e la continuità dell’ordine giuridico.
Si nota come – nella decisione assunta dal sovrano relativa allo stato di eccezione – la norma risulta essere quasi annullata rispetto alla decisione. Si concretizza, infatti, una situazione caratterizzata dalla vigenza della norma sospesa: «l’elemento della norma non ha più alcun legame con la realtà concreta, semplicemente perché non si applica, e cioè privata della sua forza, e al suo posto sono prodotti dal potere sovrano altri atti (decreti e regolamenti emanati dall’esecutivo), che non hanno valore di legge, ma che tuttavia hanno la forza della legge, e si impongono con la stessa intensità ed efficacia di questa» [11] . In altri termini, durante la vigenza dello stato di eccezione, si assiste a una frattura, a una scissione, tra il testo della legge e la sua forza vincolante, determinando la vigenza della norma separata dalla sua applicazione.
Il potere sovrano mostrerebbe la propria autentica natura durante lo stato di eccezione: durante la vigenza di quest’ultimo si assiste a un ricongiungimento dei vari aspetti del potere nelle mani di un unico soggetto decidente. Se in base al principio della divisione dei poteri, tipico degli ordinamenti democratici, il potere sovrano risulta essere “frazionato” tra i diversi organi competenti all’esercizio delle attività sovrane, «nello stato di eccezione, invece, si assisterebbe alla riunione dei poteri sovrani in capo a un unico organismo o individuo, che per via della situazione di urgenza potrebbe spingersi sino a decidere la sospensione di certi diritti, fra cui eventualmente, ove la situazione lo rendesse necessario, i diritti fondamentali delle persone» [12] .
Nella ricostruzione di Schmitt, lo stato di eccezione è interpretato quale antidoto alla degenerazione dell’ordine politico [13] il quale potrebbe aggravarsi, a sua volta, in una situazione di ingovernabilità o di indecidibilità. L’eccezione viene interpretata quale limite [14] , come unica possibilità per poter riaffermare il primato di un ordine politico [15] . In questa direzione, l’unica figura capace di porre un limite [16] alla possibile degenerazione è il sovrano il quale, tramite la propria decisione, pone l’ordinamento giuridico in una sospensione diretta a preservare e riaffermare, simultaneamente, l’ordinamento medesimo.
Da questo deriva che, sovrano non è solamente colui il quale decide che cosa fare nel momento in cui si verificano eventi estremi che non possono essere gestiti tramite le competenze normativamente presenti ma, è anche colui il quale decide se vi sono eventi di questa tipologia [17] . In altri termini, «lo stato d’eccezione rivela il sovrano, sia nel senso che lo costringe ad uscire allo scoperto sia nel senso che ne testimonia la illimitata forza creatrice. Sicché lo stato d’eccezione può essere creato dal sovrano. In ogni modo, è pur sempre lui a stabilire se vi sia oppure no: e la differenza tra dichiararne e volerne (o determinarne) la presenza è dapprima impalpabile per poi svanire del tutto, come vedremo meglio tra un po’» [18] . A tal fine non è sufficiente una mera decisione del sovrano ma la possibilità per lo stesso di essere confermato come tale, di vedere fortificata la propria volontà e questo grazie all’attività svolta dai public officials i quali applicano le regole costituite in precedenza.
La complessità del concetto di stato di eccezione dipende anche dalla circostanza in base alla quale esso «è ancorato qualcosa di diverso dall’anarchia o dal caos» poiché «dal punto di vista giuridico esiste ancora in esso un ordinamento, anche se non si tratta più di un ordinamento giuridico»; questa permanenza viene ritenuta sussistente poiché «il caso d’eccezione resta accessibile alla conoscenza giuridica, poiché entrambi gli elementi, la norma come la decisione, permangono nell’ambito del dato giuridico» [19] .
Un altro studioso che si è occupato del tema è Herbert Tingsten il quale osservò come, l’evoluzione dei regimi parlamentari, sia caratterizzata dal ricorso sempre più frequente a leggi delega che estendono al potere esecutivo i pieni poteri. La situazione che si realizza è connotata da una contraddizione tra la realtà e la gerarchia che si materializza tra legge e regolamento tipica delle costituzioni democratiche. Si assiste a uno stato di eccezione radicatosi non solo come prassi ma anche tecnica di governo e questo non solamente in paesi aventi governi autoritari ma anche all’interno di democrazie liberali [20] .
La distinzione tra dittatura costituzionale e incostituzionale viene ripresa da Carl J. Fiedrich il quale giunge a sostenere che «non vi è alcuna salvaguardia istituzionale in grado di garantire che i poteri di emergenza siano effettivamente usati allo scopo di salvare la costituzione. Solo la determinazione del popolo stesso nel verificare che siano usati a questo scopo può assicurare di ciò. Le disposizioni quasi dittatoriali dei sistemi costituzionali moderni, siano esse la legge marziale, lo stato di assedio o i poteri di emergenza costituzionale, non possono realizzare controlli effettivi sulla concentrazione dei poteri. Di conseguenza, tutti questi istituti corrono il rischio di essere trasformati in sistemi totalitari, se si presentano condizioni favorevoli» [21] .
Solamente con l’elaborazione teorica di Clinton L. Rossiter le contraddizioni, proprie dello stat...