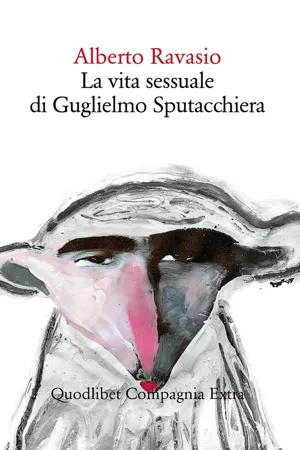1.
Il transessualizzato
Un mattino d’agosto Guglielmo Sputacchiera si svegliò col muso sprofondato in un bel paio di seni: i suoi. In otto ore di sonno s’era trasformato in donna, creatura a lui sconosciutissima, che in trent’anni di vita non era quasi mai riuscito ad avvicinare, non dico per le acrobazie pubiche, ma anche solo per le
informazioni stradali.
In posizione fetale, sul suo lettino a mezza piazza, Sputacchiera si svegliò poppando il suo stesso capezzolo, e nel traslocare dal sonno alla veglia s’accorse che qualcosa, anzi praticamente tutto non andava. Al posto dello sterno introverso c’erano due seni espansivi, invece del capello maltagliato era sbocciata una chioma boscosa. Mani e piedi s’erano rimpiccioliti, mentre il culo da quadrato s’era fatto sferico e si dava arie, per il momento solo estetiche.
Per convincersi che non fosse un sogno avrebbe dovuto pizzicarsi le guance, le natiche, cercare testimoni, oppure poteva restarsene a letto, disdire il suo ateismo e pregare a vanvera perché qualcuno lassù in cima, Cristo, Allah, un asteroide sterminatore, facesse qualcosa.
A vincere la paura però, spingendolo ad alzarsi, non fu il coraggio o la curiosità, ma una paura ancora più grande. Nel vortice di quelle nuove percezioni Sputacchiera s’era scordato di un dettaglio decisivo, qualcosa che per il maschio è ben più di un organo, ben più di un amico, ma rappresenta l’ago vibrante della sua bussola vitale. Aveva perso il pene, l’amuleto erotico, il cartellino deprezzato della sua virilità.
Appena se ne accorse lasciò il capezzolo, il suo, e cominciò a scavare nelle coperte, si contorceva, rantolava, descriveva moti circolari epilettici intorno al suo centro mancante, al pene depennato.
Alzatosi, cercava ovunque nella sua cameretta, la cella amniotica in cui era stato bambino vivace, adolescente distratto, giovanotto socialmente deceduto e infine, adesso, eunuca. Cercava sotto, sopra e dentro l’armadio, i cassetti, il comodino, la scrivania, rovistava tra i libri, molti ma confusi, nella collezione di film. Controllava, e se non trovava nulla, buttava all’aria fracassando e ragliando di dolore. Strappava le tende, mangiava i cuscini.
Intanto canottiera, pantaloncini e mutande, che per lui erano ormai larghi come tendoni da circo, gli erano caduti a terra, e proprio mentre cercava e non trovava nulla, ecco che il Nulla finalmente gli apparve, nel riflesso del vetro contro le imposte, sprangate da anni: era la vulva, l’assenza onnipresente, il buco convesso che riempie gli spazi vuoti dell’esistenza.
Con la carriera sessuale dello spermatozoo finito nella carta igienica, Sputacchiera la vulva non l’aveva mai vista dal vivo, ma l’aveva seguita, da pornodipendente, nelle sue manifestazioni virtuali, e molti anni prima, quando ancora si sbeccava i denti da latte col torrone, l’aveva persino avuta sotto il naso, o meglio sopra.
I genitori lo avevano mandato dalle suore perché il cattolicesimo in paese non era una fede, ma l’unico modo di stare al mondo, una sorta di seconda respirazione, e il piccolo Sputacchiera, prima ancora dell’alfabeto, aveva imparato a ripetere le preghiere senza capirle, a inginocchiarsi al niente, a dire «Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa», respirando l’incenso, disdegnando l’oro, almeno a parole, e ignorando cosa fosse la mirra.
Più per imitazione dei grandi che per convinzione pulsionale, a sei anni aveva provato a sedurre la più bella dell’asilo, considerata tale non a causa del capello biondo fieno o del nasino allergico a tutto, ma in quanto grembiulata di rosa, e dunque simulante il nudo proibito.
Lui le aveva portato in dono le caramelle gommose e lei gli aveva concesso il privilegio di entrare nel suo spettro visivo. Anche se surriscaldati dalle rispettive presenze, i due erano incapaci di far combaciare le loro geometrie genitali e quindi avevano ripiegato sulla lotta in cortile, nella ghiaia infortunistica, ossia penitenziale, e Sputacchiera, aitante come un verme, era finito sovrastato da lei, che gli si era seduta sopra, domandolo, cavallinandolo.
Mentre rideva e s’arrossava tutta, la bambina gli aveva premuto le cosce da galletta sulla faccia, e avvolto da un buio odoroso, cosmico perché privo di ossigeno e coordinate, Sputacchiera quella cosa là non l’aveva vista, ma l’aveva sentita, sentita al di là dei sensi, come si sentiva l’amore o, per i più brutti, la chiamata in seminario.
Da quando aveva imparato ad allacciarsi le scarpe Sputacchiera aveva accumulato abbastanza neuroni per capire che lì attorno, nel paesello stercoso, era tutta una baracconata: il tabernacolo era vuoto, la vecchiaia non era saggezza e Santa Lucia era sua madre col portafoglio di suo padre.
Se dio era assente ingiustificato, le sorprese dell’uovo di Pasqua tutte doppie e anche il cioccolato era diabetico e cariante, quel pertugio doveva essere l’unica via rimasta per il tanto reclamizzato paradiso. Doveva esserlo per forza, perché, mentre stava là sotto, a fratturarsi naso e autostima, Sputacchiera si era sentito quasi felice, felice d’esserci meno, di sottrarsi, per un attimo, allo spettacolino obbligatorio della vita, in cui lui era, e sarebbe sempre stato, anonimo cespuglio scenografico.
Della vulva il seienne Sputacchiera non sapeva nulla, nemmeno il nome, ma aveva riconosciuto in lei, nel suo profumo marziano, l’unico impossibile possibile. L’aveva divinizzata, ci aveva proiettato sopra lo stupore e la devozione e lo spavento del fedele, ne era attratto e al tempo stesso ne aveva paura, ne era così attratto da averne paura. S’era fatto un vulvomane, un vulvolatra, e con quel sanissimo sentimento d’ambivalenza emotiva era partito, già storpio, per il suo pellegrinaggio verso la sessualità adulta, collezionando ultimi posti nelle classifiche di bellezza, infortuni sentimentali, aneddotica imbarazzante.
E adesso, quasi trent’anni dopo, Guglielmo Sputacchiera non solo la vedeva, in carne e carne, ma l’aveva, tatuata geneticamente al centro del suo corpo transessualizzato.
Ma il pene, il suo inseparabile portasfortuna, dov’era finito? Non c’era più: assorbito dalla sabbia mobile della vulva, macinato da quella bocca verticale. Ovunque lo cercasse, il suo medaglione era scomparso, sepolto da qualche parte, laggiù in fondo, nella caverna delle meraviglie.
Come era potuto succedere? Chi era stato? Il governo ladro, il surriscaldamento globale, un manipolo di ex compagni di scuola ingrati che l’avevano transessualizzato mentre dormiva come scherzo notturno estremo e definitivo?
La riflessione fu interrotta da un paio di nocche familiari, che percuotevano la porta.
«Apri, tesoro», intimava la madre, bipolare monoteista, «tutto a posto? Che combini lì dentro? Papà è appena uscito. Vuoi che ti prepari la colazione?»
Ah, quasi mi dimenticavo di un piccolo particolare drammaturgico: a trent’anni, disoccupato sociale e sessuale, Guglielmo Sputacchiera viveva ancora, da sempre e per sempre, coi suoi.
2.
Falluce
Alle elementari Sputacchiera aveva attraversato il freudiano periodo di latenza, si era ritirato momentaneamente dalla caccia al tesoro donnesco per curare il suo curriculum di campioncino di carte collezionabili, virtuoso dei peti sonori e vandalizzatore della proprietà pubblica paesana.
In quasi un decennio di studi futili si prese soltanto una curabile cottarella per una sua compagna delle medie, dalle lunghe trecce ramate e l’apparecchio ai denti, con la quale condivideva, oltre allo zaino punitivo a forma di triangolo retto, anche il talento per la corsa di resistenza nel letame ghiacciato di novembre.
Da quell’amore disabile il piccolo Sputacchiera ricavò: un buon numero di scene imbarazzanti, tre sniffate epifaniche nella di lei gonnellina scozzese, lasciata incustodita nello spogliatoio durante l’ora di educazione fisica, nonché l’ispirazione per i testi di due canzoni d’amore cacofoniche, tanto acusticamente letali che la notte, quando le cantava, faceva protestare i gatti, suicidare le falene.
Al liceo il ribollente geyser pulsionale, che non trovava il suo sbocco nel bacino pelvico femminile, risaliva a ritroso, come i salmoni il fiume, lungo il corpo di Sputacchiera, per poi accumularsi, coagulato e irrancidito, sul volto, sotto forma di acne.
Con un bouquet di foruncoli su naso, guance, mento e persino palpebre, il ragazzo s’era autoeliminato, come del resto quasi tutti i suoi compagni, dalla gara per la conquista delle belle della classe: un paio di ragazzine non del tutto informi dal pelo biondo, il completo ginnico rosa confetto e il comportamento turbomestruale di chi, essendosi trovata un ordigno vulvico tra le gambe, non sa bene cosa farne e nel dubbio stronzeggia oppure piange.
Dato che presto le simulazioni delle prove di maturità e la stesura delle inutili tesine avrebbero condannato alla clausura e all’imbruttimento, l’unica occasione rimasta a Sputacchiera per risolversi sessualmente era la tanto attesa gita di marzo in Austria e Ungheria, ex Impero Austroungarico, almeno secondo il manuale squarciato di Storia contemporanea.
Dopo aver visitato Vienna, delle cui bellezze gli studenti si portarono a casa soltanto le semanticamente sconce palle di Mozart, prima del trasferimento a Budapest il programma prevedeva una tappa al campo di concentramento nazista di Mauthausen, nome proprio di orrore, dal suono così nazionalsocialista che la docente di Lettere, già militaresca di suo, lo pronunciava di continuo, anche fuori contesto, per darsi autorità senza autorevolezza.
In pullman i due sessi si disponevano in nicchie biologiche separate. Le femmine, divistiche nei loro occhialoni da sole, ascoltavano musica o indossavano comunque gli auricolari per giustificare la loro apatia comunicativa verso maschi che percepivano come fratellini minori e minorati. I maschi, col cervello effettivamente lasciato in Italia, giravano filmini ai compagni in coma etilico dalla notte precedente, incappucciati, come ostaggi del terrorismo, in borse della spesa, per contenere i frequenti scrosci di vomito.
Prima di partire per Mauthausen la studentaglia venne lasciata libera per un pranzo a piacere in centro Vienna. I ragazzi, quasi tutti aspiranti ingegneri o economisti, ossia aspiranti arricchiti generici, non avevano ancora nulla di proprio, a parte i voti in pagella, e si confrontavano tra loro attraverso i soldi dei genitori, invitandosi a vicenda in ristoranti costosi.
Sputacchiera, cresciuto a surgelati e acqua, acqua ricavata, per risparmiare, dal ghiaccio dei surgelati, cercava a sua volta di darsi un tono da bon vivant e fingendo competenza gastronomica consultava a lungo il menù, lasciava che gli altri ordinassero e alla fine prendeva quel che nessuno aveva preso, per anticonformismo conformista.
Quella volta, coi nomi dei piat...