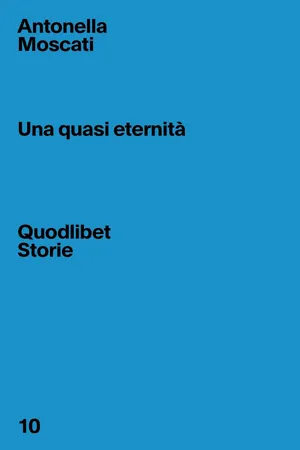Quattro
Ogni volta che doveva fare dei controlli medici, le pareva di dover subire un processo in cui erano in gioco la vita o la morte. Medici, infermieri, tecnici di radiologia, dentisti o farmacisti, che si allontanavano portandosi dietro un pezzo di lei sotto forma di provette di sangue, lastre di seni e calchi di denti erano gli emissari di un potere che la schiacciava smembrandola. Non era facile vivere in un mondo in cui i verdetti erano finiti negli ospedali, nelle cliniche, nei laboratori d’analisi e negli studi di radiologia. Nel corso della sua vita si era spesso domandata quali fossero i pensieri di un condannato a morte la notte prima della sua esecuzione. Addormentarsi avrebbe significato rischiare di svegliarsi con quella dolce apertura al nuovo che da sempre, almeno per lei, accompagnava l’arrivo del nuovo giorno, dimenticanza del male, della malattia e della morte. Una sensazione infantile che perdeva soltanto quando aveva l’influenza o si svegliava col mal di testa. Forse anche il condannato a morte si sarebbe svegliato così il giorno della sua esecuzione, dilatando il cuore e gli occhi a quella consuetudine al nuovo, un nuovo che stavolta non ci sarebbe più stato, o che ci sarebbe stato per la prima volta. Si sarebbe svegliato immemore e, solo dopo quell’esordio fiducioso, avrebbe ricordato. Era proprio quella dimenticanza che si ricorda dell’orrore soltanto dopo a spaventarla sopra ogni cosa, ed era per questo che si preparava sempre al peggio. Ma anche così, in perenne compagnia del peggio, la sana dimenticanza tornava a svegliarla ogni mattina, quasi contro se stessa.
Quando andava a fare dei controlli medici, controlli ai quali si sottoponeva con tutta l’ostinazione del funzionario della legge e tutta la resistenza del criminale braccato, si metteva nei panni del condannato a morte. E, proprio come per il condannato a morte, anche per lei il tempo prendeva quella forma vuota in cui può accadere solo qualcosa di ineluttabile. Quando, per esempio, telefonava a un medico che le dava un appuntamento per una mammografia la settimana dopo, quel pezzo di tempo si sospendeva tra la vita e la morte, anzi tra l’attesa e la morte, fino all’arrivo di quel giorno. Subito dopo la telefonata, quel tempo che solo una settimana prima le era sembrato lunghissimo cominciava a restringersi senza che niente vi si potesse opporre. Nonostante cercasse di non dormire, di non fare niente che le piacesse veramente, ma al massimo di attaccarsi a lavoretti facili e inutili, quel giorno arrivava inesorabile e soprattutto arrivava la notte prima, quella notte senza immagini e senz’ordine che l’evento del giorno dopo inghiottiva senza resti. Come si sarebbe svegliata? Forse il condannato a morte non si permetteva affatto di dormire e se ne stava a spiare le ore, i minuti, i secondi e le frazioni ancora più infime di tempo che lo separavano dalla morte, per tirarli e allungarli da ogni parte. Lei e il condannato a morte erano gli ultimi seguaci di Zenone. Ma, come quel discepolo che lo aveva confutato alzandosi dai banchi in cui lo ascoltava, in fondo anche lei sapeva che, prima o poi, in un modo o nell’altro, Achille, la mammografia e la morte l’avrebbero raggiunta. Come antidoto all’idea che ogni giorno la vita procedesse spedita in direzione della morte – proprio come in quei calendari dei film americani – le piaceva credere che la felicità aggiungesse qualche tempo, giorni, ore o anche solo minuti, alla sua vita che, come la statura di un bambino, era iscritta sì nel codice genetico, ma poteva anche crescere con le vitamine. Nella speranza che i fili nelle mani delle Parche fossero fatti di un materiale simile a quello delle gomme da masticare o agli sputi di lumache: lunghezze malleabili, negoziabili e soprattutto indecise.
Non aveva un vero e proprio corpo. Catalogazione e assemblaggio d’organi, questo sì: due occhi, due orecchie, due ovaie, un naso, un cuore, un fegato, due reni, un pancreas probabilmente, e di sicuro molte vertebre e troppi denti. Organi sparsi, gli uni accanto agli altri, pronti a contagiarsi l’un l’altro o a diventare il bersaglio di un unico tumore. Il virus del raffreddore faceva sempre lo stesso percorso: faringe naso trachea bronchi, alte vie respiratorie, per lo più. Una sola volta, a Berlino, dove aveva fumato molto perché era innamorata di uno con cui non stava e aspettava invece l’arrivo indesiderato di quello con cui stava, le era venuta la broncopolmonite, accompagnata, chissà perché, dalla cistite. La principale funzione dei suoi organi era quella di poter offrire sede e nome alle più famose malattie. Prima ancora di sapere a che cosa servisse l’utero, e in effetti non le era riuscito di saperlo fino in fondo, ben sapeva – all’età di cinque o sei anni – che lì poteva alloggiarci il tumore. Quando, infatti, non aveva ancora le idee chiare sulla generazione e, benché non credesse più alla cicogna, interpretava un ventre gravido solo come un segno inviato da Dio per annunciare il prossimo arrivo di un bambino, già sapeva che zia Sisina, Antonietta la cameriera dei Lagazzi e la signora Maria Ales erano morte di un tumore all’utero, un organo che non sapeva localizzare, ma che si poteva togliere. Nella lingua di sua madre togliersi l’utero suonava spesso come togliersi un pensiero: “Si è tolta l’utero, ah meno male, si è tolta un pensiero!” Pur estirpabile come un pensiero, l’utero restava per lei bambina un che di misterioso, una pedina fondamentale in quella lunga schiera di cose che non conosceva, ma di cui sapeva che le era proibito saperne di più. Talvolta le pareva che ogni generazione, passando per le malattie tipiche del proprio tempo, avesse il compito di rendere immortale uno degli organi di un simbolico corpo glorioso che, spignorato pezzo a pezzo, sarebbe diventato il tessuto dell’umanità sanata dai mali. Alla generazione di sua madre era toccato salvare l’utero, poi si era passati al seno. E qual era adesso l’organo da riscattare?
Per lo più andava dai medici per entrare in contatto con quelle parti di se stessa e imparare a tenerle a bada, come se le mani estranee del medico, una volta passate su di loro o dentro di loro, direttamente o con l’aiuto di strumenti piccoli e grandi, le acquietassero per un po’. Dopo un incontro felice con un medico, infatti, i suoi tessuti si mettevano a tacere per qualche tempo, sottomessi e tranquilli, talvolta perfino amabili. Le visite ginecologiche e le mammografie restituivano la vagina e i seni al piacere, le ispezioni dell’otorino le stappavano il naso, gli incontri con suo cognato medico le permettevano di toccarsi la pancia e di tornare a guardare questo o quel pezzo di pelle. Aveva scoperto, però, che anche i medici avevano bisogno di un certo tempo per abituarsi al suo corpo e che, solo dopo che quest’abitudine si era instaurata, cominciavano a intravedere qualcosa. Era per questo che, se un medico in qualche modo le piaceva, odiava cambiarlo, mentre le macchine le facevano sempre più paura dei medici.
Le malattie la preoccupavano tutte, anche quelle non mortali. Era attenta e vigile a ogni cambiamento, proprio come all’invecchiamento del suo corpo. Suo padre, d’altronde, ripeteva spesso la frase di un poeta latino: morbus ipsa senectus, la vecchiaia è essa stessa una malattia. Quando si annoiava o quando era felice, e soprattutto quando non era interamente assorbita da un’altra paura, subito scopriva un nuovo rigonfiamento, una neonata macchia sulla pelle, uno strano dolore che la mettevano in apprensione. Perdeva a questo punto ogni pace perché la sua mano andava a palpare e a soppesare a intervalli ravvicinati quei gonfiori, ...