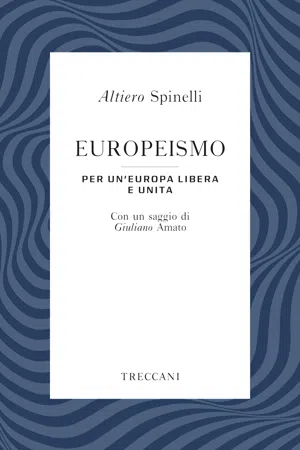
- 144 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Europeismo
Informazioni su questo libro
L'Europa è sempre più al centro del dibattito politico e culturale globale, ma al tempo stesso è l'elemento cardine di una crisi economica e democratica. Ma come nasce l'idea di Europa? Treccani propone una voce fondamentale che definisce i contorni originari della genesi di un luogo tanto geografico quanto culturale, ma che prima ancora fu soprattutto un sentimento e un modo di interpretare l'esistenza: l'Europa è infatti il continente con la maggiore ricchezza unita alla miglior qualità di welfare. Il testo di Altiero Spinelli racconta così la nascita e la diffusione di un'idea di condivisione politica che ha visto nel cittadino europeo il centro di un discorso capace di lasciarsi alle spalle la tragedia di due guerre figlie della violenza cieca degli Stati nazionali.
La voce Europeismo, rivista alla luce della contemporaneità da Giuliano Amato, è una guida utile a individuare, in un contrappunto critico, le risorse inesplorate così come le criticità di un'idea che deve farsi comunità.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Europeismo di Altiero Spinelli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Politics & International Relations e Democracy. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
L’EUROPEISMO DI ALTIERO SPINELLI
di Giuliano Amato
I TEMI E I FILI DELLA VOCE “EUROPEISMO” DI SPINELLI
Sono passati oltre quarant’anni da quando Altiero Spinelli scrisse la voce Europeismo per l’Enciclopedia del Novecento della Treccani.
Di essa colpisce in primo luogo l’impianto, già di per sé espressione di una mente straordinariamente lucida così nel concepire come nell’ordinare i temi da trattare nel saggio assegnato all’autore: i precedenti storici, con la centralità nel primo Novecento degli Stati sovrani e del nazionalismo; gli europeisti e l’europeismo, con i due percorsi del federalismo e del funzionalismo; quindi i protagonisti che hanno occupato la scena durante e dopo la seconda guerra mondiale, prima i leader, poi le grandi potenze e i singoli paesi europei, ultime le forze politiche; e infine ciò che ne è uscito e ciò che dovrà ancora uscirne sul terreno dell’integrazione europea. È semplicemente perfetto e tale appare ancora di più nella lettura: perfetto nei temi, nella sequenza, nel progressivo avvicinamento di campo all’avvicinarsi dei temi nel tempo.
Poi ci sono i fili rossi che attraversano il saggio e sui quali si confrontano gli attori e le vicende a cui gli stessi attori danno vita. Tre mi paiono sovrastanti: la forza dello Stato-nazione, il federalismo come antidoto per neutralizzarne gli eccessi devastanti, e infine il funzionalismo, che è l’alternativa preferita dagli Stati al federalismo, ed è cionondimeno capace, se la politica lo vuole, di portare verso di esso.
Lo Stato-nazione è, per Spinelli come per tutti gli europeisti della sua generazione, la matrice delle immani tragedie del secolo, le due guerre mondiali accompagnate da carneficine che mai l’umanità aveva subito in precedenza. Lo è, non necessariamente in ragione della statualità, ma del pernicioso nutrimento che questa ha avuto, da un lato dal nazionalismo aggressivo e dall’altro dalla concezione della sovranità come fonte di poteri assoluti, esclusivi, sempre legittimati a farsi valere anche con le armi. Una tenaglia – nota Spinelli – che ha stretto e orientato gli Stati verso la guerra proprio con l’avvio del XX secolo, quando sono scomparsi i due imperi, nei quali identità nazionali diverse si erano comunque trovate a convivere e a riconoscersi.
Di sicuro la soluzione non era l’impero e, del resto, l’autodeterminazione dei popoli è un principio che ha una sua indiscutibile legittimazione morale. Quel che è certo, però, è che non basta una tale legittimazione a prevenire i rischi del conflitto armato. Ecco allora il modello alternativo all’impero, la federazione così eloquentemente esemplificata dalla Svizzera. Possono gli Stati nazionali, anziché combattersi, mettere in comune una parte dei loro poteri, quanto basta a farli vivere in pace?
È il secondo filo rosso del saggio di Spinelli, il federalismo. Da lui inteso non come smantellamento degli Stati nazionali, ma, appunto, come messa in comune delle sole, grandi politiche trasversali: politica militare, politica estera, politica economica e monetaria. Sia chiaro, la messa in comune di quelle politiche non è affatto minimalista, è, al contrario, la sottrazione agli Stati delle leve più espressive della loro sovranità – dal batter moneta al fare la guerra. Ma è proprio questo che più direttamente e inequivocabilmente risponde allo scopo degli europeisti: tagliare, sotto i piedi degli Stati, l’erba che più li spinge al conflitto e all’uso delle armi. Per il resto, non ci sarebbe ragione che le singole comunità nazionali non avessero i poteri per corrispondere ai propri bisogni.
La razionalità logica del disegno non ne rende meno ardua la realizzazione e Spinelli dimostra di saperlo bene. Così come sa – e lo dice – che il federalismo, che è insieme l’ideale e lo scopo politico più forte, è tuttavia politicamente debole, non può quindi impostare, secondo il suo disegno, i concreti svolgimenti dell’integrazione europea e deve avere la capacità di influire sulla direzione e sui risultati degli indirizzi maggiormente sostenuti. C’è qui uno dei tratti peculiari della personalità stessa di Altiero Spinelli, il quale, dopo la sua uscita dal Partito comunista, fu a lungo un grande solitario e seppe tuttavia esercitare un’ampia influenza sui processi europei. A differenza di tanti altri confinati politici, si trovò solo dopo lo sbarco sulla terraferma di ritorno da Ventotene. Eppure cominciò a tessere i suoi fili e nelle prime assemblee europeiste del dopoguerra, nessuna delle quali dette frutti federalisti, fu comunque tra i protagonisti.
C’è traccia di questa sua personale esperienza nel modo in cui svolge il terzo filo rosso, quello del funzionalismo. Il funzionalismo era un metodo già sperimentato dagli Stati, che con esso, prima e durante la guerra, avevano messo insieme l’esercizio di funzioni amministrative di settore, dall’approvvigionamento di materie prime, ai rifornimenti alimentari, sino al controllo dei cambi, affidandole a una gestione tecnica unica. Jean Monnet non metteva in discussione la sovranità degli Stati e offriva una strada per ciò stesso più facile da percorrere. Come sappiamo, così è stato, prima con la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, poi con l’Euratom e con la stessa Comunità economica europea. Certo una differenza importante c’era, perché ora i partecipanti non erano Stati alleati, ma Stati che si erano combattuti. La messa in comune di carbone e acciaio tra Francia e Germania significava molto in termini di promessa reciproca di pace di solidarietà. Era dunque un grande passo avanti, che gli Stati facevano senza sentirsi spogliati. E via via che fosse cresciuta la solidarietà fra gli europei – come avrebbe detto Robert Schuman nella sua famosa dichiarazione del 9 maggio 1950 – altri passi ben più coraggiosi, forse, si sarebbero potuti fare.
Questo Spinelli lo sapeva e per questo non riteneva che al funzionalismo ci si potesse affidare, poiché senza la politica si sarebbe esaurito nella gestione del presente. Tuttavia, lo accomunava al federalismo nella condivisa ripulsa dell’intergovernativismo, in cui vedeva il contrario dell’integrazione, contando proprio sull’integrazione che esso comunque creava, perché fungesse da trampolino di iniziative politiche federaliste.
Era nell’intreccio fra questi tre fili rossi – gli Stati nazionali e la loro disponibilità non solo a cooperare, ma a integrarsi; il funzionalismo, che li poteva portare a integrazioni settoriali non necessariamente politiche; e il federalismo, che di queste integrazioni doveva esser pronto a profittare per farne uscire la stessa integrazione politica – che era destinata a svolgersi la partita europea, così come Spinelli la vedeva. Con quali prospettive, e contando su quali gambe, cominciò la partita?
Non certo sulle gambe dei primi leader che pure predicarono l’Europa durante e subito dopo la seconda guerra mondiale, Winston Churchill e Charles De Gaulle, che mai sarebbero andati oltre un’Europa confederale e che comunque vedevano l’Europa unita solo e soltanto sotto la guida ciascuno del proprio paese. Spinelli parla diffusamente di entrambi e generosamente riconosce soprattutto a Churchill di essere andato oltre la retorica europeista, impegnandosi nella costituzione del Movimento europeo in nome di un europeismo diverso da quello dell’integrazione (dalla quale pure era partito, quando nel 1940 aveva proposto, ben al di là della stessa federazione, una sorta di fusione tra Francia e Regno Unito: ma era una mossa anti-tedesca, allora). Di De Gaulle parla con maggiore distacco, se non altro perché gli è evidentemente ostica l’idea di un’Europa non più che confederale a guida francese, per designazione divina della Francia come Stato-guida. E tuttavia su entrambi gli uomini si sofferma a lungo e ne parla con rispetto, perché vede in essi le qualità di cui il suo disegno ha essenziale bisogno: la forza e la creatività politica. Sono le risorse senza le quali il federalismo mai riuscirebbe ad affermarsi. E a esse Spinelli rende omaggio.
Passando alle grandi potenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, riconosce a entrambe una sincera attenzione per l’Europa, dovuta sia allo “spirito missionario” che, pur in termini diversi, le accomuna, sia alla diffidenza verso tutti noi, che, lasciati soli, avevamo dimostrato di essere fonte di guai. È un fatto, però, che l’integrazione europea trova sostegno da una parte sola, quella americana, mentre dall’altra c’è più interesse ad acquisire al proprio sistema i paesi dell’Europa orientale. Spinelli non crede al presunto (da molti) divide et impera di Washington, interessata al contrario a prevenire ideologie e pratiche nazionaliste, ma non crede neppure al potenziale che altri attribuiscono all’alleanza atlantica. È, secondo lui, non una comunità “reale e istituzionalizzata”, bensì appunto un’alleanza che assolve a innegabili finalità strategiche, ma ha fra l’altro l’effetto, non positivo, di mantenere gli europei sotto l’ombrello di una sicurezza fornita da altri, di cui così disimparano il costo, pagando quello, meno visibile, della loro autonomia.
Non minore è il realismo che manifesta nel valutare il tasso di europeismo e le conseguenti inclinazioni dei singoli paesi europei: più propensi all’integrazione i paesi piccoli, Olanda, Belgio e Lussemburgo, e i grandi sconfitti della guerra, Germania e Italia; europeista, ma sempre con venature sovraniste, la Francia; cauta e dubbiosa la Gran Bretagna, che arriverà a impegnarsi nella Comunità, spinta dall’intento di condividerne i benefici economici, ma pronta a selezionare per il resto gli ambiti della sua integrazione.
Anche fra le forze politiche predominanti nei vari paesi – scrive Spinelli – la penetrazione dell’europeismo fu varia. E ricorda il forte consenso che esso incontrò nei partiti cattolici, mentre a sinistra l’atteggiamento fu all’inizio decisamente ostile e prese a modificarsi prima nei partiti socialisti, poi (proprio al tempo in cui Spinelli scriveva) negli stessi partiti comunisti, in particolare in quello italiano. Certo si è che nei primi decenni, quando il governo dei maggiori paesi era in mani centriste, con eminenti figure cattoliche ai vertici, il processo di integrazione poté avviarsi contando su «una larga anche se passiva simpatia popolare».
Spinelli fa entrare in campo qui un protagonista che è, in realtà, lui stesso circondato dai pochi ardimentosi che, come lui, affiancano quel processo, cercando di condurlo verso gli approdi desiderati: l’azione europea (ed è significativo che i leader ai quali si devono i passi che in concreto si compiono sulla via dell’integrazione – Schuman, De Gasperi, Adenauer, Spaak, Bevin – li collochi fra i “corifei” dell’azione europea). Con rara efficacia mette in luce le molteplici difficoltà che essa incontra: da un lato quello che definisce «l’avversario permanente, tenace, proteiforme e sempre rinascente», costituito dalla radicata abitudine a pensare interessi, attività, costumi, regole entro le categorie dello Stato-nazione. Non è l’anti-europeismo, che emergerà più tardi, ma è quanto meno la controforza che, ancor prima, porterà verso la deriva intergovernativa. Dall’altro lato il fatto che l’«operosità europea», come la chiama (e in controluce, ancora, dietro c’è lui), non si muove fra istituzioni consolidate, non si esprime nell’ambito di opzioni politiche ben delineate, ma deve “scoprirle”: «Non ha nemmeno un linguaggio politico già formato, ma deve inventarlo».
Il risultato di tutto questo è quello che gli appare un andamento paradossale e contraddittorio; un andamento che restaura gli Stati nazionali, e così facendo consolida le categorie politiche ed economiche nazionali, ma allo stesso tempo instaura istituzioni politiche comuni, aprendo prospettive, che con quelle categorie dovranno fare i conti. È dunque un risultato sempre aperto e sempre in discussione, che potrà sfociare in una costruzione europea, sovrastruttura effimera e fragile delle restaurazioni nazionali, ovvero nella instaurazione di una vera unità sovranazionale. A deciderlo potrà essere soltanto la lotta politica, il terreno sul quale Spinelli si era sempre sentito protagonista e sul quale, mentre scriveva queste cose, contava di esserlo ancora in futuro.
È una straordinaria ouverture, questa, per esaminare quello che poi è avvenuto, a partire dagli stessi sviluppi istituzionali che Spinelli segnala nella parte finale del suo saggio. Come tutti sappiamo, dopo la vicenda, in cui personalmente si era molto impegnato, che aveva fatto presagire un successo federalista attraverso la Comunità europea di difesa, bocciata invece nel 1954, si trattò di sviluppi sempre all’insegna del funzionalismo. Ma da grande, e quindi duttile, politico Spinelli ne prese atto e non ebbe remore nel progettare sviluppi di integrazione politica a coronamento delle riforme settoriali che, in chiave funzionalista, si venivano impostando. Ed ecco allora, nei passaggi conclusivi del suo saggio, ciò che egli intende per «fare l’Europa negli anni Settanta». Intende passare dall’unione doganale all’unione economica e monetaria. Intende arrivare alla «voce unica» per affrontare le responsabilità che la Comunità ha ormai nel mondo. Intende che, in questi diversi settori, siano trasferite dagli Stati membri alle istituzioni comuni le necessarie competenze legislative e di governo.
È un programma di azione politica coerente con la sua visione e ben applicabile sul terreno su cui la storia impone ormai di cimentarsi: il terreno predisposto, settore per settore, dal funzionalismo, sul quale, solco per solco, tocca alla politica europeista innestare i decisivi passi finali. Sembrerà a lungo, allo stesso Spinelli, che questo fosse possibile e venisse anzi via via accadendo. Per questo avrebbe detto, negli ultimi anni della sua vita, che senza i “visionari” come lui gli “statisti” non avrebbero saputo dove andare, ma gli stessi visionari, senza il realismo degli statisti, non sarebbero andati da nessuna parte.1
CHE COSA È SUCCESSO DOPO. L’INTEGRAZIONE È STATA UNA PARABOLA?
Certo si è che due anni dopo l’uscita del volume dell’Enciclopedia del Novecento che conteneva la voce Europeismo, ci sarebbe stata la prima elezione diretta del Parlamento europeo; un passo che Spinelli collegava addirittura all’avvento dell’Europa federale e che invece si installò in quella che era e rimase un’unione fra Stati. Tuttavia, quel Parlamento fu comunque un passo verso una più stretta integrazione, tant’è vero che conquistò presto nel tempo il ruolo di co-legislatore (prima dell’elezione diretta era stato soltanto un corpo consultivo) e riuscì anche a stabilire un rapporto di fiducia politica fra sé e la Commissione.
Tutto sembrava muovere in quegli anni nella stessa direzione. Si pensi alle decisioni della Corte di giustizia che, fra il 1970, nel caso Internationale Handelsgesellschaft, e il 1979, nel caso Hauer, riconobbero nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri il fondamento di diritti individuali che l’ordinamento comunitario poteva e doveva fare propri;2 un valore che, poco più avanti, il Trattato di Maastricht del 1992 avrebbe esplicitamente riconosciuto in una delle sue disposizioni.3
Per non parlare dell’altra e ancor più grande novità introdotta da quello stesso Trattato, la moneta unica accompagnata dalla Banca centrale europea, che toglieva agli Stati membri una delle prerogative sovrane più caratterizzanti, quella di batter moneta, e, con essa, la politica monetaria.
Sul piano istituzionale erano tutte manifestazioni di maggiore integrazione, che tuttavia esprimevano anche qualcosa di più, val...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- LA CATASTROFE DEL NAZIONALISMO
- L’EUROPEISMO
- IL FEDERALISMO EUROPEO
- IL FUNZIONALISMO
- IL CONFEDERALISMO
- LE SUPERPOTENZE E L’EUROPA
- LA DIFFUSIONE DELL’EUROPEISMO
- TAPPE E CICLI DELLA COSTRUZIONE EUROPEA
- BIBLIOGRAFIA
- L’EUROPEISMO DI ALTIERO SPINELLI. di Giuliano Amato