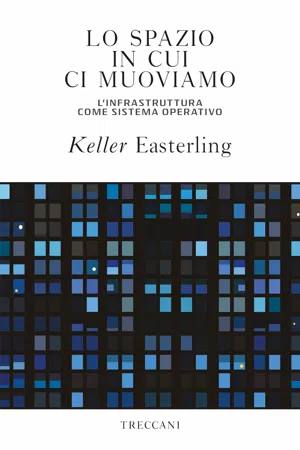
eBook - ePub
Lo spazio in cui ci muoviamo
L'infrastruttura come sistema operativo
- 312 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Lo spazio in cui ci muoviamo
L'infrastruttura come sistema operativo
Informazioni su questo libro
Viviamo in un mondo immerso in un'infrastruttura globale, definita non più solo dalle reti fisiche dedicate al trasporto e ai servizi pubblici, ma anche da quell'insieme di standard, idee e formule replicabili che governano lo spazio della nostra vita. Introducendo il concetto di extrastatecraft, una "parola macedonia" che descrive i luoghi e le attività che agiscono al di fuori delle tradizionali pratiche di governo, Easterling analizza la natura delle infrastrutture odierne: dalle più recenti enclave extraurbane come Dubai e Mumbai alle reti globali a banda larga che stanno mutando l'essenza del continente africano, fino a quel vero e proprio parlamento extrastatale che è l'ISO, deputato alla creazione di standard validi su scala globale. Emergono così i tratti caratteristici di un pianeta in cui le infrastrutture sono diventate punto di accesso e di contatto per ognuno di noi; uno spazio infrastrutturale.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Lo spazio in cui ci muoviamo di Keller Easterling, Andrea Migliori in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Architecture e Urban Planning & Landscaping. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1
LA ZONA
I filmati che reclamizzano le zone franche seguono invariabilmente lo stesso schema. Si parte dallo spazio zoomando verso un punto sulla superficie terrestre. La grafica indica i tempi di volo da lì alle principali città, a sottolineare il fatto che la zona, ovunque si trovi, è al centro dei processi produttivi globali. Nelle versioni a basso costo di questi spot la colonna sonora può limitarsi a una fanfara standard dal suono metallico, ma spesso la produzione non bada a spese: la musica coinvolgente andrebbe bene in un western o in un film d’avventura, ma include sfumature etniche che richiamano la cultura locale. Una voce profonda, da trailer cinematografico, elenca i requisiti infrastrutturali. La zoomata continua, attraversando le nuvole e rivelando lo skyline scintillante della nuova metropoli avvolta in una cascata di riverberi digitali.
La zona non è sempre stata l’ultimo grido dell’urbanistica mondiale. Un tempo relegata dietro le quinte, nell’arco di pochi anni si è trasformata da enclave recintata per magazzini e fabbriche a modello di città globale. Le mutazioni vertiginose conosciute dalla zona negli ultimi trent’anni, tuttavia, lasciano intendere che sia possibile alterarne ancora la forma.
Il commercio mondiale si è affidato per secoli ai porti franchi, ma è lo sviluppo della zona industriale di esportazione (Epz, Export Processing Zone) come strumento economico e amministrativo più formale verso la metà del Novecento a segnare la nascita della zona moderna. Fu allora che le Nazioni unite e la Banca mondiale, usando argomenti convincenti a base di nation building e libero scambio, reclamizzarono la Epz come uno degli strumenti che i paesi in via di sviluppo avrebbero dovuto adottare per affacciarsi al mercato globale e attirare i capitali stranieri con incentivi come le esenzioni fiscali e un costo del lavoro particolarmente basso. Nonostante fosse stata concepita come esperimento temporaneo e si fosse dimostrata uno strumento economico sub-ottimale, negli anni Settanta la zona conobbe una grande diffusione, portando con sé nuove ondate di sfruttamento dei lavoratori. Il fenomeno, però, ebbe conseguenze inaspettate: anziché integrarsi nell’economia locale, così come era previsto in origine, la Epz finì con assorbirla sempre più nell’enclave.
Le generazioni successive, nate in Cina o in Medio oriente, divennero sostanzialmente vere e proprie città o città-stato in cui l’urbanistica si sposta verso il terziario. Verso la fine degli anni Settanta, l’esperimento cinese della zona come strumento di libero scambio ebbe un successo tale da generare reti commerciali globali che a loro volta accelerarono la crescita delle zone su scala mondiale. A Dubai, la zona rinnovò la forma del polo commerciale senza discostarsi molto dai suoi modelli più tradizionali. Nel moltiplicarsi, le zone conobbero anche un’evoluzione che le portò a incrociarsi con altre forme urbane in espansione come il campus o i complessi dirigenziali. Con la fusione tra l’economia industriale e quella della conoscenza, la zona ha cominciato ad arricchirsi di programmi residenziali, turistici, educativi, commerciali e amministrativi, trasformandosi in un incubatore di prodotti spaziali capaci di migrare senza sforzo da un capo all’altro del pianeta grazie agli incentivi all’urbanizzazione.
Oggi, dopo aver ingoiato la città in un solo boccone, la zona è diventata il germe responsabile di un’epidemia urbanistica che genera imitazioni scintillanti di Dubai, Singapore e Hong Kong. Se negli anni Sessanta le zone di tutto il mondo si contavano sulle dita di una mano, oggi ne esistono migliaia, con dimensioni che variano da pochi ettari a diversi chilometri quadrati. Uscita dall’ombra della città intesa come centro finanziario globale (New York, Londra, Tokyo, San Paolo), la zona in quanto enclave aziendale è diventata il più apprezzato tra i modelli di città globale contemporanea, perché consente di accedere direttamente e senza limitazioni di sorta all’economia di un paese straniero. Le città più importanti di molti paesi – e perfino le capitali, che dovrebbero rappresentarne il centro del diritto – hanno creato le proprie zone-sosia: Navi Mumbai in India; in Kazakistan Astana, la capitale nuova di zecca; o ancora Songdo, un doppione di Seul che per l’immobiliarista Stanley Gale è una città «chiavi in mano», ripetibile. Per gli analisti economici è una corsa continua all’inseguimento di una zona capace di riproporsi in decine di varianti e di mutare in vivo, oscillando tra visibilità e invisibilità, identità e anonimato.
Nelle sue mutazioni, la zona ricorda le varie comunità intenzionali formatesi nel corso della nostra storia, in cui le vocazioni eremitiche si mescolavano ad altre aspirazioni, e manifestazioni gioiose di civiltà convivevano con una forma complessa e talvolta violenta di illegalità. Esercitando un controllo autonomo su un circuito chiuso di circostanze compatibili, la zona isomorfa rigetta gran parte delle situazioni e delle contraddizioni che caratterizzano le forme più familiari di civiltà urbana. Con i suoi dormitori e i suoi sweatshop, le fabbriche-lager, la zona continua a essere, molto spesso, un sito clandestino di sfruttamento del lavoro.
Nonostante tutti gli sforzi di mantenersi apolitica, la zona si rivela sovente un potente pedone politico. Celebrata come strumento del liberalismo economico, baratta la burocrazia statale con una stratificazione ancora più complessa di governance extrastatale, manipolazione del mercato e regolamentazione. Concepita come strumento di razionalizzazione economica, in molti casi è un crogiolo in cui l’irrazionalità e la fantasia si fondono alla perfezione. E il fatto di costituire un software spaziale relativamente primitivo – l’equivalente urbanistico di MS-DOS – non ha impedito alla zona di diffondersi rapidamente in tutto il mondo. Ed è per tutte queste ragioni che la zona è perfetta per essere manipolata, e che la sua popolarità ne fa un potenziale vettore o amplificatore di tecnologie, politiche e modelli urbanistici alternativi.
La zona è antica, la zona è nuova
La zona eredita il fascino antico dei porti franchi, dei covi di pirati e dei poli del commercio marittimo. Il porto romano di Delos, in Grecia, viene citato sovente come esempio primigenio di porto franco.1 Nel Mediterraneo, le rotte commerciali italiane, armene e musulmane avevano favorito la nascita di numerosi porti franchi. Tra il XIII e il XVII secolo, la Lega Anseatica fondò una rete di “città libere” sulle sponde del Baltico e del Mare del Nord. I suoi mercanti, orgogliosi della loro indipendenza, crearono una società quasi monastica i cui membri vivevano e mangiavano insieme nelle fabbriche e nelle logge mercantili delle città straniere in cui a volte si trovavano confinati. Città della Lega come Amburgo e Brema commerciavano con Londra, Lubecca, Rostock, Danzica, Königsberg, Bruges, Colonia e Novgorod.2 I primi porti franchi del Mediterraneo furono Marsiglia, Genova e Livorno. Nel XVII secolo, l’elenco delle città libere e dei porti franchi europei comprendeva Napoli, Venezia, Trieste, Porto, Dunkerque e Copenaghen. Amburgo conservò per secoli le prerogative di porto franco, riuscendo a sottrarsi alla giurisdizione delle monarchie e alle leggi nazionali.3
Tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, con l’allargamento degli scambi alle Americhe, cominciò a prendere forma una rete commerciale realmente globale; la Spagna, il Portogallo, l’Olanda e la Gran Bretagna aprirono porti franchi in Sudamerica e ai Caraibi, cui seguirono i porti franchi britannici e francesi a Singapore (1819), Hong Kong (1841), Aden (1853) e Gibuti (1859).4 Con gli anni i porti dei Caraibi persero importanza, a differenza di quelli asiatici, in modo particolare di Hong Kong, che insieme ad Amburgo continuò a rappresentare un modello globale per tutto il XX secolo. Quando Amburgo entrò a far parte dell’Impero tedesco, nel 1871, la città rifiutò di entrare a far parte dell’Unione doganale tedesca per paura di perdere i suoi molteplici privilegi commerciali, e vi aderì solo nel 1888, quando le fu riconosciuto il diritto di conservare un’area non sottoposta al controllo dell’Unione. Al suo interno, la città godeva di maggiore libertà nello smistamento, nella lavorazione e nella distribuzione delle merci stoccate prima della riesportazione.5
Nel 1934, dopo aver inviato proprie delegazioni a studiare i casi di Copenaghen e Amburgo, gli Stati Uniti vararono il Foreign Trade Zone Act, che consentì la creazione di zone franche (Ftz, Foreign Trade Zones). Ispirate in parte a quelle di Amburgo, le Ftz permettevano lo smistamento e la lavorazione delle merci.6 Le prime Ftz statunitensi furono quelle di New York, New Orleans, San Francisco e Seattle. Nel 1950 la legge fu modificata per consentire la produzione di beni, ma fino agli anni Settanta le nuove Ftz furono solo tre: Toledo, in Ohio; Honolulu, alle Hawaii; e Mayagüez, a Portorico.7
Dopo la seconda guerra mondiale, in tutto il mondo videro la luce siti specializzati nella produzione di beni, precursori della zona industriale di esportazione (Epz). Fu questa la formula che diede indubbiamente avvio alla proliferazione delle zone su scala globale. Pur avendo perso importanza in seguito alla seconda guerra mondiale e al conflitto coreano, Hong Kong si risollevò proprio sposando il nuovo modello di porto franco, grazie (almeno in parte) all’elevato volume di merci esportate.8 Quando non fu più indispensabile come punto di rifornimento, l’aeroporto irlandese di Shannon lanciò una campagna esplicita per attirare industrie manifatturiere e di servizi con leggi che sancirono la nascita di una zona franca aeroportuale (Customs Free Airport Act, 1947) e della Shannon Duty Free Airport Development Company (1959).9
Nel 1947, Portorico, che in tempo di guerra aveva già operato per gli Stati Uniti come fornitore duty-free, si lanciò nella realizzazione di fabbriche e magazzini ritagliati sulle esigenze dei clienti americani. Grazie a un’esenzione fiscale decennale e alla disponibilità di edifici modulari prefabbricati, nel 1963 le aziende installate erano già cinquecento. Uno dei promotori del programma lo definì come «il primo tentativo serio di alleviare la sofferenza nei Caraibi». Il personale della società immobiliare aveva il compito di portare i clienti all’immobile che avevano comprato, accendere le luci, farsi da parte e dire: «Ecco la sua fabbrica, señor».10
Anche la Ftz Colón della Repubblica di Panama, creata nel 1948, venne concepita per sfruttare le relazioni sviluppate con gli Stati Uniti nel corso della seconda guerra mondiale. I primi progetti per una zona franca internazionale risalivano al 1917, tre anni dopo l’apertura del canale di Panama, e alcuni investitori newyorchesi si erano dimostrati interessati a finanziare il progetto. Nel 1946 Panama incaricò Thomas E. Lyons, segretario esecutivo del Foreign-Trade Zones Board statunitense, di valutare la fattibilità del progetto.11
Nel 1964, in concomitanza con la scadenza del programma di collaborazione con gli Stati Uniti Bracero (“bracciante”, in spagnolo), il Messico inaugurò il Border Industrial Program (Bip).12 Il Bip consentiva alle aziende straniere di aprire fabbriche (maquiladoras) in una fascia di 30 chilometri lungo il confine tra il Messico e gli Stati Uniti; a partire dal 1972 divenne possibile aprirle in tutto il paese. Si trattava, in sostanza, di gemelle a buon mercato delle fabbriche statunitensi che sfruttavano il basso costo di una manodopera soprattutto femminile.
Questi primi avamposti incoraggiarono altri paesi a condurre esperimenti analoghi....
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Ringraziamenti
- Introduzione
- CAPITOLO 1 La zona
- CAPITOLO 2 La disposizione
- CAPITOLO 3 La banda larga
- CAPITOLO 4 Narrazioni
- CAPITOLO 5 La qualità
- CAPITOLO 6 Extrastatecraft
- Conclusione