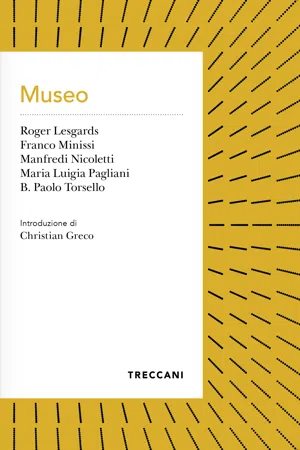
- 115 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Un tempo semplice contenitore di capolavori, manufatti o patrie memorie, il museo è diventato nel corso degli anni un luogo centrale nell'organizzazione della città, un sistema che aggrega poli diversi intorno a una sola istituzione, valorizzando anche altre realtà? e costituendo spesso un'ottima occasione di sperimentazione e innovazione, oltre che di tutela. Al tradizionale ruolo di conservazione delle testimonianze storiche si sono aggiunte funzioni connesse alla realizzazione di iniziative culturali e alle attività? didattiche per la popolazione scolare e adulta, che hanno contribuito a trasformare il museo da oggetto a soggetto attivo di processi socioculturali e progetti di intervento. Negli ultimi decenni la sua fisionomia ha subìto enormi cambiamenti a seguito dell'evoluzione dei modi di conservazione del patrimonio artistico e del concetto stesso di beni culturali, ma soprattutto in virtù? degli straordinari e continui apporti che la tecnologia ha introdotto. In termini di strategie economiche, il museo è diventato inoltre un vero e proprio prodotto. L'introduzione di Christian Greco, direttore di uno dei più famosi musei italiani e del mondo, il Museo Egizio di Torino, apre questo percorso affascinante che gli autori, architetti e archeologi esperti in campo museale, hanno costruito per noi.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
1
Introduzione
Negli ultimi vent’anni il museo ha mutato la sua fisionomia generale sulla scorta del dibattito che ha portato a una profonda revisione del concetto di bene culturale e di patrimonio artistico, e a seguito del diffuso uso sociale e didattico di tale patrimonio e dello sviluppo della nozione di redditività del prodotto culturale in termini anche di strategie economiche. Al tradizionale ruolo di luogo della conservazione delle testimonianze storiche legate a un limitato ambito territoriale o frutto di prevalenti interessi collezionistici, si sono aggiunte nuove funzioni connesse alla realizzazione di iniziative culturali, alle attività didattiche per la popolazione scolare e adulta, a tutto quanto contribuisce a trasformare il museo da oggetto a soggetto attivo di processi culturali e progetti d’intervento. Se talora il museo conserva quella caratteristica “civica” che lo ha contraddistinto nell’Ottocento, il suo significato è profondamente mutato; da contenitore di capolavori o di patrie memorie, il museo diviene luogo centrale nell’organizzazione della città, un sistema che aggrega luoghi diversi e vocazioni integrate intorno a una sola istituzione. Il museo si pone così in relazione e valorizza altre realtà, anche private o semiprivate, patrimoni di enti diversi, luoghi delle professioni artigiane e del loro tramando. Esso tende a trasformarsi, nel dibattito teorico, da struttura amministrativa con caratteristiche di verticalità e staticità, in un soggetto che meglio dovrebbe rispondere alle esigenze di versatilità e mobilità richieste dai nuovi modelli economici, che ne invocano un reale e concreto ingresso nell’area della produttività.
La crescita degli interventi nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, anche in termini economici, propone una nuova complessità organizzativa che vede articolarsi intorno a uno stesso progetto enti e istituzioni di varia natura, partner privati e figure professionali diverse, dallo storico dell’arte all’archeologo, al pianificatore territoriale, al restauratore, al manutentore, venendo così a creare un insieme di tecniche e di apporti metodologici e informativi che contribuiscono a fare dell’istituzione museale un luogo interdisciplinare per eccellenza. La realtà italiana rispecchia una peculiare vocazione, molto diversa per carattere e funzioni da quelle straniere. Per esempio, negli Stati Uniti, da molto tempo e assai più che altrove, il museo rappresenta un grande contenitore destinato a oggetti di provenienza prevalentemente collezionistica e spesso privi del loro originario contesto culturale e storico, che sulla base di intensi programmi di divulgazione artistica si propone anche come momento di aggregazione sociale, d’incontro. Fra i nuovi modelli museali che si affermano oltreoceano occorre ricordare la Smithsonian Institution che, sostenuta con fondi pubblici, offre ai musei consociati servizi ed efficienti magazzini dai quali vengono prelevate le opere a seconda delle necessità (esposizioni, studio ecc.). Il Musée de la civilisation a Québec, invece, unisce le caratteristiche del museo e del teatro, organizza esposizioni-spettacolo e si propone come modello del cosiddetto museoevento. L’adeguamento delle istituzioni ai modelli e alle dinamiche della società contemporanea fa sì che, in molti casi, il museo costituisca un’ottima occasione di sperimentazione e innovazione, non solo nel campo della museografia, ma anche della prassi architettonica e dell’allestimento. Si pensi, per esempio, all’East Building della National Gallery of Art di Washington di I. M. Pei, all’ampliamento del Guggenheim Museum di New York dello studio Gwathmey, Siegel and Ass., alla sezione Temporary Contemporary del Museum of Contemporary Art di Los Angeles dovuta a F. O. Gehry o infine al nuovo Getty Center di Los Angeles, su progetto di R. Meier. Analoghi fenomeni si colgono in alcuni paesi europei che negli ultimi vent’anni hanno rinnovato e arricchito le istituzioni museali.
In Germania, per esempio, a partire dagli anni Settanta si è assistito alla realizzazione di una serie di costruzioni museali nei centri delle città. Si tratta di una radicale politica di ristrutturazione e ricostruzione, che provoca anche profondi mutamenti urbanistici. Le funzioni e le forme del museo infatti, poste in relazione con ambienti anche molto diversi, si arricchiscono e al contempo esplorano nuovi territori della pianificazione urbana. All’interno di questa tendenza s’inseriscono, tra gli altri, la nuova Staatsgalerie di Stoccarda, progettata da J. Stirling e M. Wilford fra il 1977 e il 1984, che ha ottenuto un vasto successo di pubblico portando il museo dall’ultimo al primo posto delle presenze nella graduatoria stilata dall’amministrazione federale tedesca; e i nuovi musei di Francoforte, dove, nel decennio 1980-1990, si è intrapreso un estensivo programma di riconversione turistico-culturale con la creazione della cosiddetta “riva dei Musei”, che ha visto impegnati famosi progettisti come R. Meier e H. Hollein. I musei delle Arti applicate, della Posta, di Storia, di Arte antica e di Arte moderna integrano, sul piano culturale, l’importante ruolo di Francoforte in campo produttivo e commerciale. Il museo cerca così di rispondere con sempre maggiore aderenza ai bisogni della società contemporanea. In quest’ottica si possono interpretare anche i sempre più frequenti recuperi di aree industriali dismesse e obsolete per istituirvi musei, quali il Deichtorhallen di Amburgo, trasformato da mercati generali in Kunsthalle; la Tate Gallery di Liverpool, realizzata da Stirling, che occupa l’angolo nord-ovest dell’Albert Dock, un magazzino di sette piani del XIX secolo; il nuovo museo di arte contemporanea di Istanbul che ha recuperato come sede una fabbrica sul Corno d’Oro, la cui ristrutturazione è stata affidata a G. Aulenti (1992). Il panorama della politica museale spagnola offre una vasta gamma di soluzioni, dalla scelta del settecentesco Ospedale Generale come sede del Centro de arte Reina Sofia (1986) al progetto (1992) dell’ampliamento sotterraneo del Prado a Madrid, al nuovo museo di arte contemporanea di Barcellona, progettato (1988-92) da R. Meier. E, tra gli ampliamenti di prestigiose sedi museali, si deve ancora ricordare a Londra la nuova SainsburyWing della National Gallery che, progettata da R. Venturi, è stata inaugurata nel 1991.
Da segnalare ancora due casi francesi, che s’innestano nella tradizionale politica, tesa a concentrare nella capitale istituzioni culturali di grandi dimensioni. La prima è la creazione del Centro G. Pompidou (realizzato su progetto di R. Piano e R. Rogers e aperto al pubblico nel 1977) che, oltre al ricchissimo Musée National d’Art Moderne, ospita il Centre de création industrielle, l’Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) e numerosi servizi, primo fra tutti un’efficiente biblioteca. Vi si concretizza una concezione del museo come luogo di un processo dinamico e di una continua comunicazione, in cui l’approccio del fruitore non si chiude in compartimenti stagni, ma anzi si focalizza sulle relazioni interdisciplinari.
Nell’ultimo decennio, poi, dopo la sistemazione del museo d’Orsay, si è posta mano all’ampliamento e al riordino globale del Louvre. Il progetto, di grande complessità, avviato nel 1981, si protrarrà fino al 1996. Nel 1989 è stato aperto al pubblico il nuovo ingresso interrato coperto da una grande piramide in vetro incolore (opera dell’architetto I. M. Pei), che occupa il soprastante cortile. Il progetto di ristrutturazione, che prendeva le mosse dall’opportunità d’incamerare, per fini espositivi, l’ala del palazzo occupata dal Ministero delle Finanze, si propone un ampliamento e un miglioramento dei percorsi, una più vasta articolazione di servizi culturali e di attività, nonché l’inserimento del museo nella città, adattandone l’organizzazione e il funzionamento alla posizione di privilegio occupata nell’agglomerato urbano.
Anche in Italia il rapporto tra museo e città, non solo nei grandi nuclei urbani, ma anche nei piccoli centri, è il tema nodale del dibattito teorico. La volontà di riconoscere e preservare l’intensa stratificazione del patrimonio e le complesse interrelazioni tra il contesto territoriale e l’istituzione museale, e di conferire a quest’ultima un ruolo fondamentale nella vita e nella pianificazione urbana, ha indotto a elaborare strumenti metodologici autonomi capaci di rappresentare la trama ricca e articolata delle specificità dei luoghi, delle antiche e numerose sedimentazioni, delle vicende storiche, religiose e politiche, delle tradizioni così peculiarmente caratterizzate nelle diverse aree del paese. In questo quadro si elaborano soluzioni autonome anche in relazione al tema delle sedi museali. A differenza di quanto avviene − come già si è detto − negli Stati Uniti e in molti paesi europei, ove per i musei si costruiscono nuovi edifici specificamente progettati per tale destinazione, in Italia si privilegiano il recupero e il restauro di edifici storici con caratteristiche monumentali, sorti originariamente per uso diverso, ma per i quali l’utilizzo culturale e museografico rappresenta l’unica via possibile per una congrua salvaguardia.
Nel momento allestitivo s’instaura così un forte rapporto tra l’opera d’arte e l’ambiente che la circonda, teso a meglio accentuarne le caratteristiche e la leggibilità, senza peraltro rinunciare ai valori culturali e storici che gli sono propri. L’edificio quindi, da neutro contenitore in grado di garantire, attraverso l’impiego di moderni apparati tecnologici, una conservazione ottimale, si colloca in rapporto dialettico con gli oggetti esposti e diviene esso stesso momento importante del percorso culturale. In questo filone operativo s’innestano numerosissimi nuovi allestimenti realizzati nell’ultimo quindicennio, tra cui il Civico di Piacenza (1988) nelle sale del cinquecentesco Palazzo Farnese, oppure l’ampliamento dell’Accademia Carrara a Bergamo negli antistanti edifici anticamente di destinazione conventuale, e ancora il Museo di S. Giulia a Brescia, il complesso di Palazzo Altemps e di Palazzo Massimo a Roma. Anche a Torino si assiste alla riqualificazione in chiave di sistema della Galleria Sabauda, di Palazzo Carignano e di Palazzo Reale. Un suggestivo contrasto offre invece il restaurato Castello di Rivoli, dal 1984 sede di un museo d’arte contemporanea. In questo settore si può ricordare come esempio significativo il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, aperto nel 1988 nella sede progettata da M. Gamberini. Quanto all’apparato espositivo, tema dibattuto dalla museografia italiana in questi anni, si tende a creare un nuovo rapporto tra il visitatore e le opere, con una presentazione chiara e di facile accesso che permetta diverse chiavi di lettura, senza trascurare di orientare attraverso appositi apparati esplicativi il pubblico meno preparato. Mentre si assiste a una ridefinizione del ruolo delle istituzioni museali in dimensione urbana, se ne invoca anche l’autonomia, l’attitudine quasi imprenditoriale alla programmazione economica e il fattivo ingresso nel mondo della produzione culturale, nonché la capacità di conciliare le esigenze della conservazione, poste quotidianamente dal patrimonio artistico e storico, con le aspettative di spettacolarità che contraddistinguono molti fenomeni sociali contemporanei e che non mancano di far sentire il proprio richiamo anche in questo settore. Il dibattito politico degli anni Ottanta, che ha portato all’elaborazione di numerose proposte di riforma delle istituzioni e della legge di tutela, ha insistito sull’importanza di una maggiore autonomia dei musei e dell’arricchimento dell’offerta museale. Tali istanze hanno trovato parziale accoglimento sul piano legislativo con il provvedimento n. 4 del 13 aprile 1993. Il testo di legge prevede orari prolungati di apertura, maggiore offerta di servizi al pubblico (dalle caffetterie alle librerie) e uno stretto rapporto con le associazioni del volontariato: quest’ultimo aspetto, inedito per il nostro paese, favorisce un sempre più stretto rapporto fra le istituzioni culturali e la società civile.
Alla proiezione del museo verso l’esterno hanno contribuito, soprattutto in questi ultimi anni, gli interventi di sponsorizzazione privata, inizialmente rappresentata soprattutto dagli istituti di credito, cui si sono aggiunte imprese private e industrie. L’iniziativa privata, originariamente rivolta ad attività editoriali, ha poi moltiplicato gli interventi, comprendendovi restauri, attività didattiche e promozionali, servizi, fra cui l’apertura di alcune istituzioni in orari serali, prestazioni assicurative o di trasporto in occasione di mostre itineranti.
Il problema è stato anche recepito dal legislatore, che ha elaborato il testo della legge del 2 agosto 1982 n. 512, peraltro ancora priva di regolamentazione. Le norme emanate riguardano una serie di agevolazioni fiscali che possono stimolare il privato a investire in questo campo. Le innovazioni sono assai significative: basti pensare che precedentemente (DPR 597/1973, art. 60) si prevedeva esclusivamente la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di istituti culturali per un ammontare complessivo non superiore al 2% del reddito d’impresa. L’articolo 3 del provvedimento contempla invece la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni in denaro, di cui non viene precisata l’entità, a favore di enti pubblici o di fondazioni regolarmente riconosciute, destinate sia all’acquisto, al restauro, alla conservazione delle “cose” indicate nella legge n.1089 del 1939, sia all’organizzazione di mostre e di esposizioni riconosciute d’importanza artistica e culturale. L’articolo 6 dello stesso provvedimento inoltre prevede che gli eredi e i legatari di beni di rilevante interesse artistico e culturale, e quindi anche di opere d’arte, possano pagare l’imposta di successione mediante cessione totale o parziale a detti enti degli stessi beni, a scomputo di quanto da loro dovuto.
Grande rilievo ha assunto in questi anni la programmazione delle attività espositive che propongono approfondimenti su temi specifici o generali della produzione artistica. Sempre più numerose sono le iniziative di divulgazione e di didattica rivolte al pubblico adulto e alla popolazione in età scolare, con proposte e percorsi diversificati per soggetto, durata e grado di com...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- INTRODUZIONE, di Christian Greco
- Museo
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Museo di AA.VV.,AA.VV. in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Architettura e Pianificazione urbana e paesaggistica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.