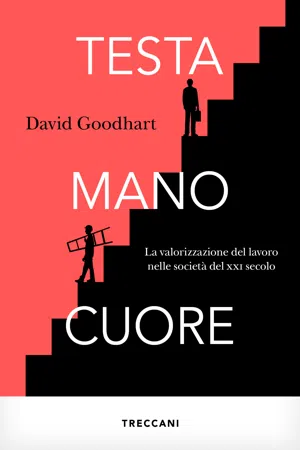
eBook - ePub
Testa, mano, cuore
la valorizzazione del lavoro nelle società del XXI secolo
- 449 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Testa, mano, cuore
la valorizzazione del lavoro nelle società del XXI secolo
Informazioni su questo libro
La pandemia da coronavirus ha rivelato ciò che avremmo dovuto sapere già da tempo: infermieri, operatori sanitari, lavoratori dei supermercati, corrieri, addetti alle pulizie, badanti hanno un ruolo essenziale per la società, che tuttavia non è stato loro fino a oggi riconosciuto, sia in termini di rispetto sia dal punto di vista economico. A questo esito conduce anche l'approfondita indagine che David Goodhart ha svolto in diversi paesi occidentali, particolarmente ricca di dati e numeri. Goodhart divide il mondo del lavoro in tre categorie: alla prima appartengono le persone che lavorano "con la testa" (lavoro cognitivo), alla seconda quelle che svolgono un'occupazione manuale, alla terza coloro che si avvalgono del "cuore" e dunque operano nel settore della cura. Di ciascun gruppo considera lo status e l'influenza. Il risultato? Il lavoro cognitivo è considerato ovunque più "prestigioso", è meglio retribuito ed è l'obiettivo a cui tende la maggior parte delle università nel formare gli studenti. In poche parole, è diventato il "gold standard" della stima umana, e chi lo svolge modella la società prevalentemente nel proprio interesse e detiene il potere. Questo squilibrio ha portato alla disaffezione e all'alienazione di milioni di persone che lavorano negli altri due ambiti. David Goodhart rivela la storia finora "indicibile" di questa disparità e illustra le sfide concrete che dovremo affrontare per superarla e vivere in una società sana e democratica.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Testa, mano, cuore di David Goodhard, Elisa Dalgo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Teoria sociale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
PARTE SECONDA
La scalata cognitiva
4
L’era della selezione educativa
Dov’è la saggezza che abbiamo perduto sapendo?
Dov’è la sapienza che abbiamo perduto nell’informazione?1
THOMAS STEARNS ELIOT
La gran parte delle persone, di certo dei politici, ritiene che una maggiore istruzione formale sia un bene indiscutibile che aiuta le economie a crescere più velocemente, le società a diventare più civilizzate e i singoli a guadagnare di più e a diventare in qualche modo migliori. È opinione diffusa che una popolazione più istruita rientri in una storia teleologica del progresso umano, che tutti in principio fossimo esseri primitivi governati dall’istinto e che in seguito la ragione abbia assunto un ruolo sempre più importante nelle questioni umane. All’inizio il comando era affidato a una piccola élite alfabetizzata, ma a poco a poco l’alfabetizzazione è divenuta la norma, almeno nelle società ricche, seguita dall’istruzione di massa a livello primario, poi secondario e ora superiore.
Considerando i benefici arrecati all’umanità dalla conoscenza e dalla sua applicazione negli ultimi duecento anni, sembra un controsenso affermare che il ritorno economico dell’istruzione, soprattutto quella superiore, sia in calo. Eppure la tesi centrale di questo libro è che, almeno nei paesi ricchi, ci stiamo avvicinando al “picco della Testa” e che guidare sempre più diplomati verso l’istruzione accademica superiore non è sensato né da un punto di vista politico né da un punto di vista economico. L’ampliamento del sistema di istruzione superiore ha avuto senso per qualche decennio, tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI, ma ora quel tempo è passato. Molte convinzioni diffuse sull’istruzione superiore e sui suoi vantaggi per l’individuo e per la società intera oggi corrispondono solo in parte al vero: basta considerare che, proprio ora che la percentuale di laureati tra la popolazione attiva ha subìto un forte aumento, la produttività è rallentata nella maggior parte delle economie sviluppate, la disuguaglianza è cresciuta (o quanto meno non si è ridotta) e la polarizzazione politica si è accentuata.
La condizione ideale che molti di noi si figurano quando pensano all’istruzione in termini astratti – per esempio allo studio della medicina, che coniuga un apprendimento professionalizzante e accademico con una carriera lavorativa indubbiamente utile e ben remunerata – per la maggior parte delle persone è assai lontana dalla realtà. Molti titoli accademici ambìti non sono poi così strettamente correlati all’occupazione futura e spesso sono una forma di credenzialismo, poiché servono a segnalare ai datori di lavoro la posizione del singolo rispetto agli altri anziché attestare la sua padronanza di complesse competenze cognitive.
Naturalmente può esistere una preziosa ricerca intellettuale che non ha finalità credenziali né professionali. Un mio amico dice che all’università ha studiato Kant per un anno intero e ora non saprebbe scrivere nemmeno una frase di senso compiuto su di lui, ma ritiene comunque che quello studio gli abbia insegnato a pensare: una sorta di palestra intellettuale. È però dimostrato che al di fuori delle principali facoltà professionalizzanti, come medicina o ingegneria, molti studenti non apprendono – o non assimilano – molto dai loro studi, ed è difficile valutare se imparino a pensare in maniera critica.
In alcuni casi l’istruzione è “ciò che ci resta dopo che abbiamo dimenticato tutto quello che ci hanno insegnato”, come vuole il vecchio adagio. Il problema è questo. L’istruzione in molti casi è un bene culturale e un investimento economico sia per i singoli sia per la società. Ma è anche una specie di corsa agli armamenti che indirizza le persone verso diverse correnti occupazionali. In genere a livello individuale ha senso investire nell’istruzione, ma a livello sociale tale investimento può essere in parte mal riposto.
Nel momento in cui, grazie al surplus di laureati, gli annunci di lavoro per assistenti educativi e impiegati contabili in Gran Bretagna iniziano a richiedere abitualmente la laurea, è ovvio che chi aspira a lavorare in questi ambiti si adoperi per conseguirla. Tuttavia sarebbe meglio, sia per i singoli sia per la società, se si interrompesse la corsa agli armamenti e queste occupazioni tornassero accessibili a diplomati coscienziosi, com’erano in passato. Il fatto non è che stiamo investendo troppo nell’istruzione in generale, ma che stiamo forse puntando troppo sulla ricerca di credenziali da parte degli “specialisti degli esami” e troppo poco sulle competenze vocazionali, professionali e tecniche, come pure nella formazione permanente, di cui gran parte della popolazione, nonché dell’economia, ha bisogno per poter prosperare. È un po’ come dotarsi di un’arma nucleare all’avanguardia e intanto lasciare che i carri armati e l’artiglieria vadano in rovina.
Vale la pena ricordare i traguardi raggiunti nell’Ottocento e nel primo Novecento dai nostri antenati, molti dei quali avevano solo un’istruzione minima. Negli anni Sessanta la situazione era ancora invariata. Come hanno scritto Mark Bovens e Anchrit Wille in Diploma Democracy, «L’idea che il successo scolastico fosse l’unica strada per l’affermazione personale non esisteva negli anni Sessanta. Molti di quelli che non andavano bene a scuola raggiungevano comunque il successo, e il concetto stesso di “successo” era ampio e variegato»2. Se lasciamo che i risultati accademici diventino l’unica strada percorribile per ottenerlo, noi sottraiamo possibili futuri talenti alle forze di polizia, al diritto, alla pubblica amministrazione e all’imprenditoria privata.
Nel 1972 più del 40% degli alunni nel Regno Unito terminava gli studi senza alcun titolo (salvo in alcuni casi il Certificate of Secondary Education3)4. Negli Stati Uniti il dato era leggermente più basso: circa il 25%. A quell’epoca perfino le scuole private del Regno Unito riuscivano a indirizzare soltanto la metà circa degli studenti all’università5. Nel 1974, anno in cui ho concluso gli studi a Eton, molti dei miei compagni di scuola sono entrati direttamente nelle aziende di famiglia, hanno avviato una professione o si sono arruolati. Oggi più del 90% degli studenti delle scuole elitarie si iscrive alle migliori università.
All’inizio degli anni Settanta la maggior parte degli esami era ancora riservata a una minoranza, anche nei paesi sviluppati. All’epoca in Inghilterra solo uno studente su tre sosteneva gli O levels (il principale esame scolastico per i sedicenni) e circa il 15% sosteneva almeno un A level (esame di maturità/ammissione all’università per studenti di età compresa tra diciassette e diciotto anni). Esistevano solo una trentina di università, a cui si iscriveva il 9% dei diplomati.
Nel 1988 il GCSE (General Certificate of Secondary Education, certificato generale di istruzione secondaria), concepito per coprire una gamma più ampia di abilità e destinato a tutti gli studenti, ha sostituito gli O levels. Secondo il Dipartimento dell’Istruzione, attualmente circa il 47% degli alunni si sottopone agli A levels e quasi la metà dei diplomati prosegue gli studi. Questo ha inevitabilmente comportato un abbassamento degli standard: oggi ottenere una “A” negli A levels o un ottimo punteggio di laurea in molte università è più facile che negli anni Settanta6.
Il secondo dopoguerra e in particolare gli anni Settanta hanno inaugurato l’epoca della selezione educativa. Nella seconda metà del XX secolo molti paesi sviluppati, Stati Uniti in testa, sono passati dalla diffusione di massa dell’alfabetizzazione e della capacità di calcolo a quella dell’istruzione primaria, poi secondaria e infine superiore.
Negli Usa fu il Gi Bill del 1944 in favore dei veterani di guerra a spianare la strada per l’istruzione superiore di massa. Ricompensare i veterani era una prassi consolidata nella politica statunitense, e la sensazione che le misure adottate dopo la prima guerra mondiale fossero state insufficienti spinse Roosevelt ad accordare benefici molto più generosi nel 1944, che comprendevano non solo il finanziamento dell’istruzione universitaria ma anche mutui a tasso ridotto e assistenza sanitaria. Nessuno poteva sapere quanti veterani avrebbero accettato l’offerta: in realtà furono più di un milione, abbastanza per raddoppiare il numero di studenti universitari già alto, almeno rispetto all’Europa, e portarlo a 2 milioni nel 1951, quando nel Regno Unito raggiungevano appena i 100.000. Nel 1961 la cifra era già raddoppiata nuovamente, raggiungendo i 4 milioni, e negli anni Settanta circa il 40% dei diplomati proseguiva gli studi, anche se solo un quarto di loro seguiva corsi di laurea quadriennali, mentre gli altri frequentavano corsi biennali in un community college7. Nel 2018 la percentuale era salita al 50% circa, ma solo un terzo degli studenti frequentava corsi quadriennali per ottenere il bachelor’s degree8.
L’espansione della classe cognitiva in tutti i paesi ricchi è stata inizialmente un cambiamento ben accolto e necessario. L’economia e l’espansione del settore pubblico richiedevano più lavoratori nell’ambito della Testa e relativamente meno nella Mano. Come vedremo nel prossimo capitolo, il ritorno della conoscenza e dell’istruzione in termini retributivi ha iniziato a decollare negli anni Settanta, dopo quasi un secolo di compressione salariale tra Testa e Mano.
Le teorie di Frederick Winslow Taylor sull’organizzazione scientifica del lavoro, sviluppate negli Stati Uniti prima della Grande guerra, avevano dato vita alle enormi fabbriche per la produzione di massa, mettendo fine al monopolio delle conoscenze del processo produttivo da parte dei lavoratori qualificati e scomponendo il lavoro in funzioni facili da svolgere. Tutto questo richiedeva una minore abilità manuale ma un certo grado di alfabetizzazione e di capacità di calcolo. La standardizzazione e la specializzazione tayloriste aumentarono la produttività in maniera esponenziale: negli anni Settanta tante aziende assumevano molti più laureati in marketing, vendite, ingegneria, It e gestione che non addetti alle linee di produzione, sempre più automatizzate. Anche le professioni di alto livello cognitivo – medici, scienziati, insegnanti, avvocati, commercialisti – hanno registrato una crescita consistente, tanto che la quota di lavoratori coinvolti in attività professionali in senso lato è passata da percentuali a una sola cifra, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, all’attuale 30-40%. Questa tendenza è stata riscontrata in tutti i paesi sviluppati, ma le tradizioni dei singoli Stati hanno determinato diversi atteggiamenti nei confronti della conoscenza e del rapporto tra Testa e Mano (come descritto nel capitolo 2).
All’inizio del Novecento l’Inghilterra, come abbiamo visto, optò per un sistema nazionale di istruzione superiore socialmente esclusivo dominato da Oxford e Cambridge – che imponeva il suo ethos attraverso commissioni d’esame e borse di studio al resto del settore educativo nascente. Elemento cardine dell’istruzione superiore era il principio dell’università residenziale.
Questa tendenza derivava in parte dal tipo di educazione che le famiglie della classe medio-alta impartivano ai figli, come spiega Nick Hillman, direttore dell’Higher Education Policy Institute:
È difficile che i figli mandati a otto anni alla boarding school9 tornino a casa a diciotto anni per frequentare l’università, perché ormai hanno tagliato da tempo il cordone ombelicale. È quindi più probabile che si trasferiscano ancora più lontano per consolidare la loro indipen...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- PREFAZIONE
- PARTE PRIMA. Il nostro problema
- PARTE SECONDA. La scalata cognitiva
- PARTE TERZA. Mano e Cuore
- PARTE QUARTA. Il futuro
- RINGRAZIAMENTI
- BIBLIOGRAFIA