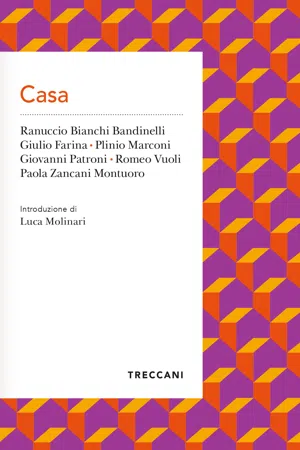
- 192 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Le case sono la nostra vita, e mai come in questo anno e mezzo ce ne siamo resi conto: ospitano emozioni, paure, desideri, stanchezza, entusiasmo, speranze. Protagoniste di un cambiamento radicale dei nostri paesaggi nel secolo scorso, palcoscenico della metamorfosi sociale ed economica di un paese che entrava nella modernità, hanno colonizzato il territorio estendendosi sulle coste e verso le periferie: ville, villette, case a schiera, palazzine, condomini, case popolari, camper, loft, co-housing... I paesaggi metropolitani sono insomma mutati sotto la pressione e il desiderio di un'abitazione nuova. Parlare oggi di casa – pur a partire dalla sua storia, ricostruita in queste pagine – significa porsi in una prospettiva più ampia, ci spiega Luca Molinari, spostarsi dalla casa singola all'ambiente e a un'idea sempre più densa e contraddittoria di ecosistema di individui e manufatti ormai invecchiati. La pandemia ha chiaramente dimostrato che non solo il modello abitativo attuale non risponde più alle esigenze della maggior parte della popolazione, ma che la relazione tra casa e città è sempre più inscindibile e presuppone un cambio di visione che accolga un tempo di profondi cambiamenti.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Casa
Casa
Dal lat. casa «capanna»; fr. maison; sp. casa; ted. haus; ingl. house. È una costruzione elevata dall’uomo a scopo di abitazione, diversa nel materiale, nelle proporzioni o nella disposizione degli ambienti, nell’ornamento esterno come nell’arredamento interno, a seconda delle epoche e dei popoli e a seconda della classe di abitatori per cui è costruita. Alle volte, particolari caratteristiche nella sua costruzione e nella sua destinazione fanno che essa si chiami castello, palazzo, villa. Nei tempi moderni col termine casa si designano spesso edifizi non destinati a uso di normale abitazione (casa di salute, casa di riposo, casa di correzione, casa di pena), mentre altri edifizi destinati ad abitazione di particolari categorie di persone assumono denominazioni diverse: albergo, carceri, caserma, collegio, convento. Nella sua accezione particolare, la casa moderna è l’edifizio destinato nei centri abitati ad abitazione di più famiglie che generalmente ne prendono in affitto ciascuna una parte (appartamento), laddove in epoca anteriore alla nostra la casa era generalmente abitata da una sola famiglia che l’aveva in proprietà.
Prima di esaminare la casa contemporanea nella sua struttura architettonica e in rapporto alle condizioni economiche e sociali dei suoi abitatori, non rimarrà che considerare alcuni tipi storici di casa, che, per i problemi molteplici relativi alla loro configurazione e per l’interesse storico archeologico che essi presentano, meritano una trattazione particolare.
1
La casa egiziana
Per il periodo preistorico furono rilevate tracce di buchi per pali che dovevano sorreggere frascami, forse spalmati di mota. Ma già sulla fine di quel tempo si trovano resti di abitazioni con mattoni crudi. Un modello in terracotta mostra una pianta rettangolare, la porta sormontata da un architrave di legno aperta in uno dei lati minori; sull’opposto, la finestra. Per il regno antico, mancano documenti archeologici. Naturalmente le case differivano secondo le condizioni economiche. In Illāhūn, allo spazio occupato da 200 o 250 abitazioni operaie corrispondono all’incirca 10 o 11 abitazioni nobili. Di queste una, ad esempio, misura 45 m per 60 e tra camere, corridoi, annessi ne furono contati 70. Il centro era costituito da un cortile a colonne che serviva per sala di ricevimento; le abitazioni private del padrone e delle donne stavano ai lati. Oltre alle camere da letto, c’era la sala per mangiare, il cortile della cucina, dove non solo si preparavano le vivande, ma si macellava, si cuoceva il pane, si allestiva la birra. Non manca il piccolo altare davanti al quale si pregava. Sappiamo dell’esistenza di camere da bagno, ma nel medio regno non se ne sono rilevate. Separate dal resto erano le abitazioni della servitù e i magazzini. I pavimenti erano di terra del Nilo battuta; le mura talvolta venivano dipinte; il soffitto in genere era di legno. Si trovano pure piani superiori. Alcune villette mostrano facciate ornate di colonne che danno sul giardino. Nel nuovo regno, come si osserva a Tell el-‘Amārna, la sala dei ricevimenti è coperta; il soffitto è sostenuto da una colonna centrale. Essa è preceduta da un’anticamera che in un certo modo la sottrae agli sguardi indiscreti della via; i bagni mostrano le loro vasche. L’arredamento indispensabile anche a un modesto cittadino era costituito dal letto di legno a quattro gambe, piuttosto basso; dal poggiatesta semilunare poggiato su una colonnina, cuscini, seggiole e sgabelli di varie fogge; da tavole basse per mangiare, stuoie, cofani di legno per riporre oggetti ecc.
•Bibliografia
Sulla casa egiziana: L. BORCHARDT, Das altäg. städtische Wohnhaus, in Centralblatt der Bauverwaltung, XIII, pp. 517 segg.; ID., Über das altäg. Wonhaus mit besonderer Berücksichtigung der Innendecoration, in Deutsche Bauzeitung, XXVIII, pp. 200 segg.; N. DE G. DAVIES, The Town House in Ancient Egypt, in Metropolitan Museum Studies, I, 1929; A. ERMAN, Ägypten und äg. Leben im Altertum, Tubinga 1885-87, voll. 2; F. MASPERO, L’archéologie égyptienne, nuova ed., Parigi 1907; I. ROSELLINI, Monumenti dell’Egitto, Pisa 1833-44, II, II, pp. 378 segg.; M. UHLEMANN, Handbuch ägypt. Altertumskunde, Lipsia 1857-58; A. WIEDEMANN, Das alte Ägypten, 1920, pp. 162 segg. Cfr. anche: H. H. NELSON, U. HÖLSCHER, Medinet Habu 1924-28; U. HÖLSCHER, J. A. WILSON, Medinet Habu Studies 1928-29, in The Or. Inst. of the Univ. of Chicago.
2
La casa greca
La casa greca, attraverso tutto il vasto ambito cronologico del suo sviluppo e le sue fasi successive, presenta una certa uniformità e continuità di tipo dalle origini neolitiche fino a tutta l’età ellenistica: una stanza principale, dove la famiglia mangia, s’intrattiene e riceve gli ospiti intorno al focolare, preceduta da un cortile. Questo schema fondamentale persiste attraverso i secoli pressoché immutato, se pur modificato o reso meno evidente per le numerose aggiunte di locali accessori.
Due sono le forme primitive che compaiono nell’oriente ellenico: la casa rotonda, che riproduce il tipo originario della capanna circolare ed è quindi più proprio di genti che, pure stanziandosi, hanno serbato le consuetudini della vita nomade, e la casa a pianta rettangolare o quadrata (megaron). La prima prevale sul continente, la seconda nell’Egeo; ma i paletnologi non sono d’accordo sulla genesi di questi due tipi, giacché alcuni ritengono che il megaron sia stato creato nei freddi climi settentrionali e da nordiche genti importato poi a sud-est, e che il tipo circolare sia stato invece introdotto dall’Oriente attraverso l’Egeo, dove appunto, più presto compiutasi la sua evoluzione, sia scomparso interamente; mentre altri al contrario considerano europeo soltanto il tipo circolare, che per il suo tetto conico sarebbe stato più adatto ai climi piovosi, e orientale invece il megaron, che sarebbe passato sul continente col diffondersi della civiltà cretese. Certo è che la sostituzione di materiali più solidi (pietre, argilla ecc.) ai tronchi e ai rami primitivi segna la prima tappa dello sviluppo architettonico della casa a forma di capanna.
Già nel primo strato di Orcomeno in Beozia, i cui resti risalgono allo scorcio del III millennio a.C., troviamo case circolari, che hanno fino a 6 metri di diametro interno, e sono formate da un basamento di pietre rozzamente squadrate, sovrapposte in più filari e connesse a secco (altezza 0,50-1 m, larghezza circa 1 m), e da un ampio tetto conico di mattoni cotti al sole; uno strato d’argilla battuta segna il pavimento e si può supporre che la cupola raggiungesse un’altezza massima di 7 m; tipo rudimentale di abitazione che trova perfetti paralleli moderni nelle capanne del Kurdistan e dell’Africa meridionale, e le cui tracce ricompaiono in altri luoghi (Sesklo in Tessaglia) del continente greco, ma che possiamo credere adoperato anche nel bacino dell’Egeo, riconoscendone l’immagine in un’urna votiva dell’isola di Amorgo, e considerando le tombe a cupola cretesi e micenee come rituale sopravvivenza millenaria della più antica forma di abitazione. È infatti oltremodo probabile che il sepolcro ripetesse lo schema della casa, tradotto in materiali più durevoli e, persistendo poi tradizionalmente immutato, con mezzi tecnici ben più perfetti. Del resto tutta la civiltà neolitica nel bacino occidentale del Mediterraneo offre l’analogia di costruzioni rotonde in pietra a cupola, così funerarie come domestiche.
Questa forma non consentiva, dato il sistema di copertura, né suddivisioni né ingrandimenti: si dovette quindi ricorrere alla giustapposizione di più case simili intorno a un cortile centrale per conciliare le maggiori esigenze, come appare da un’urna di Melo e meglio risulta dal confronto con attuali civiltà primitive dell’Africa; ma lo sviluppo del tipo costruttivo avviene col passaggio dalla forma circolare alla ovale, più spaziosa e più facilmente divisibile con muri interni, che appare nel secondo strato di Orcomeno, a Olimpia, a Rhini in Tessaglia; a Thermos in Etolia troviamo due case ellittiche unite fra loro ad angolo retto; a Chamaizi in Creta vediamo invece una grande abitazione ellittica (14,50 × 22,20 m), databile agli inizi del II millennio, suddivisa con muri trasversali in molti vani irregolari, non comunicanti fra loro, ma ai quali si accedeva da un cortile centrale, che doveva essere scoperto per dar luce agli interni. Allungandosi in pianta l’ellissi, i muri laterali diventavano sempre meno curvi, mentre, acquistando importanza la porta d’ingresso, veniva a schiacciarsi sempre più uno degli estremi, finché si arrivò a ottenere una forma rettangolare absidata (Orcomeno, Olimpia, Tirinto) con muri interni paralleli alla facciata (isole di Siro e Paro, Rachmani in Tessaglia, Thermos, Korakou presso Corinto). Durante questa fase è presumibile che il tetto, modificandosi secondo l’edificio, sia venuto ad acquistare i due pioventi sui lati lunghi con l’esser sostenuto da una travatura orizzontale, mentre sull’abside postica sussisteva la forma di mezza cupola e sull’ingresso risultava forse il timpano frontonale. Infine l’abside finì per essere eliminata e ci appare da ultimo qui segmentata (Rachmani), lì poligonale (Lianokladi in Tessaglia): si giunge quindi a un edificio rettangolare, tripartito in lunghezza, di cui possiamo immaginare che il vano anteriore fosse il vestibolo, l’ultimo il talamo, mentre la sala mediana più vasta accentrava intorno al focolare tutta la vita domestica e sociale.
Già dall’età neolitica, a Magasa e Tripiti in Creta, appare il tipo di casa rettangolare o quadrata, che si diffonde poi con variazioni locali nelle altre isole (Phylakopi in Melo, Thera), sulle coste asiatiche (Troia) e sul continente (Dimini, Sesklo e Tsangli in Tessaglia, Zygouries e Korakou in Argolide); forma che al suo sorgere non presenta nessuna caratteristica notevole, mentre assume un aspetto tipico fin dalla prima età del bronzo, età alla quale risale il secondo strato di Hissarlik (2000 a.C. circa): il megaron è qui un rettangolo stretto e allungato, scompartito in due o tre vani successivi, di cui il maggiore contiene il focolare rotondo; i muri son costituiti da un basamento a scarpa di rozze pietre cementate con terra, e da un elevato di mattoni crudi intramezzati e sostenuti alle estremità da assi di legno, mentre tavole di legno rivestivano le testate dei muri (antae) e completavano l’architettura. Il megaron più tardo, quale troviamo nel sesto strato di Hissarlik, che è da identificarsi con la Troia omerica, e negli altri luoghi coevi (Phylakopi, acropoli di Micene ecc.), ha forma più quadrata, cioè costituisce un rettangolo più allargato. Con l’ingrandirsi delle costruzioni divenne necessario sostenere la travatura del tetto (sia la trave maestra longitudinale, se il tetto aveva i due pioventi, sia i correnti trasversali nella copertura a terrazza), e così furono aggiunti pilastri di pietra o colonne lignee in unico o duplice filare al centro delle sale, quando la loro ampiezza lo richiese (Thera, Zygouries, Korakou ecc.). Infine appaiono due colonne fra le ante del vestibolo a costituire il portico anteriore del megaron, che raggiunge così la sua tipica forma definitiva (Dimini e Sesklo in Tessaglia, palazzo di Tirinto ecc.), tradizionale in tutta l’antichità, da cui prenderà le mosse più tardi lo sviluppo del tempio greco classico e che persisterà anche nell’architettura domestica fino a tutto l’ellenismo. Ma col fiorire della grandiosa civiltà cretese-micenea si ebbero strutture monumentali e costruzioni complesse, alle quali le case private del genere comune servirono di modello (e già i megara del secondo strato di Hissarlik sono allineati e compresi in un recinto a costituire un insieme) e delle quali il megaron col focolare rappresenta il nucleo tradizionale e l’intimo centro. Peraltro, col progresso dei mezzi tecnici e col manifestarsi del bisogno di addensare le abitazioni in aree relativamente limitate – necessità di tutti i centri popolosi –, già da tempo si era aggiunto un altro piano superiore, e anche due, e persino un attico; di tali case a pianta complicata, che spesso lascia dedurre l’esistenza di un secondo piano, non mancano resti nelle isole egee (Paleocastro, Cnosso, Vasiliki ecc. in Creta, Psira, Melo ecc.) e sul continente (Micene, Tirinto), ma una precisa idea della perfezione raggiunta dall’architettura cretese fin da prima del XVII secolo a.C. si può avere dalle facciate riprodotte su tavolette di maiolica policroma trovate a Cnosso: prospetti meravigliosi per la compiutezza della loro struttura e decorazione, con i vari piani, le numerose finestre e altri particolari, che danno un’impressione di modernità.
Della casa omerica si dava, prima delle scoperte archeologiche, una ricostruzione teorica fondata sui dati dei poemi, oggi non più accettabile, mentre si può sommariamente dire che i grandiosi edifici dei quali persiste un riflesso poetico nell’epica più antica sono i palazzi della civiltà egeo-micenea, e che dai più il palazzo di Gla sul lago Copaide in Beozia viene identificato con l’omerica Arne. Le parti principali della casa omerica sono la corte (αὐλή) con l’ara di Zeus Herkeios, circondata da un portico (αἴϑουσα), e il megaron o sala principale, cui si accedeva dalla corte attraverso un propileo (πρόδομος) e dove, intorno al focolare (ἐσχάρα), si svolgeva la vita, e infine il quartiere delle donne (γυναικωνῖτις). A questi elementi principali si aggiungevano gli accessori, come le stanze da letto (ϑάλαμοι); è da ritenere che nei tipi meno complessi la famiglia dormisse nel megaron e gli ospiti alloggiassero nel portico.
Le successive ondate di genti barbariche che si riversarono sulla regione greca determinarono il ripetersi di tutto il ciclo di sviluppo della casa dalla forma circolare alla rettangolare, giacché ciascuna tribù portava seco la tradizione della capanna primitiva: così, mentre seguiamo l’evoluzione negli strati di Orcomeno, che hanno per noi il pregio della continuità indiscutibile, abbiamo il riflesso del ciclo compiuto nelle tombe “achee”; infine l’ultima ripetizione dello stesso fenomeno si ha nel Medioevo greco, dopo la fine della civiltà cretese-micenea e all’alba dell’età classica.
Delle case di età classica non sopravvivono disgraziatamente che miseri avanzi, affatto insufficienti per tracciarne con sicurezza la pianta, o, almeno, per seguirne l’evoluzione. Certo è che l’architettura privata non ebbe importanza presso i Greci fino a tutto il V secolo a.C.; le abitazioni furono semplici e modeste, serbandosi del tutto accentrate e concluse in loro stesse, in antitesi con la concezione moderna delle case che sorgono in rapporto alla strada.
Tale principio è giustificato e dal clima e dai costumi; infatti la vita si svolgeva in gran parte all’aperto, sicché il padrone rientrava soltanto per i pasti e per dormire nella casa, dove si trattenevano invece le donne: era dunque n...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- INTRODUZIONE: di Luca Molinari
- CASA
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Casa di Ranuccio Bianchi Bandinelli,Giulio Farina,Plinio Marconi,Giovanni Patroni,Romeo Vuoli,Paola Zancani Montuoro in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Pianificazione urbana e paesaggistica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.