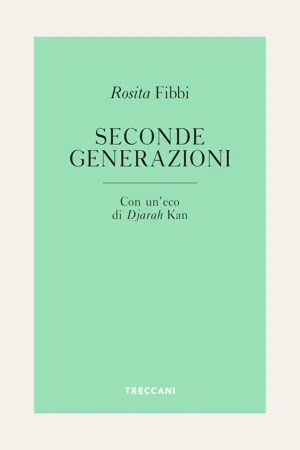
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Seconde generazioni
Informazioni su questo libro
«L'emergere della tematica dei figli degli immigrati denota il passaggio dalla logica di breve periodo della regolazione dei flussi migratori in funzione del mercato del lavoro alla logica di lungo periodo dell'istallazione delle popolazioni d'origine immigrata e della loro integrazione nel tessuto sociopolitico del Paese d'immigrazione.» (da Seconde Generazioni di Rosita Fibbi)
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
Emigrazione e immigrazioneDINAMICHE SOCIALI E IDENTITÀ NELLE SECONDE GENERAZIONI
Per acquisire legittimità, le dinamiche sociali d’esclusione si appoggiano su una costruzione culturale dell’alterità che unifica gruppi disparati in un’identità negativa essenzializzata, in riferimento a una concezione della cultura e dell’appartenenza etnica come ‘naturale’, reale, stabile nei quali sono confinati i gruppi minoritari stigmatizzati. In Europa, il denominatore religioso islamico (Zolberg, Long Litt Woon 1999; Drouhot, Nee 2019) funge da principio unificatore di gruppi molto eterogenei, originari dell’Asia meridionale, dell’Africa settentrionale, del Mediterraneo orientale, nonché di Paesi europei storici, quali la Bosnia e l’Albania, relegandoli in un’alterità presentata come insormontabile nel discorso pubblico.
ESCLUSIONE E IDENTITÀ
Nella teoria dell’assimilazione, l’identificazione degli immigrati e dei loro discendenti con il gruppo etnico tende a essere intesa come espressione della presunta limitata volontà di integrazione della popolazione immigrata (Heath 2014). Questo assunto, che solleva ‘ansietà di assimilazione’ tra i membri della maggioranza del gruppo, non tiene conto del fatto che identificarsi e (ri)valorizzare il gruppo di appartenenza, benché stigmatizzato, costituisce una strategia di risposta dei gruppi emarginati per conservare un’immagine positiva di sé e proteggere il proprio benessere psicologico. Così l’analisi empirica invita a rovesciare i termini della relazione. È proprio la socializzazione culturale riuscita nel Paese in cui sono cresciuti ad alimentare le aspirazioni dei figli degli immigrati, a rendere intollerabile la rappresentazione negativa proiettata su di loro dalla società d’immigrazione e a indurli a rivoltarsi contro l’esclusione socioeconomica che subiscono: essi rispondono a queste sfide con una ‘identità reattiva’ (Portes, Rumbaut 2001), fabbricata nel Paese di immigrazione con valenza aggregante e carica oppositiva verso una società che li emargina. È così che, per esempio, Olivier Roy (1991) comprende l’identificazione etnica e religiosa dei giovani marginalizzati di origine maghrebina in Francia. Osservando che l’arabo non è usato come lingua di comunicazione nelle ‘comunità’ arabe, che la religione è piuttosto un richiamo simbolico che una pratica reale, Roy parla di «etnia inventata» e di «islam immaginario». Anche Çetin Çelik (2015), con la sua indagine qualitativa su alcuni giovani di origine turca in Germania che hanno abbandonato la scuola, corrobora il modello di rifiuto-identificazione (Schmitt, Branscombe, Postmes, Garcia 2014). Osservando il trattamento sfavorevole degli insegnanti nei loro confronti, essi sviluppano una profonda sensibilità alla discriminazione che colpisce gruppi singolarizzati sul piano religioso, a differenza di altri immigrati di origine cristiana. Mentre questi ultimi possono elaborare percorsi identitari assimilativi o misti, i giovani turchi e curdi aderiscono fortemente alla loro identità d’origine come risposta alla percezione di una mobilità sociale bloccata. Per Çelik, l’identità reattiva si trasforma in identità oppositiva quando la discriminazione percepita coincide con la stigmatizzazione, cioè il rifiuto della cultura minoritaria da parte del gruppo maggioritario.
La questione delle dinamiche identitarie presso i discendenti di immigrati è diventata più pressante in relazione alla cosiddetta radicalizzazione, il ricorso cioè all’azione politica violenta da parte di individui o gruppi minoritari che rivendicano una identità musulmana. Il termine radicalizzazione compare per la prima volta nei discorsi politici e mediatici come associato alla migrazione in relazione agli attentati di Londra del 2005 imputati al cosiddetto jihadismo autoctono (Kastoryano 2017): nella seconda metà del primo decennio del Duemila, i protagonisti sono giovani di seconda e terza generazione o convertiti, ‘jihadisti di casa nostra’, cresciuti nei Paesi europei (Vidino 2014). È molto difficile identificare il profilo del terrorista islamico autoctono. In realtà, esiste un profilo demografico oggettivo degli individui che si radicalizzano: la maggior parte degli individui che entrano a far parte di gruppi radicali sono adolescenti o giovani adulti, in genere maschi (Verkuyten 2018, p. 22).
Non esiste invece un chiaro profilo sociologico: si tratta di soggetti estremamente eterogenei per origine etnica, istruzione e condizione sociale, uniti dalla comune fede jihadista. Gli studi politologici sul ricorso alla violenza politica hanno empiricamente confutato le ipotesi esplicative che lo imputavano alla ricerca identitaria o allo svantaggio sociale (della Porta 2018). La radicalizzazione poggia piuttosto sulle micro-dinami...
La questione delle dinamiche identitarie presso i discendenti di immigrati è diventata più pressante in relazione alla cosiddetta radicalizzazione, il ricorso cioè all’azione politica violenta da parte di individui o gruppi minoritari che rivendicano una identità musulmana. Il termine radicalizzazione compare per la prima volta nei discorsi politici e mediatici come associato alla migrazione in relazione agli attentati di Londra del 2005 imputati al cosiddetto jihadismo autoctono (Kastoryano 2017): nella seconda metà del primo decennio del Duemila, i protagonisti sono giovani di seconda e terza generazione o convertiti, ‘jihadisti di casa nostra’, cresciuti nei Paesi europei (Vidino 2014). È molto difficile identificare il profilo del terrorista islamico autoctono. In realtà, esiste un profilo demografico oggettivo degli individui che si radicalizzano: la maggior parte degli individui che entrano a far parte di gruppi radicali sono adolescenti o giovani adulti, in genere maschi (Verkuyten 2018, p. 22).
Non esiste invece un chiaro profilo sociologico: si tratta di soggetti estremamente eterogenei per origine etnica, istruzione e condizione sociale, uniti dalla comune fede jihadista. Gli studi politologici sul ricorso alla violenza politica hanno empiricamente confutato le ipotesi esplicative che lo imputavano alla ricerca identitaria o allo svantaggio sociale (della Porta 2018). La radicalizzazione poggia piuttosto sulle micro-dinami...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- ECO di Djarah Kan
- SECONDE GENERAZIONI
- NOZIONE, DENOMINAZIONE E NUMERI
- I FIGLI DEGLI IMMIGRATI NELLE ISTITUZIONI DELLA SOCIETà D’IMMIGRAZIONE
- I PROCESSI DI INTEGRAZIONE: DAI DATI EMPIRICI ALLE TEORIE
- PROCESSI E TEORIE
- DINAMICHE SOCIALI E IDENTITÀ NELLE SECONDE GENERAZIONI
- BIBLIOGRAFIA
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Seconde generazioni di Rosita Fibbi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Emigrazione e immigrazione. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.