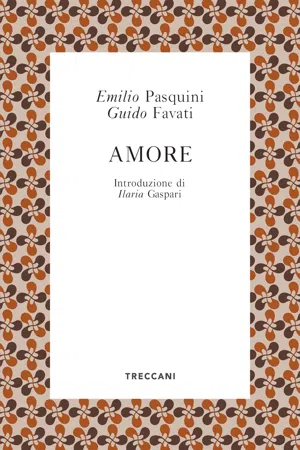
- 112 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Amore
Informazioni su questo libro
"Amor ch'a nullo amato amar perdona": chi di noi non conosce, ha sentito o declamato almeno una volta nella sua vita il famoso verso 103 del Canto V dell'Inferno della Divina Commedia, tra i più famosi dell'intera opera e della letteratura italiana in generale? Diventate simbolo per eccellenza dell'amore, quelle parole pronunciate da Francesca da Rimini, alla quale il Canto è quasi interamente dedicato, contengono il senso e l'intrinseca contraddizione di un sentimento che procura gioia incontenibile e allo stesso tempo indicibile dolore, e che il sommo poeta seppe descrivere in modo ineguagliabile. Termine-chiave dello Stilnovo e al centro del lessico dantesco, l'amore viene esplorato dettagliatamente in queste pagine dense nella sua articolata evoluzione e nelle più diverse declinazioni all'interno della produzione di Dante: percorre la Vita nuova, veste i panni della donna gentile-filosofa nel Convivio, esplode in un crescendo espressionistico nelle Rime fino a innestarsi nella Commedia in un contesto di magistrale respiro. Introducono il testo le riflessioni di Ilaria Gaspari, che all'universo sentimentale ha dedicato gran parte della sua produzione.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
AMORE
Per eccellenza il termine-chiave dello Stilnovo, fin dagli esordi al centro del lessico di Dante, anche perché la possibilità di considerarlo quasi costantemente personificato (con aperte collusioni fra i piani del nome proprio e del nome comune, spesso inscindibili) consente a Dante d’instaurare un assiduo dialogo con la divinità di quel mondo o d’inserirla nella mitologia della cerchia, attraverso la visualizzazione di tutti gli spiriti e funzioni dell’animo, fino a sfociare in un’affollata drammaturgia del cuore e dei sentimenti.
Viceversa il verbo dello Stilnovo non è proprio ‘amare’, la cui zona d’influenza è estesa invece a significati esorbitanti dall’hortus conclusus della scuola, e in genere della poesia d’amore, proprio per merito di Dante; il quale più spesso adopera altri predicati equivalenti o costruisce perifrasi con amore o Amore + verbo (ad es. ‘dare’, ‘fare’, ecc.). Se dunque lo spettro semantico di ‘amare’ è così ampio e poliedrico, o ben presto eccedente il lessico specializzato dello Stilnovo; se per i più raffinati giochi della casistica erotica Dante preferisce adoperare verbi diversi, non ci si dovrà stupire della ricchezza di significati del sostantivo anche al di là dell’orbita stilnovistica: questa però assai più cospicua di quella attinente al verbo, anzi – per l’insistenza della personificazione – prevalente sulle altre zone.
Distingueremo i semantemi seguendo una trafila possibilmente cronologica, che consentirà anche di percepire l’evoluzione concettuale del termine in Dante; in più – data la sua rilevanza oltre che onnipresenza –, di osservare da un privilegiato angolo di visuale l’arricchimento spirituale del poeta.
Scarteremo subito il luogo isolato e particolarissimo che traduce il titolo dei Remedia di Ovidio (Vn XXV 9); e ci libereremo di Amore toponimo nel Fiore, dove rende il francese Saint-Amour, designando una vittima insigne delle ipocrisie dei chierici (XCII 12 e CXIX 6).
1. Vadano al primo posto gli esempi del significato più vicino a quello usuale, di «passione fisica o sensuale», «sensualità», «attaccamento dei sensi», tanto universale da meritare registrazioni più estese del semplice rinvio solo per l’eco di certe immagini dantesche. Tale accezione, se resta esterna al Convivio, spesseggia invece nelle Rime, dove raggiunge e accompagna esiti di esasperata tensione espressionistica, parallela e speculare all’estrema passionalità che pervade le ‘petrose’ infervorando il linguaggio dantesco in questa sua irripetibile fase: la metafora delle ragne di Amore (C 23) succede alla confessione che, nonostante la stagione fredda, non disgombra / un sol penser d’amore, ond’io son carco, / la mente mia (C 11); alla constatazione che d’inverno ne sono liberi gli animali, ma non il poeta (C 34 e 36 son d’amor disciolti, / però che ’l freddo lor spirito ammorta: / e ’l mio più d’amor porta; 70 per questi geli / amore è solo in me, e non altrove), il proprio tormento o, metaforicamente, la crudele spina (C 50); mentre la primavera appare il dolce tempo novello, quando piove / amore in terra da tutti li cieli (C 68). Il traslato più sconcertante (CIII 32 la morte, che ogni senso / co li denti d’Amor già mi manduca) si spegne nella perifrasi allusiva (CIII 37 [Amore incombe su di lui] con quella spada ond’elli ancise Dido); Amore lo logora rendendo più seducenti i riccioli dorati della donna (CIII 64 biondi capelli / ch’Amor per consumarmi increspa e dora); lo sferza con le belle trecce (CIII 72) che egli vorrebbe straziare fino a placarsi nel perdono (CIII 78 e poi le renderei con amor pace). Ma nella grande canzone della liberalità Dante polemizza contro il vil disire delle donne per uomini indegni, vi riconosce un appetito di fera (CVI 143) e nega che un degno amore possa stimarsi fuor d’orto di ragione (CVI 147). In un’altra delle ‘petrose’, Amore viene a stare a l’ombra della ghirlanda di madonna, cioè nei suoi occhi (CI 16), e Dante porta amore pur a la sua ombra (CI 27). Il rapporto ‘amore-ombra’ evoca un accordo tentato in precedenza in LVIII 1 Deh, Vïoletta, che in ombra d’Amore / negli occhi miei sì subito apparisti; ma l’immagine della ‘petrosa’ ritorna più fedelmente (oltre che nel Petrarca) in due delle rime spurie (fra le autentiche in Fraticelli e Moore; cfr. S. Debenedetti, Nuovi studi sulla Giuntina, Città di Castello 1912, 49-69), le sestine Amor mi mena tal fiata all’ombra / di donna (1 e 11, 23, 32, 37) e Gran nobiltà mi par vedere all’ombra 5, 7. Frase fatta è il sintagma ‘richiedere qualcuna d’amore’, in Rime dubbie XX 11; Amore come simbolo della passione sensuale, al vocativo, si ravvisa in Rime CII 1 (cit. in VE II XIII 12); mentre oscilla fra l’impiego sostantivale e quello di nome proprio in CII 8 non par ch’ell’abbia cor di donna, / ma di qual fiera l’ha d’amor più freddo.
In questa serie di esempi parrebbe minuzia eccessiva distinguere volta a volta il sostantivo dal nome proprio, diremmo, per la compresenza in amore della fatale e immedicabile forza di una divinità antica; così anche nella Commedia, dove il termine va innestandosi entro problematiche più aperte o elevate: in If V 66 per la fatale conclusione di una vita eroica, ’l grande Achille, / che con amore al fine combatteo; V 69, dove campeggiano fra le ombre dei lussuriosi le donne e i cavalieri dell’antichità e dell’epos arturiano, ch’amor di nostra vita dipartille; Pg VIII 77, nel pacato ma fermo intervento misogino per bocca di Nino Visconti, amareggiato dal comportamento della moglie (Per lei assai di lieve si comprende / quanto in femmina foco d’amor dura, / se l’occhio o ’l tatto spesso non l’accende); Pd VIII 2, dove si allude alla questione delle influenze del cielo di Venere (Solea creder lo mondo in suo periclo / che la bella Ciprigna il folle amore / raggiasse: ‘folle’ è qui termine tecnico per designare l’amore dei sensi), già impostata, quantunque messa in rapporto coi Troni, in Cv II V 14 E perché li antichi s’accorsero che quello cielo era qua giù cagione d’amore, dissero Amore essere figlio di Venere (con altre due citazioni di Amore, da Virgilio e Ovidio). Né dunque ci si stupisca se nelle Rime dubbie Amore sia presente come divinità antica che provocò innumeri discussioni sulla sua natura (XIX 2, 7, 8, 10, 13 e 14, XXIX 1 e 9); la sua drammatica vitalità si è perpetuata nel Dante maggiore, sia pur scevra di riflessi sensuali: dove le quattro Virtù cardinali lo richiamano alla contemplazione degli occhi di Beatrice, a li smeraldi / ond’Amor già ti trasse le sue armi (Pg XXXI 117); ipotiposi sulla quale s’incentra la perifrasi indicativa dello sguardo di Beatrice, i belli occhi / onde a pigliarmi fece Amor la corda (Pd XXVIII 12).
La prosopopea di Amore nella Commedia era preparata anche da alcuni usi che giungono quasi alla personificazione, sebbene gli editori moderni non la sanciscano graficamente con la maiuscola (ad es. If V 66, 69 e 78); v’inclina anche a che e come concedette amore / che conosceste i dubbiosi disiri? (V 119), ma qui forse in quanto Amore per gli stilnovisti agisce sempre come forza personificata, spirito vivente un suo autonomo dramma: quantunque poi insistano sull’episodio echi della concezione cortese dell’Amore, dove si riverberavano frange del concetto antico di una passione travolgente suscitata da un dio.
2. Una lieve diffrazione semantica s’individua là dove amore passa a indicare il generico sentimento di voluttà suscitato da una creatura di aspetto seducente: nella metamorfosi della ‘femmina balba’ di Pg XIX 15 e lo smarrito volto, / com’amor vuol, così le colorava (s’interpreti «di quel colore che amore richiede per destare il suo fascino» o, meno bene, «trasfigurandolo come suole fare un animo innamorato»). Il significato parrebbe estensibile a un luogo della Vita Nuova, con riferimento alla solenne personificazione della Morte: XXXIII 6 12 e dico «Vieni a me» con tanto amore, / che sono astioso di chiunque more: ma vi si confonde o trova alternativa quello di «trasporto», «affetto» (§ 13).
3. Vale invece la pena di distinguere fra il sostantivo e il nome proprio nell’ambito di un’altra accezione del termine, legata all’amore cortese-cavalleresco e al suo galateo, oscillante tra l’omaggio feudale e il desiderio sensuale; frequente nel Fiore e nel Detto, è invece elusa nelle opere canoniche.
Se il lessico del Fiore è inquadrabile in un ampio settore della poesia trobadorica e oitanica, non foss’altro per il costante riflesso del Roman de la Rose, e quindi è caratterizzato per tutto l’arco dei 232 sonetti da stilemi fissi (fino e leal amore, IV 8; CLXXIII 4, ecc.; gran festa e grand’amore, CLXXIII 1, ecc.; ogne mio amore, XX 11, ecc.; sanza amor non è altro che nuia, XXXVIII 11), coi nuovi apporti idiomatici toscani (A mille diavol v’accomando / chi amor fugge, CCXXII 6; i’ le farò tener bordello / color che l’amor vanno sì schifando, CCXXII 8, ecc.), esso si esaspera e concentra nei due codici di amore carnale di Amico e della Vecchia. Qui il termine appare talvolta in un’orbita nominale: LXII 8, LXVII 14, LXXII 3 e CXLII 6; CXLVI 1 giuoco d’amor; CXLVIII 2 stare a la scuola de l’amore; CLX 4, CLXIX 1, CLXX 8 (binomio amore-‘franchezza’), CLXXII 12, CLXXXVIII 8 e 11, CXCV 5. Anche nel Detto (58, 267, 476) amore vale «passione sensuale»; caso isolato, per «donna amata», l’amor, cu’ tu ha’ caro / più che ’l Soldano il Caro (v. 431).
Per il resto, la personificazione è generale o banale, nel Fiore, oltre che nelle innumeri didascalie, in una sequenza ininterrotta di luoghi segnalati dalla relativa maiuscola, lo Dio d’amor (o ’l Die): I 1, II 4, X 2, XIII 3 e 9, XV 12, XXXV 13, XXXVII 9, XXXVIII 3, XLII 13, XLIX 10, LXXVII 5, LXXVIII 1, LXXXI 1, LXXXIV 1, LXXXV 12-13, CIV 3, CXXVIII 7, CCI 2, CCVI 2, CCXVIII 9, CCXX 14, CCXXXI 5. Come si vede, le ricorrenze s’affollano nella prima e nell’ultima parte, dove Amore compare come agens e loquens, circondato dalla sua baronìa; mentre nella sezione centrale prevalgono diversi attori, la grande figura di Falsembiante e i pedagoghi di Amante e Bellaccoglienza, cioè Amico e la Vecchia. Così in Detto 111 lo dio (ellitticamente), 139, 273.
In altrettanti casi il personaggio dominante della vicenda, accanto al protagonista, è denominato semplicemente Amore: III 2, IV 2, V 2, VI 1, VIII 7, IX 9, XXI 11, XXXIII 14, XXXIV 5, XLV 6 e 13, XLVII 4, XLVIII 8, LIV 3, LVI 9, LX 8, LXXIX 12, LXXXII 1, LXXXV 1, LXXXVII 1, XCIV 2, CXVII 2, CXXVII 12, CLVI 1, CC 12, CCI 7, CCXIV 6, CCXV 2. In Detto la forma semplificata è assai più frequente dell’integra, per ovvie ragioni (agevolezza d’inserzione nei distici di settenari): 1, 12, 23, 48, 54, 61, 75, 81, 86, 128, 131, 142, 148, 150, 153, 217, 229, 252, 256, 361, 366, 384, 407, 453.
4. Una distinzione fra amore e Amore parrebbe invece arbitraria nell’ambito dello Stilnovo; e non solo per l’estraneità di una componente sensuale alla scuola, ma proprio perché la personificazione di amore in Dante e nei suoi amici è in ogni senso immanente alla situazione amorosa; anzi rappresenta quasi la seconda persona obbligata di un dialogo perpetuo fra il poeta e lo sdoppiamento di sé stesso, che poi si risolve in un autentico monologo, nella drammatica visualizzazione di un’ombrosa vicenda spirituale.
Fin dalle prime pagine della Vita Nuova, non si sa ben distinguere – o meglio non serve farlo – se si tratti di personificazione o di sentimento concreto. In realtà i due aspetti risultano quasi sempre compresenti, e pertanto le edizioni moderne indulgono alla maiuscola: Amore signoreggia l’anima di Dante (II 7 e 9, XXVII 3 1, 4 9); lo regge e governa non sanza lo fedele consiglio de la ragione (II 9, IV 2, due volte); gl’induce nel viso le sue insegne (IV 2); lo distrugge (IV 3, XIV 5, due volte) e lo stringe (XIII 5: cfr. Rime XCI 33); uccide tutti i suoi spiriti (XIV 14) e lo assale (XVI 3) in una vera battaglia (XVI 4); lo pone in vita dolce e soave (VII 4 7); si lascia conoscere mirando lo tremare de li occhi suoi (XI 2); si sveglia in lui per merito della gentilissima (XXI 1); volge Dante verso le donne compassionanti (XXIII 19 20) e gli piange nel cuore (XXIII 21 31); gli preannuncia la morte di Beatrice (XXIII 26 63) e partecipa al suo dolore (XXXI 9 14). Oppure è il cuore, ove era tanto amore, che gli fa presagire la morte dell’amata (XXIII 8) e gli parla con la lingua d’Amore (XXIV 3); o è Amore che gli favella nel cuore (XXIV 4), dicendo: E chi volesse sottilmente considerare, quella Beatrice chiamerebbe Amore, per molta simiglianza che ha meco (XXIV 5), con stupenda identificazione della donna con l’Amore stesso (XXIV 9 14 e quell’ha nome Amor, sì mi somiglia).
In questi passi Amore sembra accompagnare l’itinerario della passione di Dante, quasi divinità eponima di quella straordinaria accensione spirituale; ma senza approdare a un significato esemplare, tanto è stretto il nesso con l’appassionata vicenda. In altri invece, che p...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- INTRODUZIONE
- AMORE
- BIBLIOGRAFIA
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Amore di Guido Favati,Emilio Pasquini in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Critica letteraria italiana. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.