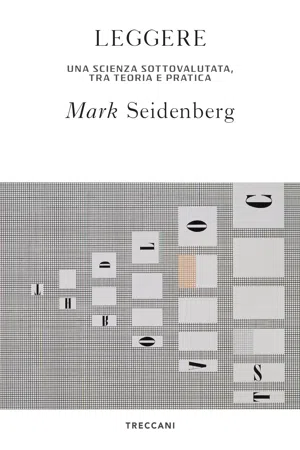
eBook - ePub
Leggere
Una scienza sottovalutata, tra teoria e pratica
- 608 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Perché in diversi paesi avanzati si assiste a un peggioramento degli standard di lettura della popolazione – testimoniato anche da molti confronti internazionali – e all'aumento dei cattivi lettori se non addirittura degli analfabeti di ritorno? Oltre al contesto socioculturale, sostiene Mark Seidenberg, esiste un motivo più profondo che riguarda il metodo di insegnamento della lettura a scuola, rimasto fermo a vecchie e anacronistiche teorie. Negli ultimi anni, infatti, si è sviluppata una vera e propria scienza, ancora poco conosciuta, che in un dialogo serrato tra linguistica, psicologia e neuroscienze ha permesso di svelare i meccanismi di base che regolano la lettura, come la si acquisisce e quali sono le principali cause dei problemi che possono riguardarla. Recuperare il tempo perduto è fondamentale, perché l'esistenza di ampie fasce di popolazione poco istruita è un danno per l'intera società.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Leggere di Mark Seidenberg, Gianbruno Guerriero in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Crescita personale e Tecniche di scrittura e presentazione. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
4
L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE
La lettura esiste perché i nostri antenati hanno sciolto le catene della raffigurazione e risolto il difficile problema di rappresentare la lingua parlata in forma visiva. Il nuovo mezzo ha mantenuto la capacità espressiva della lingua parlata, ma ha superato la sua principale limitazione: la transitorietà. Il fatto che le registrazioni linguistiche durano più a lungo delle espressioni orali è un evidente successo, ma c’è stato di più. Il parlato è qualcosa di grandioso e potente, ma ha pessime caratteristiche progettuali: le frasi possono essere generate solo come sequenze di parole e non a grandi blocchi. Chi parla deve pianificare ciò che va detto dopo nel momento stesso in cui è impegnato a pronunciare ciò che sta dicendo ora, ed è difficile concepire e produrre in modo abbastanza fluente un enunciato che sia grammaticalmente corretto e che esprima più o meno il messaggio desiderato. I difetti di questo metodo li riscontriamo nel linguaggio quotidiano, con i suoi fraintendimenti, gli errori grammaticali e le pause; con le frasi che cambiano direzione a metà del discorso; e con la necessità di aiutarci affidandoci ai gesti e alle espressioni facciali. Questi fenomeni, piuttosto che denunciare limiti personali, riflettono le sfide intrinseche alla creazione di un discorso.
Come ascoltatori siamo prigionieri di ciò che ci viene proposto. Un discorso si dipana: le parole appaiono in sequenza, durano solo il tempo necessario a pronunciarle, per poi scomparire e lasciar spazio alla parte successiva. L’ascolto rischia di assomigliare a ciò che accade a Lucy della sit-com I Love Lucy nella scena in cui deve confezionare dei cioccolatini mentre scorrono su un nastro trasportatore che a intervalli imprevedibili si ferma, torna indietro e cambia velocità. Gli ascoltatori devono “confezionare” le parole pronunciate nell’istante in cui passano, senza la possibilità di infilarsene alcune in bocca o in tasca se rimangono attardati.
Pur essendo profondamente radicate nella nostra specie, la capacità di generare il parlato e quella di comprenderlo sono notevolmente differenti: siamo in grado di comprendere il parlato a velocità superiori a quelle alle quali riusciamo a produrlo in modo fluente.
Starsene seduti a leggere è molto più comodo: guardiamo un testo, pronto per il consumo, servito su un piatto d’argento e approntato con discrezione nella cucina. Noi, e non la persona che l’ha prodotto, controlliamo il ritmo a cui ingerirlo e – la cosa migliore di tutte – il testo non scompare appena letto. Il linguaggio può aver avuto origine nel canale di comunicazione orale, ma la lettura ne è la versione 2.0.
Dato che non ha ereditato i limiti della lingua parlata, il codice scritto ha anche ampliato le nostre capacità linguistiche? Sicuramente. Il mezzo permette agli scrittori di creare testi molto più complessi di quanto possano fare gli oratori. È la differenza tra la narrazione orale nelle culture pre-alfabetizzate e Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay. Fortunatamente, i lettori sono in grado di comprendere queste costruzioni più complesse. La lettura è il primo esempio di ausilio tecnologico che ha esteso le nostre capacità oltre i loro limiti naturali.1
Poi c’è la forza bruta, ossia l’accelerazione della velocità di comprensione permessa dalla lettura, che non dipende dal fatto che la velocità della luce è superiore a quella del suono, ma dalla differenza del soggetto che controlla la velocità di trasmissione. Gli ascoltatori sono obbligati a dedicare a ogni parola tutto il tempo che l’oratore ha impiegato per pronunciarla, mentre i lettori possono almeno in parte ottimizzare il loro impegno, regolando la quantità di tempo che dedicano alle parole, soffermandosi il tempo necessario e andando avanti non appena sono pronti. Nell’ascolto non si può andare avanti (per questo serve una registrazione). Le differenze nel tasso di comprensione possono essere sostanziali. Le statistiche ovviamente variano: sul versante della lettura, dipendono dall’abilità del lettore, dalla complessità del testo, dal fatto che esso venga affrontato per la prima volta o riletto per l’ennesima, e da quanto attenta è la lettura; sul versante del discorso ascoltato, dipendono dal contenuto del messaggio e da come viene pronunciato (ossia da proprietà come velocità, accento, volume). Anche se nessun singolo numero è in grado di fotografare la differenza fra le due modalità, possiamo coglierne il carattere generale con un semplice esempio. Immaginate un buon lettore (per esempio, uno studente al primo anno di università) che si avvicina al primo libro di Harry Potter, nel quale si immerge profondamente, leggendo con cura e interesse.
Costui può leggere con una buona comprensione circa quattro-cinque parole al secondo. Harry Potter e la pietra filosofale contiene circa 77.000 parole. A cinque parole al secondo, il libro potrebbe essere letto, teoricamente, in poco più di quattro ore.
Il numero sembra irrealistico perché ignora i tanti eventi che influenzano i tempi di lettura: aprire il libro (o l’e-book), trovare il punto giusto, rileggere parte del testo per riorientarsi, rileggere una frase, perdere il segno, voltare pagina, sognare a occhi aperti, accarezzare il gatto e spostarlo dal libro, e tanti altri piccoli inconvenienti della vita quotidiana del lettore. Senza contare che ci si può soffermare a soppesare ciò che si è letto – pensando, evocando sensazioni, anticipando eventi – o tornare a rileggere un brano per puro piacere, a dispetto dell’efficienza. Per non parlare di tutte le distrazioni offerte dall’eventuale dispositivo di lettura elettronica. Se non avete divorato Harry Potter e la pietra filosofale in quattro ore e mezza, non preoccupatevi: potreste aver speso nella lettura solo una parte del tempo impiegato. Possiamo paragonare le quattro ore e mezza al consumo standard indicato per un’auto, che è ben più basso di quello che si ha nel mondo reale, ma è abbastanza utile per fare confronti.
L’audiolibro di Harry Potter e la pietra filosofale dura invece circa otto ore e mezza. Questo tempo totale include quello non legato al testo in sé (per esempio, gli intermezzi musicali); d’altra parte, si tratta di una performance registrata per essere facilmente comprensibile con quel mezzo. L’audiolibro dura circa il doppio del tempo di lettura stimato. Anche se i numeri sono solo approssimativi, il rapporto 2:1 tra i tempi di ascolto e di lettura è realistico. La frequenza media di conversazione in inglese è compresa tra le 120 e le 180 parole al minuto e le linee guida per la registrazione degli audiolibri raccomandano 120-150 parole al minuto, che è circa la metà della velocità di lettura tipica (da quattro a cinque parole al secondo, pari a 240-300 parole al minuto). La maggior parte degli apparecchi per audiolibri e podcast permette di aumentare la velocità, ma la riproduzione a trecento parole al minuto è difficile da comprendere se non per lassi di tempo molto brevi. La versione audio del libro di Harry Potter può essere perfetta per un lungo viaggio in macchina con i bambini, ma non è un modo veloce per sapere come si sviluppa la storia.2
Questi numeri valgono anche per altri tipi di discorso e di testo? Facciamo un altro esempio. Aaron Sorkin è uno sceneggiatore e produttore televisivo noto per la sua parlantina veloce. Forse avete visto nella serie The Newsroom il monologo che è valso un Emmy a Jeff Daniels.3 Il personaggio interpretato da Daniels parla molto velocemente, circa 489 parole in 3,5 minuti, ovvero circa 2,3 parole al secondo. Quante frasi, e così ben costruite! L’oratore, naturalmente, è in grado di farlo perché sta lavorando con un copione, in cui interpreta da attore un discorso estemporaneo. Eppure la sua velocità di pronuncia è ancora molto più lenta di una velocità di lettura di quattro-cinque parole al secondo.
Tutto segna un vantaggio per la lettura. Con un testo che non scompare e il controllo del ritmo, possiamo leggere a velocità che nel parlato superano i limiti di comprensione. Se prendiamo in considerazione solo la velocità, il testo vince. La domanda allora è: fino a che punto possiamo spingere questo vantaggio? Tutti noi abbiamo una nostra velocità di lettura standard; possiamo migliorarla? Ci si allena per migliorare i tempi di corsa e i giri al minuto; perché non i tempi di lettura? I bambini potrebbero prepararsi per gare di velocità di lettura invece che di spelling, sfidandosi nel leggere il più veloce possibile con il minor numero di errori di pronuncia o di comprensione.
Fermiamoci qui. La lettura viene compiuta da un sistema visivo che si è evoluto per risolvere altri tipi di problemi: riconoscere volti e oggetti, percepire il mondo come uno spazio stabile e tridimensionale, distinguere i colori, le tessiture e i movimenti all’esterno; non per decifrare modelli bidimensionali astratti. I vantaggi della lettura rispetto al parlato arrivano solo fino a dove l’occhio può vedere.
Te lo leggo negli occhi
La lettura è in primo luogo un’esperienza linguistica, che sfrutta conoscenze condivise con il parlato. La natura e la disposizione dei simboli visivi sulla pagina, insieme al fatto che essi sono percepiti dall’occhio invece che dall’orecchio, danno però origine ad alcune caratteristiche specifiche della lettura. L’uso del linguaggio in questa modalità offre dei vantaggi, ma è vincolato alle caratteristiche del sistema visivo, che impongono i propri limiti.
Sappiamo molto sulla visione e su come avviene nell’uomo e in altre specie, dallo sviluppo del substrato neurale alla percezione di un mondo tridimensionale popolato di oggetti e individui identificabili, collocati in scene visive complesse e in rapido cambiamento. Le informazioni più importanti sul ruolo della visione nella lettura derivano proprio dall’osservazione degli occhi. Dalla fine degli anni Sessanta sono disponibili tecnologie che permettono di tracciare con precisione dove si focalizzano gli occhi e come si muovono. I primi tracciatori erano dispositivi grandi e costosi, l’equivalente dei grandi e costosi computer mainframe dell’epoca. Oggi, come per i computer, la tecnologia è molto progredita e permette la produzione di dispositivi più piccoli ed economici che possono essere indossati come un cappello, raccogliendo dati sul punto fissato mentre si guida o si sta osservando la Gioconda. Se si mette uno di questi apparecchi sulla testa di un bambino, si può scoprire che cosa preferisce guardare.4 Sapere dove si fissa lo sguardo delle persone mentre consultano le pagine web o guardano la televisione è molto importante per i produttori di contenuti e i dirigenti delle reti televisive.
Negli anni Settanta, alcuni ricercatori decisero di usare questo nuovo strumento per studiare la lettura. Era una scommessa, perché non era chiaro se si potesse imparare qualcosa semplicemente guardando gli occhi della gente: la maggior parte del processo di lettura avviene nella mente, non nelle pupille. I movimenti degli occhi potevano essere utili per studiare la prima parte del processo, quella visiva, attraverso la rilevazione degli spostamenti dello sguardo sulla pagina, ma la possibilità che rivelassero qualcosa sul pensiero di livello superiore – per esempio, l’uso della conoscenza della lingua e del mondo per comprendere il messaggio – sembrava alquanto remota.
Questo era dato per scontato fino all’esecuzione di quegli studi. I movimenti degli occhi si sono dimostrati molto più rivelatori del previsto: i nudi fatti relativi al modo in cui gli occhi captano il codice scritto ci dicono molto sulla natura della lettura. E, cosa ancora più sorprendente, molti eventi mentali che si verificano mentre leggiamo possono essere dedotti dai loro effetti sui movimenti oculari. Certo, ci vuole un esperimento ben progettato – non ci limitiamo a scrutare attentamente gli occhi di una persona per desumere ciò che sta pensando o guardando mentre legge – ma i movimenti oculari sono un potente strumento per studiare la lettura e il pensiero.5
I movimenti oculari implicano due decisioni: dove guardare e quando muoversi. Come si può notare guardando un video sull’argomento, al soggetto di un esperimento di tracciamento dello sguardo è richiesto di leggere un testo visualizzato sullo schermo di un computer.6 Un dispositivo di tracciamento invia una luce infrarossa impercettibile verso l’occhio della persona, e l’angolo di riflessione del fascio di luce sull’occhio viene usato per triangolare il punto che la persona sta osservando. Muovendosi da sinistra a destra, l’occhio fa brevi pause, chiamate fissazioni. I rapidi salti tra le fissazioni sono dette saccadi. Il numero di fissazioni, la quantità di tempo trascorso su ciascuna di esse e l’entità delle saccadi sono i principali fattori che determinano i tempi di lettura. (Le saccadi in sé aggiungono solo venti o trenta millisecondi circa ciascuna.)
Le registrazioni del movimento degli occhi mostrano anche che la lettura non procede solo da sinistra a destra; il soggetto fa occasionalmente saccadi all’indietro per rileggere parte del testo. Questi “movimenti oculari regressivi” sono comuni anche nei lettori più esperti. Vengono registrati anche i rapidi movimenti che si verificano quando l’occhio raggiunge la fine di una riga e si sposta all’inizio della successiva.
Per quanto sembri inefficiente, questo schema irregolare di fissazione-saccade-fissazione caratterizza il modo in cui tutti leggiamo. Il lettore fissa un punto per leggere ciò che vi è scritto e quasi subito inizia a pianificare dove guardare dopo, poi esegue un salto, arrivando sul punto di fissazione successivo, e così avanti e indietro a ripetizione, molte volte per ogni testo. Ma non potremmo semplicemente scorrere il testo in modo continuo, come in una bella panoramica? Non è una cosa irrealistica. Il sistema visivo è capace di un altro tipo di movimento dell’occhio chiamato “inseguimento lento”.7 Ecco come potete sperimentarlo:
Chiudete la mano destra a pugno e sollevate l’indice come a dire “sono il numero uno”, poi posizionate la mano a una trentina di centimetri davanti a voi, sulla si...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Indice
- LETTURA, SCRITTURA E PARLATO
- COME LEGGIAMO
- LE SFIDE DELL’ISTRUZIONE
- Ringraziamenti
- Note
- Bibliografia