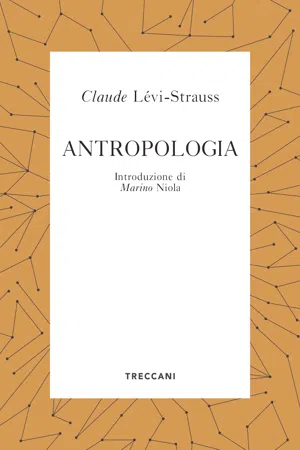
- 112 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Antropologia
Informazioni su questo libro
Il progetto antropologico di Claude Lévi-Strauss ha esercitato un'influenza straordinaria sulla cultura del Novecento e si è affermato come una pietra miliare nel percorso storico di conoscenza dell'uomo. Alla sua base un'ampiezza di orizzonti incredibile, un'erudizione profondissima, una rara capacità di tessere collegamenti tra le più diverse discipline e implicazioni teoriche e filosofiche; non ultima, una scrittura felicissima, ben lontana dal descrittivismo etnografico e non scontata per un autore di saggistica accademica. Le grandi questioni del presente che rimettono in discussione la frontiera tra natura e cultura si trovano tutte nell'opera di Lévi-Strauss: oggi più che mai risulta di grande attualità l'insegnamento contenuto in queste pagine che Marino Niola, nella sua ampia e illuminante Introduzione, ha definito «una concezione dell'uomo che pone l'altro prima dell'io, e una concezione dell'umanità che, prima degli uomini, pone la vita [...] cercando di connettere, come due facce della stessa moneta, la varietà delle forme di vita ai vincoli della mente».
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
1
PROBLEMI DI DEFINIZIONE: ANTROPOLOGIA, ETNOLOGIA, ETNOGRAFIA
L’antropologia non si distingue dalle altre scienze umane o sociali per via di un oggetto di studio che le sia proprio. Essa sembra interessarsi soprattutto ai cosiddetti popoli “primitivi” o “senza scrittura”, e tuttavia si è sviluppata mentre questi popoli tendevano a scomparire o, almeno, a perdere i loro caratteri distintivi; d’altra parte, da qualche decennio vi sono antropologie che si rivolgono allo studio delle cosiddette società civilizzate. È chiaro dunque che l’antropologia parte più da una maniera originale di formulare dei problemi comuni all’insieme delle scienze dell’uomo che dall’esistenza di un soggetto distinto di studio: essa ha preso coscienza della sua particolare missione in occasione dello studio di fenomeni sociali non necessariamente più semplici di quelli dei quali la società dell’osservatore è teatro, ma che, per via delle grandi differenze che essi mostrano nei confronti di questi ultimi, rendono manifeste certe proprietà a un tempo generali e fondamentali della vita sociale. In questo senso si potrebbe dire che l’antropologia occupa, nell’insieme delle scienze dell’uomo, una posizione che ha qualche analogia con quella dell’astronomia nell’insieme delle scienze della natura: essa studia l’uomo a partire dalle sue manifestazioni più lontane, dando alla nozione di distanza un significato a un tempo spaziale, temporale e morale. Questa distanza che lo separa dal suo oggetto impoverisce la percezione dell’antropologo ma, costringendolo a fare di necessità virtù, lo condanna a vedere soltanto le proprietà essenziali dei fenomeni considerati.
In primo luogo, il distacco permette di accedere più facilmente all’obiettività, di astrarre non soltanto da credenze, preferenze e pregiudizi propri all’osservatore, ma anche – e forse soprattutto – dai suoi metodi di pensiero. L’antropologo si sforza di formulare i problemi e le conclusioni in un modo che in linea di principio sia accettabile non soltanto all’osservatore onesto e obiettivo che egli vuol essere, ma a tutti gli osservatori possibili. Egli costruisce nuove categorie mentali, contribuisce a introdurre e ad accreditare nozioni di spazio e di tempo, di opposizione e di contraddizione atte a tradurre un’esperienza sociale particolare nel codice di una qualunque altra esperienza sociale.
In secondo luogo, questa ricerca di una obiettività totale si situa a un livello in cui i fenomeni conservano un significato umano e restano comprensibili, intellettualmente e sentimentalmente, per una coscienza individuale. Ciò che è stato dapprima osservato dal di fuori deve essere restituito in una forma che consenta all’osservatore stesso e al suo lettore di riviverlo dal di dentro. Invece di contrapporre la spiegazione causale alla comprensione, l’antropologia vede in quest’ultima una forma particolare di prova: prova che un insieme di fenomeni, per essa oggettivamente molto lontani, ma soggettivamente molto concreti per gli uomini che ne sono gli attori, sono stati colti nella loro realtà intima. I fatti sociali non si riducono a degli sparsi frammenti; essi sono vissuti da uomini, e questa coscienza soggettiva è una forma della loro realtà, alla stessa stregua dei loro caratteri oggettivi.
Infine, l’antropologia aspira alla totalità. La vita sociale le appare come un sistema i cui aspetti sono tutti organicamente connessi. Il suo metodo d’elezione è la monografia di cui, senza dubbio, l’esempio più impressionante è costituito dai sei volumi, scaglionati lungo quarant’anni, che R. Firth ha consacrato a un’isola del Pacifico: Tikopia; studio a un tempo storico e funzionale di una società particolare, abbastanza piccola perché la sua organizzazione si basi principalmente su rapporti personali: rapporti concreti tra gli individui, dei quali la parentela costituisce generalmente il modello. Di qui l’importanza che gli studi sulla parentela hanno avuto e continuano ad avere nel pensiero antropologico. È quindi nella misura in cui certi settori della vita contemporanea si fondano ancora su relazioni personali che l’antropologia se ne può interessare.
Questi studi monografici rappresentano, per l’antropologia, l’equivalente di quello che gli esperimenti di laboratorio sono per le scienze fisiche e naturali. Con questa differenza, tuttavia: che in antropologia la sperimentazione precede l’osservazione e l’ipotesi; le piccole società che gli antropologi studiano sono esperienze bell’e fatte e su cui essi non hanno né il tempo necessario né i mezzi per agire. Le esperienze dell’antropologo sono già pronte, ma esse non possono essere anche guidate. Per trattarle in laboratorio, confrontarle fra di loro, sforzarsi di enuclearne forme comuni e proprietà essenziali, egli deve sostituire loro dei modelli: sistemi di simboli che salvaguardano le proprietà caratteristiche dell’esperienza, ma che si possono far variare sopprimendo o aggiungendo delle variabili e facendole evolvere. Questo impiego alternato di due metodi, l’uno empirico, l’altro deduttivo, fornisce all’antropologia il suo carattere distintivo nell’insieme delle scienze dell’uomo. Più di ogni altra scienza, essa cerca di fare della più intima soggettività un mezzo di dimostrazione oggettiva. Lo spirito dell’antropologo, durante la ricerca sul campo, si abbandona all’esperienza e si lascia modellare da essa; ma in laboratorio questo stesso spirito diviene il teatro di altre operazioni mentali che senza cancellare le precedenti trasformano tuttavia l’esperienza in modello, modello che avrà valore solo in quanto permetterà, in una terza fase, di ritornare all’esperienza conferendo a essa nuove dimensioni.
Questa complessità di fini e di metodi spiega come la terminologia sia rimasta per molto tempo incerta. A seconda che l’accento venisse posto sull’uno o sull’altro aspetto della ricerca si è preferito parlare, dalla fine del XVIII al XX secolo, ora di etnografia, ora di etnologia, ora di antropologia, e l’uno o l’altro di questi tre appellativi prevale ancora qua o là nel linguaggio scientifico. Tuttavia si delinea un accordo generale per classificare sotto queste voci tre stadi successivi di una medesima ricerca.
Con una certa approssimazione, si può dire che l’etnografia consiste quindi nell’osservazione, nella descrizione e nell’analisi di gruppi umani considerati nella loro particolarità, avendo di mira la ricostruzione quanto possibile fedele della vita di ciascuno di essi: l’etnografia è tipicamente monografica. Definita un tempo come lo studio delle razze, dei loro caratteri distintivi e della loro distribuzione geografica, l’etnologia si occupa oggi piuttosto dello studio comparativo dei documenti raccolti sul campo dagli etnografi. Essa corrisponde quindi a una seconda fase della ricerca. Infine, secondo un uso che tende a diffondersi, l’antropologia integra le due fasi precedenti e ne aggiunge loro una terza: quella in cui i risultati dell’etnografia, sistematizzati dagli etnologi, sono posti al servizio di una conoscenza generale dell’uomo, che permette il dialogo con altre scienze dell’uomo anch’esse aspiranti a una conoscenza generale, tra le quali al primo posto figurano la storia, la linguistica, la psicologia e la filosofia. Tra antropologia ed etnologia esiste dunque lo stesso rapporto che tra quest’ultima e l’etnografia. Esse non costituiscono tre discipline diverse o tre concezioni diverse degli stessi studi, ma piuttosto tre tappe o tre momenti di una stessa ricerca, tanto meno separabili oggi che tutti gli antropologi sono ormai d’accordo nel riconoscere un primato assoluto alle indagini sul campo – fieldwork, come si dice in inglese –, la cui preliminare esperienza è indispensabile a tutti: a colui che per tutta la vita resterà etnografo come all’etnologo indirizzato verso il comparativismo e all’antropologo che si vuole teorico puro.
Tuttavia, questo accordo sulla terminologia e sulle forme rimane relativo e, fin dove esiste, è il risultato di una lenta evoluzione che impone l’esame delle origini della disciplina antropologica e le tappe storiche del suo sviluppo.
2
EXCURSUS STORICO
In ogni tempo gli uomini si sono interessati all’origine delle loro istituzioni e dei loro costumi, e sono stati curiosi di conoscere quelli dei popoli stranieri. Queste preoccupazioni compaiono già negli storici che accompagnarono Alessandro Magno in Asia, in Senofonte, Erodoto, Pausania e, in forma più speculativa, in Aristotele e Lucrezio. Nel mondo arabo, nel XIV secolo, Ibn Battūta, viaggiatore, e Ibn Khaldūń, storico e filosofo, offrono l’esempio di uno spirito antropologico; e lo stesso si può dire, in Cina, per i monaci buddhisti che, sin dal VII secolo, si recarono in India.
Nel Medioevo, l’Europa scopre l’Oriente attraverso le relazioni di Giovanni dal Piano dei Carpini e Guglielmo di Rubruquis, inviati in missione presso i Mongoli durante il XIII secolo, l’uno dal papa, l’altro da Luigi IX, e soprattutto grazie al lungo soggiorno in Cina di Marco Polo (XIII secolo). Al principio del Rinascimento si distinguono fonti molto diverse, dalle quali avrà origine la riflessione antropologica. Oltre a quelle già citate, bisogna menzionare la letteratura suscitata dalle invasioni turche in Europa orientale e nel Mediterraneo; le speculazioni ispirate dalle tesi aristoteliche sulla barbarie; le fantasie del folklore medievale, che riprendevano quelle dell’antichità, su popoli selvaggi, mostruosi per anatomia e costumi; soprattutto, infine, le conoscenze che incominciavano a pervenire dall’Africa, dall’Oceania e dall’America in occasione delle grandi scoperte, che i racconti dei primi viaggiatori divulgavano: così, per l’America, gli scritti dei francesi J. de Léry ed A. Thevet, e del tedesco H. Staden (XVI secolo).
A partire dall’inizio del XVI secolo, i racconti di viaggio e le compilazioni che se ne fanno conoscono una voga prodigiosa. Tra queste ultime, le più antiche sono senza dubbio l’Omnium gentium mores del tedesco J. Böhme (1520) e le Cosmografie dello svizzero S. Münster (1544) e del francese A. Thevet (1575). Nel XVI secolo in Inghilterra, ha inizio la pubblicazione delle collane di viaggi di R. Hakluyt e in Germania quella dei Grandi viaggi di J.-Th. de Bry che continuerà fino al XVII secolo; ancora in Inghilterra, nel 1613, Purchas his pugrimage di S. Purchas.
Questa enorme letteratura sui viaggi servirà da base alla riflessione antropologica che ha inizio veramente nel XVIII secolo e nella quale, sin dal principio, si delineano tre orientamenti. Quello dei naturalisti come Linneo, Buffon, P. Camper, G. White e J.-Fr. Blumenbach, preoccupati soprattutto del problema dell’unità o della diversità specifiche del genere umano, del quale si sforzano di fissare il posto nel regno animale. Quello dei moralisti e dei filosofi: in Francia, Montesquieu, Fontenelle, Rousseau, Diderot, preceduti da Montaigne, e ancora d’Alembert, Condorcet, Turgot, che tutti insieme preparano la strada a Saint-Simon e a Comte, che, a loro volta dovevano prepararla a Durkheim e alla sua scuola; in Inghilterra, i filosofi scozzesi da Hume ad A. Smith; in Germania, Kant. Si assiste infine, nel XVIII secolo, alla continuazione del lavoro di compilazione, ma accompagnato da uno sforzo di classificazione più metodico e da una riflessione più approfondita; così nel danese J. Kraft (1760), nel francese J.-N. Démeunier (1776), nello svizzero A. A. C. Chavannes (1788), che impiega già in senso moderno i termini “antropologia” ed “etnologia”. Il termine “etnografia” appare invece in Germania verso il 1790; e Ampère tratta dell’etnologia nel suo corso del 1831 al Collège de France.
Un posto a parte meritano due opere di ineguale ampiezza, ma che segnano entrambe una svolta nella storia del pensiero antropologico. Moeurs des sauvages amériquains del padre J.-F. Lafitau – pubblicato nel 1724 – invita a percorrere la strada di una comparazione tra tecniche e costumi degli Indiani e quelli dei tempi più remoti delle nostre proprie civiltà. Nel 1730 viene pubblicata la Scienza nuova di Vico, che rompe con la tradizione cartesiana di uno studio introspettivo dell’uomo per intraprendere tale studio a partire dalle manifestazioni culturali e particolarmente dai fatti linguistici. Ma, malgrado questi segni premonitori, l’autentico “decollo” del pensiero antropologico moderno si situa molto più tardi, nello spazio di una decina d’anni durante i quali apparvero Ancient Law di H. J. Maine e Das Mutterrecht di J. J. Bachofen nel 1861, La cité antique di N.-D. Fustel de Coulanges nel 1864, Primitive Marriage di J.-F. McLennan e Researches into the Early History of Mankind di E. B. Tylor nel 1865; infine, nello stesso anno, il 187...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- INTRODUZIONE di Marino Niola
- ANTROPOLOGIA
- 1. PROBLEMI DI DEFINIZIONE: ANTROPOLOGIA, ETNOLOGIA, ETNOGRAFIA
- 2. EXCURSUS STORICO
- 3. LA COLLOCAZIONE DELL’ANTROPOLOGIA FISICA
- 4. ANTROPOLOGIA CULTURALE E ANTROPOLOGIA SOCIALE
- 5. EVOLUZIONE E “DIFFUSIONISMO”
- 6. METODO COMPARATIVO E METODO STORICO
- 7. FUNZIONALISMO, STRUTTURALISMO
- 8. ALTRI SETTORI DI RICERCA
- 9. L’AVVENIRE DELL’ANTROPOLOGIA
- BIBLIOGRAFIA
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Antropologia di Lévi-Strauss Claude in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Antropologia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.