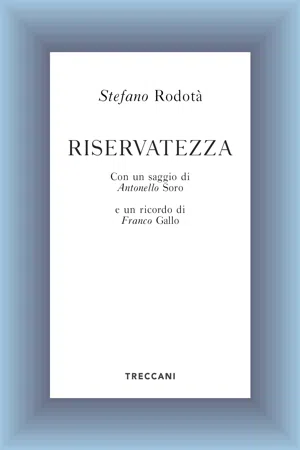
- 108 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Riservatezza
Informazioni su questo libro
Google decide come dobbiamo avere accesso alle notizie, scegliendo per noi quelle più adatte. Facebook ci consiglia gli amici, le foto e le cose che ci piacciono. Amazon intuisce quale sarà il prossimo libro che leggeremo – e nel frattempo coglie l'occasione per vendercelo.Benvenuti nell'era dell'algoritmo, della condivisione dei dati, dell'uso dei big data. Benissimo, ma che fine ha fatto la nostra privacy? Affrontare un ragionamento sulla riservatezza significa costruire una struttura a protezione della libertà dell'individuo e della società. Stefano Rodotà, uno dei più importanti giuristi del Novecento, ha delineato l'orientamento teorico alla base dei protocolli di protezione dei dati dei cittadini, in pagine tanto utili per il singolo individuo quanto significative per lo sviluppo culturale dell'intera società. Il saggio di Antonello Soro illustra il percorso di ricerca e la riflessione intellettuale di Stefano Rodotà, mentre Franco Gallo, presidente di Treccani, ci offre un affettuoso e sentito ricordo dell'autore.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
eBook ISBN
9788812008629Argomento
Politics & International RelationsCategoria
Science & Technology Public PolicyRISERVATEZZA E PRIVACY
Il termine “riservatezza” è entrato ormai stabilmente nel linguaggio giuridico: adoperato prima dagli studiosi1 e poi dalla giurisprudenza (Cassazione civile, nr. 1557 del 5 aprile 1978; Corte costituzionale, nr. 38 del 12 aprile 1973), è stato infine accolto nella legislazione (art. 6, l. nr. 300 del 20 maggio 1970, con riferimento ai soli lavoratori; e, in via generale, art. 1, l. nr. 675 del 31 dicembre 1996). Prima di quest’ultima legge, già l’art. 615-bis del Codice penale, introdotto dalla l. nr. 98 del 8 aprile 1974, aveva vietato, sempre in generale, le interferenze illecite nella “vita privata”, attribuendo a questa espressione (corrente in altri paesi, come la Francia) un significato sostanzialmente identico a “riservatezza”; e l’art. 10 della legge di riforma della polizia (nr. 121 del 1° aprile 1981) aveva introdotto una sia pur circoscritta tutela generale dei dati personali.
Il primo, sostanziale riconoscimento legislativo della riservatezza, comunque, si trova nella l. nr. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori), che disciplina rigorosamente una serie di comportamenti dell’imprenditore che incidono sulla sfera privata dei lavoratori, dall’uso di impianti di controllo a distanza agli accertamenti sanitari, alle visite di controllo. La norma più significativa, tuttavia, è contenuta nell’art. 8, che vieta le indagini sulle opinioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori, individuando così una categoria di dati personali che, insieme ad altri, saranno poi qualificati “sensibili” (art. 22, l. nr. 675 del 31 dicembre 1996) e quindi tutelati in maniera particolarmente rigorosa. Si coglie qui un paradosso singolare e rivelatore. La privacy (come ormai si usa dire nel linguaggio corrente), tradizionalmente indicata come diritto tipico della borghesia, entra nell’ordinamento giuridico italiano attraverso una speciale tutela accordata ai diritti della classe operaia.
La privacy si libera così della sua vicenda d’origine, e si sottrae quindi all’inevitabile declino al quale, secondo alcuni, era condannata dall’avvento di una società pluriclasse. Tutto ciò avviene per effetto della sempre più pervasiva diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che rendono maggiormente agevole la raccolta e la gestione di banche dati che trattano le più diverse informazioni personali. Definendosi la nostra appunto come “società dell’informazione”, il tema della privacy era destinato ad assumere un’importanza centrale. Anche se si respinge, com’è giusto, una riduzione dell’individuo alle sue informazioni, è ormai del tutto evidente che lo statuto giuridico dei dati personali contribuisce a definire il carattere delle relazioni interpersonali e sociali e a presentarsi come un elemento della stessa cittadinanza, tanto che da anni ormai si sottolinea la necessità di un Information Bill of Rights, di una dichiarazione dei diritti dell’informazione, con una suggestione che alcune costituzioni (come quella spagnola) hanno già raccolto, collocando la privacy tra i diritti fondamentali dell’uomo.
Nasce da qui un nuovo e complessivo statuto delle informazioni personali, la cui tutela è in primo luogo affidata a poteri direttamente esercitabili dagli interessati, che diventano così pienamente titolari del diritto sui dati che li riguardano: questa è l’indicazione della direttiva 95/46 dell’Unione europea, vincolante per tutti gli Stati dell’Unione. Si attua così una sostanziale redistribuzione di poteri giuridici e sociali, facendo cadere ogni privilegio dei detentori delle informazioni, obbligati a rendere conto agli interessati del modo in cui gestiscono i loro dati, ai quali gli interessati devono poter accedere liberamente. La gestione dei dati non è più incontrollabile, si possono far eliminare le informazioni raccolte illegalmente od obsolete, correggere quelle inesatte, integrare quelle incomplete. A una più forte tutela della riservatezza corrisponde così una più accentuata trasparenza sociale.
LA NASCITA DELLA PRIVACY
Per comprendere questa vicenda, più che insistere sui dati naturalistici relativi alla necessità biologica di una sfera riservata,2 è opportuno ricordare il contesto socioeconomico in cui sono maturate le condizioni che hanno poi consentito l’affermarsi della privacy come esigenza bisognosa di autonoma tutela. Basta qui citare un’osservazione di Lewis Mumford: «il primo mutamento radicale [...] destinato ad infrangere la forma della casa di abitazione medievale fu lo sviluppo del senso di intimità. Questo, infatti, significava la possibilità di appartarsi a volontà dalla vita e dalle occupazioni in comune coi propri associati. Intimità durante il sonno; intimità durante i pasti; intimità nel rituale religioso e sociale; finalmente, intimità nel pensiero». Tale fatto segna «la fine delle reciproche relazioni sociali fra i ranghi superiori e quelli inferiori del regime feudale: relazioni che avevano mitigato la sua oppressione. Il desiderio d’intimità segnò l’inizio di quel nuovo schieramento di classi che era destinato a finire nella lotta di classe senza quartiere e nelle rivendicazioni individualistiche di un periodo posteriore».3
In questo senso, la nascita della privacy può essere storicamente riportata al disgregarsi della società feudale, nella quale gli individui erano tutti collegati da una complessa serie di relazioni, che si riflettevano nell’organizzazione stessa della loro vita quotidiana: l’isolamento era privilegio di pochissimi eletti o di coloro i quali, per necessità o scelta, vivevano lontani dalle comunità: mistici o monaci, pastori o banditi. Questa possibilità, poi, si estende a quanti dispongono dei mezzi materiali che consentono loro di riprodurre, anche nell’ambiente urbano, condizioni tali da appagare il nuovo bisogno d’intimità: ed è ben noto che questo è un processo in cui intervengono molteplici fattori, dalle nuove tecniche di costruzione delle abitazioni alla separazione tra luogo in cui si vive e luogo di lavoro (la casa “privata” contrapposta all’ufficio). La privacy si configura così come una possibilità della classe borghese, che riesce a realizzarsi soprattutto grazie alle trasformazioni socioeconomiche connesse alla rivoluzione industriale.
Non è necessario insistere ulteriormente sul molteplice complesso di condizioni che fecero evolvere la privacy come diritto tipico della classe borghese in particolari contesti ambientali e sociali (l’“età dell’oro” della privacy, per esempio, è stata identificata con la seconda metà dell’Ottocento negli Stati Uniti).4 Qui è opportuno ricordare che quello fu l’effetto non di uno sviluppo lineare, ma di una rottura intervenuta all’interno dell’organizzazione sociale. La realizzazione delle condizioni materiali per la soddisfazione del bisogno di intimità appare come un momento di una più complessa operazione attraverso la quale la borghesia riconosce la propria identità all’interno del corpo sociale. La possibilità di godere pienamente della propria intimità è un connotato differenziale della borghesia rispetto ad altre classi: e la forte componente individualistica fa sì che quella operazione si traduca, poi, in uno strumento di isolamento del singolo borghese all’interno della sua stessa classe. Il borghese, in altri termini, si appropria di un suo “spazio”, con una tecnica che ricorda quella compiuta per l’identificazione di un diritto alla proprietà “solitaria”.5
A livello sociale e istituzionale, quindi, la nascita della privacy si presenta non come la realizzazione di un’esigenza “naturale” di ogni individuo, ma come l’acquisizione di un privilegio da parte di un gruppo. Non è un caso che gli strumenti giuridici di tutela siano prevalentemente modellati su quelli caratteristici del diritto borghese per eccellenza, la proprietà; e che esigenze analoghe a quelle fatte valere dalla borghesia sotto l’etichetta della privacy o non siano affatto riconosciute alla classe operaia o vengano più tardi realizzate attraverso strumenti giuridici completamente diversi (si pensi, per esempio, alla tutela della personalità nella fabbrica). Sono le condizioni materiali di vita a escludere la privacy dall’orizzonte della classe operaia. Basta ricordare i dati raccolti da Friedrich Engels sulla situazione abitativa degli operai inglesi a Londra, Edimburgo, Bradford, Leeds, Manchester, per rendersi conto, per contrasto, delle connotazioni elitarie del concetto di privacy. È stato giustamente detto che «poverty and privacy are simply contradictoires»:6 anzi, il “diritto di essere lasciato solo” può assumere un significato pesantemente negativo, quando ciò implica disinteresse per le condizioni dei meno abbienti, abbandono dei più deboli alla violenza sociale.
Valutata in questo suo contesto storico d’origine, la privacy, quindi, non può essere considerata come una nozione unificante, come un concetto che esprime esigenze uniformemente diffuse nella collettività. Naturalmente, sarebbe anche sbagliato considerare la privacy monoliticamente rispetto alla stessa classe borghese: essa, per esempio, è destinata a scomparire dove si degradano le condizioni di vita di tale classe, come accade alla piccola borghesia europea confinata negli “alveari” alla periferia delle grandi città. Né, peraltro, può essere trascurato il fatto che quel modello culturale tende a essere ricevuto dagli strati più alti della classe operaia. Ma, per comprendere la reale dinamica a cui il concetto di privacy è legato, bisogna soprattutto considerare le diverse funzioni a esso attribuite a seconda della cultura complessiva di ciascun gruppo interno alla borghesia. Sono state opportunamente messe in luce le diverse ispirazioni che muovevano gli stessi “padri fondatori” della privacy sul terreno giuridico, Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis,7 autori dello scritto che, pur non rappresentando storicamente la prima affermazione del right to privacy, certamente ha costituito il punto d’avvio della sua espansione, anche perché prendeva spunto dai nuovi problemi posti dall’informazione di massa. Il primo, un conservatore di stampo tradizionale, si mostrava interessato soltanto ai privilegi dell’alta borghesia, considerando con risentimento l’azione di una stampa a caccia di scandali politici e mondani; l’altro, liberal-progressista, pur preoccupandosi della privacy delle persone più in vista, metteva l’accento sul danno che alle minoranze intellettuali e artistiche poteva derivare da indiscrezioni giornalistiche indiscriminate, che avrebbero potuto accrescerne l’impopolarità. Questa duplicità di punti di vista può essere ritrovata, al di là della specifica cultura americana e con caratteristiche progressivamente più marcate, nella gran parte dei dibattiti sulla privacy, fino ai nostri giorni.
È ben noto, infatti, che l’enorme aumento della quantità di informazioni personali raccolte da istituzioni pubbliche e private risponde soprattutto a due obiettivi: l’acquisizione degli elementi necessari alla preparazione e alla gestione di programmi di intervento sociale, da parte dei poteri pubblici, e allo sviluppo delle strategie imprenditoriali private; e il controllo della conformità dei cittadini all’indirizzo politico dominante o ai comportamenti prevalenti. Invocare la difesa della privacy, allora, assume significati diversi, a seconda di quale sia l’obiettivo perseguito attraverso la raccolta delle informazioni. Quando si rifiutano le informazioni necessarie ai programmi d’intervento sociale, la privacy si presenta come lo strumento per il consolidamento dei privilegi di un gruppo; nell’altro caso, serve a reagire contro l’autoritarismo e contro una politica di discriminazioni basate sulle opinioni politiche (o sindacali o religiose, oppure sulla razza, e così via). La privacy diventa dunque un modo per promuovere la parità di trattamento tra i cittadini, per realizzare l’eguaglianz...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- UN DIRITTO DI LIBERTÀ
- RICORDO DI STEFANO RODOTÀ
- RISERVATEZZA
- BIBLIOGRAFIA
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Riservatezza di Stefano Rodotà in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Politics & International Relations e Science & Technology Public Policy. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.