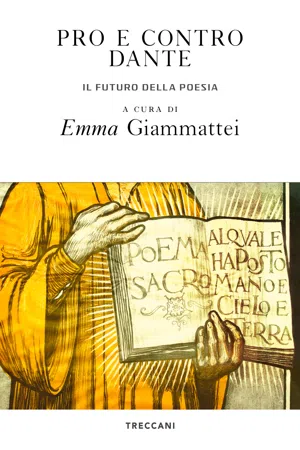
- 284 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Nel 2021 ricorre il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Esattamente cento anni fa, nel 1921, gli studi danteschi furono rivoluzionati dal libro di Benedetto Croce La poesia di Dante. Il racconto del viaggio del sommo poeta lungo il Novecento parte da questa soglia ancora oggi significativa. Nel ricostruire le vicende della critica che intorno a Dante si intrecciarono con motivi politici e ideologici, tra posizioni e fronti molteplici, nel secolo scorso, questo libro, composto da tre saggi tra loro connessi, intende ampliare il campo delle celebrazioni e il dibattito fervido fra filologia e critica estetica, analizzando un momento-chiave della cultura italiana. E soprattutto, vuole suggerire un interrogativo profondo: come mai Dante sopravvive ai suoi critici, alle esercitazioni scolastiche, alle polemiche accademiche? La vitalità di un immaginario secolare sembra anzi rafforzarsi e caricarsi di nuovi significati, nuove allegorie e nuove domande.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Pro e contro Dante di Emma Giammattei in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Critica letteraria nella poesia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1
CONVERGENZE DELLA SOGLIA.
BENEDETTO CROCE, LA POESIA
DI DANTE, IL 1921
di Emma Giammattei
I suoi stessi dannati sono ancora in possesso della beatitudine dell’eternità (Seligkeit der Ewigkeit). «Io etterno duro» si trova scritto sulla porta dell’Inferno. […]
L’eternizzazione per mezzo della Mnemosyne del poeta qui vale obiettivamente come giudizio stesso di Dio, in nome del quale lo spirito più audace della propria epoca condanna o salva l’intero presente e l’intero passato.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
1.1. Tra biografia e storia
Anno drammatico e feroce, il 1921, passaggio d’epoca che si presenta in eventi-chiave, all’incrocio di politica e cultura, fra il biennio degli scioperi e dei tumulti e la stagione dell’assestamento e del generale “ritorno all’ordine” – ma rovesciato rispetto all’Italia liberale. È l’anno di nascita, in gennaio e in novembre, del Partito comunista d’Italia e del Partito nazionale fascista. Nelle tensioni ora clamorose ora sorde e nei travestimenti ideologici, nella mobilità disseminata della lotta delle idee che non si realizza in superamento dialettico ma si attua in fulminei cambi di ruolo, si consuma, nel tramonto di Giolitti e del progetto giolittiano, lo scarto tra un determinato sistema di valori e il senso di un’altra emergente gerarchia, quella fascista. La transizione si presenta in due forme preminenti e complementari: la prima, particolare e propria di quel frangente della storia italiana degli inizi del Novecento, è l’avvento del «regno delle parole»1, dello scollamento dal principio di realtà; l’altra, concernente un fenomeno europeo di ampia portata e collegata, causa ed effetto, al conflitto del 1915-1918, è la trahison des clercs, l’ideologizzazione in senso nazionalista del sapere e dello scienziato2. Ed ecco che si registra l’alternarsi veloce e violento dei modelli culturali di riconoscimento e autoriconoscimento, risultanti nell’incremento di enunciati ambigui, implicati in una diffusa «retorica dell’antanaclasi», così come seppe individuarla e descriverla, in un saggio quanto mai attuale, Tullio De Mauro. Ci sono stagioni che registrano con speciale rilievo tale fenomeno, quando le parole più importanti e fondative di identità, come fede, nazione, tradizione, compaiono con significati contrapposti. «Una stessa parola» ha scritto De Mauro «può ammettere senza difficoltà e perdita di unità accezioni antinomiche, come nelle parole sfruttate nella figura retorica dell’antanaclasi. L’unità si perde quando la generalità dei parlanti non sia più in grado di ricostruire l’ordito che, di filo in filo, lega un’accezione a un’altra»3. Sono osservazioni qui appena accennate ma necessarie per dare conto, nella dimensione storica della lingua, di una vicenda profondamente legata alla questione dell’interpretazione dei testi e dei discorsi, centrale nella storia politica della cultura e di un dibattito critico che per molte ragioni non rimase chiuso nelle rispettive riserve degli specialisti. Intanto è l’uso delle parole a rivelare una comunità che non si sentiva tale e non riusciva a impostare un discorso del legame sociale, tanto meno un’idea di cultura nazionale. Nel 1928, dall’osservatorio privilegiato di testimone, nella Storia d’Italia, a proposito del personaggio D’Annunzio divenuto, nella fastosa sopravvivenza di anticipatore, vera star del sistema della comunicazione totalitaria, Croce insisterà sulla rilevanza della dissociazione tra le parole e le cose come precondizione per la nascita del fascismo4. In effetti, la crisi dello Stato liberale è crisi di parole non condivise, di racconti non convergenti, a partire, come si sa bene, dal racconto della Grande Guerra. Basta controllare, in un confronto probante, le diverse pronunce del lemma fede negli scritti e nelle testimonianze del periodo 1915-1918: da parte del laicissimo Croce è l’esigenza di una nuova coscienza religiosa come compito da realizzare, senso di responsabilità; per Gentile è la mistica dell’azione, «l’atto assoluto che impegna il tutto»; per i vociani è l’epifania dell’Evento taumaturgico che prende il posto dell’attività del soggetto.
È da considerare tra gli esempi di significativo riuso di un testo eminente della tradizione proprio il massiccio investimento politico sulle parole e sull’immaginario dantesco. In direzione del nazionalismo, nel momento in cui la comunicazione giornalistica segna e modifica le pratiche discorsive, e si registra la secolarizzazione del lavoro del pensiero come servizio organico, ecco che letterati, accademici, intellettuali ambiscono a consacrare il proprio ruolo nell’agire attraverso rappresentazioni, immagini, affermazioni di valore. E l’infinita lontananza del mondo dantesco ne consente un’attualizzazione arbitraria.
Anticipatrice, a tutti gli effetti, la conferenza di Gentile del febbraio 1918, La profezia di Dante:
ei ammonisce, non esservi pace senza Stato forte; e finché questa forza non coincida con la giustizia e con la libertà, la pace esser vana speranza, e la guerra necessaria, da combattere senza tregua, senza esitanze, fermi nella fede che Dio la vuole; perché lo Stato […] fa uomo l’uomo, libero nel diritto: di quella libertà, che sola può lasciarci sentire la presenza di Dio in noi e nelle cose nostre […]. La vita dello Stato infatti è vita di uomini, vita spirituale: e questa vita non è dato concepirla se non come devozione assoluta a un’idea […]. Quella devozione, che fa il soldato sicuro incontro alla morte necessaria alla patria, ma fa anche ogni cittadino negli uffici più prosaici e meno rischiosi […], inflessibile nella coscienza e nella volontà del dovere5.
Fede, libertà, vita, Stato: le parole comuni ci sono tutte; ma se fino al 1912-1913 una formula come la nuova fede, riferita all’idealismo crocio-gentiliano, aveva rappresentato una forza polarizzante e ordinatrice, ora, con la montante dissimilazione fra i due, già dalla Discussione fra filosofi amici (1913), si scompigliano le procedure sottese alla circolazione e ridistribuzione degli enunciati che descrivono e formano la comunità: «la moltiplicazione dei piani del discorso accentua l’impossibilità di uscire dal cerchio»6.
In questo clima contrastante, nel “buco nero” che risucchia i valori e li restituisce polverizzati in vuoto verbale – secondo un’immagine ognora efficace7 –, anche nella biografia di Croce si registra una soluzione di continuità. Lo testimoniano le Pagine sulla guerra, libro unico e sui generis nel corpus delle opere di Croce, dove si raccolgono una per una e senza modifiche note, postille, recensioni, scritte in diretta dal 1914 al 1918, improntate a un singolare stato d’animo: il sarcasmo amaro di chi sa di avere (e di avere avuto, da neutralista coraggioso) inutilmente ragione e sa di dovere combattere su tutti i fronti. Il suo è, ora lo verifica giorno per giorno, un pensiero fra gli altri pensieri altrui. Ciò implica un cambio di passo retorico e argomentativo, anche in un libro-soglia come La poesia di Dante e concerne – come avverte il curatore delle Pagine sulla guerra – la questione di dire e comunicare il vero8. E muta, impercettibilmente, poi con evidenza, il principio assoluto dell’arte, sottoposta al conflitto delle interpretazioni nelle sedi istituzionali, anche le più conservatrici, e delle opinioni nei luoghi affollati della comunicazione giornalistica: con esso, l’autonomia del giudizio estetico.
Per l’impavidità con cui affronta la perdita di un consenso che prima della guerra appariva incrollabile, Croce è davvero il protagonista di maggiore rilievo e autorità morale del biennio 1920-1921, sull’orlo dell’abisso non ancora riconoscibile9; e anche il più esposto mediaticamente, per gli ambiti operativi che si trova contemporaneamente a presiedere, ministro della Pubblica Istruzione impegnato a impostare la riforma della scuola, i lavori preparatori della prima legge di tutela del paesaggio e a organizzare e gestire nel breve periodo le celebrazioni del secentenario della morte di Dante. Pure, questo protagonista eminente, chiamato da Giolitti in piena emergenza sociale e politica a contribuire a salvare «l’Italia in travaglio» («e non so» gli aveva detto Giolitti «se vi riusciremo»10), usciva dalla guerra in una posizione assai diversa dalla stagione della sua egemonia culturale, i primi quindici anni del secolo. In una lettera all’amico Alessandro Casati del gennaio 1920, Croce, ancora ignaro dello sconvolgimento che la drammatica esperienza ministeriale stava per portare nella sua vita e nei suoi disegni, quasi maelstrom o «vortice mentale»11, aveva annunziato il lavoro su Dante in poche righe ironiche e presaghe, tali da far trapelare l’aria del tempo che vi circola. «Lavoro ora intorno a Dante, pel centenario. Credo che anche in caso di bolscevismo si farà il centenario di Dante!»12. E qualche mese prima in una lettera al giornalista del “Mattino” Ettore Marroni, poi consegnata all’epistolario da lui stesso trascelto, leggiamo, a sorpresa, un passo significativo dell’autobiografia crociana. È il 1919:
Mi hanno molto interessato le cose che voi dite dell’età storica in cui siamo entrati. Vi confesso che anche io, durante la guerra, sono stato hanté del fantasma della decadenza di Roma antica. Voi sapete che vivo solitario nella solitarissima e isolatissima Napoli; vedo pochissima gente, non leggo molto i giornali e le riviste politiche. Mi sento un po’ (per restare nell’immaginazione della tarda romanità) come uno di quei fabbricanti di idoli pagani che, fattisi cristiani, seguitavano a fabbricare e a vendere Venere e Bacco e i dei Lari, perché non sapevano fare altro per vivere. Così io, checché succeda, seguito a far della filosofia e della critica, e ho terminato il mio volume su Ariosto, Shakespeare e Corneille, e ora sto rileggendo Dante. Anche Dante (a proposito!) vedeva in modo catastrofico la situazione del mondo ai suoi tempi; e il subisso non accadde13.
Il 1919 è l’anno del libro su Goethe e delle Pagine sulla guerra. Il saggio su Dante partecipa di questa temperie, della duplice rubrica che intreccia critica e politica.
Le celebrazioni dantesche del secentenario, se considerate nella dimensione testuale della cultura, costituirono il punto di svolta della parabola crociana, così come rappresentarono uno dei sintomi manifesti della complessa fenomenologia storica della crisi italiana, e anzi uno snodo importante di questa, per le spinte e le sollecitazioni che vi confluirono, portando alla luce moventi di assai varia natura, ideologica, economica e persino geografica. Al centro c’era La poesia di Dante14, un libro di critica e di teoria estetica, intorno al quale divampa la polemica, improvvisa e incandescente come mai altra nella storia delle lettere moderne15; presto duplicata in Parlamento, dove i decreti di Croce per le celebrazioni dantesche e per le riforme della scuola vengono bocciati e ribaltati16.
Il sismografo della letteratura registra oscillazioni allarmanti nei momenti in cui è instabile la gerarchia dei poteri, delle istituzioni, dei valori. Al pari del Bello, che è sempre, osserva Croce in una lettera a Gentile del 1898, «ciò che sembra bello», perché connesso alla storicità, al variare della vita, l’estetica crociana ora meno che mai vive fuori del tempo, coi...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Introduzione di Emma Giammattei
- 1. Convergenze della soglia. Benedetto Croce, la poesia di Dante, il 1921 di Emma Giammattei
- 2. La filologia dantesca contro Croce. Tra metodo e polemos di Emanuela Bufacchi
- 3. La «contemporaneità inesauribile». Storia e geografia di un centenario di Nunzio Ruggiero
- Ringraziamenti
- Gli autori