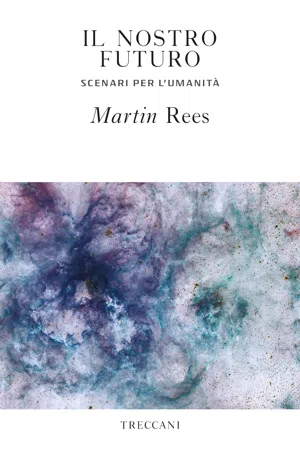
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il nostro futuro
Informazioni su questo libro
Il nostro futuro dipende sempre di più da come riusciremo a sfruttare i progressi delle scienze per affrontare le sfide ambientali e sociali che si profilano all'orizzonte. Allo stesso tempo le opportunità sono divenute il campo di paure paralizzanti, e l'umanità si è trovata a mettere in discussione un'idea di progresso pressoché millenaria, alle prese con una tecnologia che si fa biologia e un'intelligenza che diviene artificiale. Martin Rees costruisce una riflessione critica ma ottimistica, basandosi sul dialogo fra scienza e umanesimo e restituendo fiducia e lucidità allo sguardo sul futuro dell'umanità.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il nostro futuro di Martin Rees in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Filosofia ed etica nella scienza. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1
NEL BEL MEZZO DELL’ANTROPOCENE
Pericoli e opportunità
Qualche anno fa mi presentarono un noto miliardario indiano che, venuto a conoscenza del mio titolo di “astronomo reale”, mi domandò: «È lei che fa l’oroscopo alla regina?» Gli risposi restando serio: «Se la regina ne desiderasse uno, lo chiederebbe a me». Voleva a tutti i costi avere qualche mia previsione, così gli dissi che gli indici di borsa sarebbero andati su e giù, che ci sarebbero state nuove tensioni in Medio Oriente e così via. Mentre gli offrivo queste “intuizioni”, l’uomo mi ascoltava rapito. Poi decisi di essere onesto e gli dissi che ero un astronomo, non un astrologo. Di colpo perse ogni interesse in quello che gli raccontavo. E aveva ragione: di solito gli scienziati sono pessimi profeti, quasi quanto gli economisti. Negli anni Cinquanta, per esempio, un astronomo reale mio predecessore affermò che l’idea di viaggiare nello spazio era «una totale sciocchezza».
Politici e uomini di legge, d’altro canto, non sono molto più bravi. Tra i futurologi che in passato si sono cimentati con le previsioni, uno dei più sorprendenti fu Frederick E. Smith, conte di Birkenhead, sodale di Churchill e lord cancelliere britannico negli anni Venti del secolo scorso. Nel 1930 scrisse un libro intitolato The World in 2030 AD.1 Mentre gli altri futurologi suoi contemporanei immaginavano bambini cresciuti in provetta, macchine volanti e via fantasticando, lui previde un periodo di stagnazione. Ecco una sua tipica affermazione: «Nel 2030 le donne, grazie alla loro delicatezza e alla spiritualità, saranno ancora in grado di ispirare gli uomini migliori e spingerli verso mete che da soli non saprebbero raggiungere».
Non aggiungo altro!
Nel 2003 scrissi un libro che doveva intitolarsi Our Final Century?. L’editore inglese tolse il punto interrogativo, e quello americano cambiò del tutto il titolo in Our Final Hour.2 La mia idea di fondo era questa: la Terra ha quarantacinque milioni di secoli, ma quello attuale è il primo in cui una specie, la nostra, ha il potere di determinare il destino della biosfera. Allora non credevo che avremmo finito per autodistruggerci, ma ero convinto che per evitare catastrofi devastanti avremmo avuto bisogno di un bel colpo di fortuna. Perché la pressione sugli ecosistemi è divenuta insostenibile: il mondo è sempre più popolato e abbiamo sempre più fame di risorse. Inoltre – cosa ancora più spaventosa –, fornendoci sempre maggiori poteri la tecnologia ci rende allo stesso tempo vulnerabili a nuove minacce.
Nel sostenere le mie tesi mi ispiravo, tra gli altri, a un grande del primo Novecento, Herbert G. Wells, che nel 1902 tenne una conferenza, poi divenuta celebre, alla Royal Institution, a Londra.3 Ecco come concludeva il suo discorso:
L’umanità ha compiuto un lungo cammino, e la strada percorsa fino a oggi ci porta a immaginare un poco quel che sarà la strada futura.
[…]
È lecito credere che il passato non sia che l’inizio di un nuovo inizio, e che tutto ciò che è stato non sia che il crepuscolo che precede l’alba. È lecito credere che ciò che la mente umana ha compiuto fino a ora non sia che il sogno che precede il risveglio. […] Ma è dalla nostra razza, dalla nostra stirpe, che nasceranno le menti future capaci di volgere lo sguardo indietro, capire la nostra piccolezza e comprenderci meglio di quanto lo possiamo fare noi ora […]
Verrà un giorno, nella infinita processione del tempo, in cui nuovi esseri, oggi latenti nei nostri pensieri e celati nei nostri lombi, si ergeranno sulla Terra e, come posando il piede su una seggiola per spiccare un salto, ridendo alzeranno le mani per raggiungere le stelle.4
La prosa è abbastanza alata, ma il contenuto ci fa sentire vicino questo scritto di oltre un secolo fa: Wells aveva capito che gli esseri umani non sono l’apice della vita emergente sul pianeta.
Non era però ottimista, e conosceva i rischi di una catastrofe globale:
È impossibile dimostrare che non avverrà una totale distruzione e la fine della storia umana […] il che renderà vani tutti i nostri sforzi. […] Forse qualche entità dallo spazio, o una pestilenza, o una grave malattia portata dall’aria, i veleni presenti nella coda di una cometa, una grande fuoriuscita di vapori dall’interno della Terra, o la nascita di nuovi animali per cui saremo prede, o qualche sostanza chimica o un’epidemia di follia generale.5
Ho citato Wells perché rispecchia quella miscela di ottimismo e angoscia, oltre che di speculazione e scienza, che cercherò di trasferire nelle pagine di questo libro. Se fosse vivo oggi sarebbe entusiasta di quanto la nostra prospettiva sulla vita e sul cosmo si sia allargata, ma sarebbe forse ancora più colpito dai pericoli che ci circondano. La posta in gioco si è fatta più alta: la scienza offre opportunità grandiose, ma con conseguenze che potrebbero mettere in dubbio la nostra stessa sopravvivenza. Molti temono che le scoperte abbiano raggiunto una “velocità di fuga” che rende impossibile a chi ci governa e all’opinione pubblica tenerne il passo o comprenderle.
Forse pensate che, da astronomo, la paura che mi toglie il sonno sia quella di una collisione con un asteroide. In realtà, questa è una delle poche potenziali minacce che possiamo stimare in modo quantitativo, e quindi stabilire con una certa sicurezza che si tratta di un evento raro. Ogni dieci milioni di anni circa, infatti, cade sulla Terra un corpo del diametro di qualche chilometro in grado di causare distruzioni a livello globale, quindi ci sono poche possibilità che ciò accada nell’arco di una vita umana media. Molti di più sono invece gli asteroidi più piccoli che potrebbero fare danni di varia entità a livello locale. Per esempio, l’oggetto schiantatosi nel 1908 nella regione siberiana della Tunguska, per fortuna disabitata, ha raso al suolo centinaia di chilometri quadrati di boschi, e si stima abbia rilasciato un’energia equivalente a molte centinaia di bombe di Hiroshima.
È possibile essere avvertiti in anticipo di questi impatti? La risposta è sì. Si sta progettando un database che raccolga il milione circa di corpi celesti con diametro maggiore di 50 metri potenzialmente in grado di piombarci addosso. Lo scopo è monitorare con precisione le loro orbite e identificare in tempo quelli che si stanno avvicinando in modo pericoloso. Con un sufficiente preavviso sull’impatto, potremmo così evacuare le zone più a rischio. C’è poi una notizia ancora migliore: siamo teoricamente in grado di costruire un veicolo spaziale e di lanciarlo, qualche anno prima del previsto impatto, in direzione del corpo celeste per dargli un “colpetto”. Basta infatti alterare di pochi centimetri al secondo la velocità dell’asteroide per farlo deviare dalla rotta di collisione con la Terra.
Se applichiamo a questo scenario i calcoli che di solito si fanno per determinare un premio assicurativo, moltiplicando le probabilità per i costi delle conseguenze, risulta che conviene spendere qualche centinaio di milioni di dollari l’anno per ridurre il rischio asteroide.
Altre catastrofi naturali, come i terremoti e le eruzioni vulcaniche, sono più difficili da prevedere, e a oggi non esiste un modo credibile per prevenirli, né tantomeno per sapere in anticipo quando accadranno. Ma come per gli asteroidi, anche in questo caso c’è una notizia rassicurante: la loro frequenza non sta crescendo, e oggi è più o meno la stessa dell’epoca dell’uomo di Neandertal, o dei dinosauri. Le conseguenze di questi eventi, tuttavia, dipendono dalla fragilità e dall’importanza delle infrastrutture a rischio, che nel mondo urbanizzato contemporaneo è assai maggiore. C’è poi un fenomeno cosmico non compreso dai nostri progenitori (e da tutta l’umanità fino al XIX secolo): i brillamenti solari, ovvero eruzioni che possono causare tempeste magnetiche in grado di danneggiare le reti elettriche e le comunicazioni su tutto il pianeta.
A ogni modo, non sono i pericoli naturali che dovrebbero toglierci il sonno, bensì quelli creati dall’uomo, che oggi sono assai più minacciosi rispetto al passato e che, con il trascorrere degli anni, diventano sempre più probabili e potenzialmente più catastrofici.
L’abbiamo già scampata una volta.
La minaccia nucleare
Durante la guerra fredda, al culmine della corsa agli armamenti, le due superpotenze avrebbero potuto scatenare per sbaglio l’apocalisse, a causa di superficialità ed errori di giudizio. Era il tempo in cui si costruivano i rifugi antiatomici. Durante la crisi dei missili di Cuba ero uno dei tanti studenti che partecipavano a manifestazioni e sit-in; ci tiravamo su il morale con le canzoni di protesta dell’epoca, come quella di Tom Lehrer che diceva: «Ce ne andremo via tutti insieme quando sarà l’ora / soffusi di un bagliore incandescente».6 Ma in quei momenti avremmo avuto molta più paura, se avessimo saputo quanto la catastrofe fosse davvero dietro l’angolo. A crisi risolta sentimmo citare le parole del presidente Kennedy, il quale aveva detto che la guerra sarebbe potuta scoppiare «con una probabilità tra il 30 e il 50 per cento». Solo molto dopo il suo ritiro dalla politica l’allora ministro della Difesa Robert McNamara poté affermare con franchezza: «Eravamo a pochissimo dalla guerra nucleare e non ce ne siamo accorti. Non è merito nostro se l’abbiamo scampata, Kennedy e Chruščëv sono stati previdenti ma anche molto fortunati».
Oggi conosciamo maggiori dettagli su ciò che avvenne in uno dei momenti più tesi. Vasilij Arkhipov, stimato e pluridecorato ufficiale della marina sovietica, era il comandante in seconda di un sottomarino dotato di testate nucleari. Quando il comandante, suo diretto superiore, vide che gli americani stavano attaccando con bombe di profondità, dedusse che era scoppiata la guerra e si preparò a dare l’ordine di lanciare i missili. Le regole d’ingaggio, tuttavia, prevedevano che tale ordine dovesse essere approvato dai tre ufficiali più alti in grado a bordo del sottomarino. Arkhipov votò contro, evitando così di far partire un attacco nucleare che avrebbe potuto portare a un’escalation catastrofica.
Le stime successive alla crisi cubana suggerivano che la probabilità di morire in un disastro termonucleare durante la guerra fredda fosse circa diecimila volte superiore al tasso di morte per l’impatto di un asteroide. E in effetti andammo vicini alla catastrofe in più di un’occasione. Nel 1983 l’ufficiale dell’aviazione sovietica Stanislav Petrov vide comparire un segnale di allarme sul monitor: gli americani avevano lanciato cinque missili balistici intercontinentali Minuteman in direzione del territorio russo. Se avesse seguito il protocollo previsto in casi del genere, Petrov avrebbe dovuto informare il suo diretto superiore, che era autorizzato a far partire il contrattacco nucleare nel giro di pochi minuti. Ma basandosi su una semplice intuizione, decise di ignorare il segnale sullo schermo, pensando che si trattasse di un malfunzionamento del sistema di allarme. E aveva ragione: la macchina aveva scambiato i riflessi della luce solare sulla sommità delle nuvole per i lampi di un lancio missilistico.
Oggi sono in molti a sostenere che il sistema di reciproca deterrenza nucleare abbia funzionato, e in un certo senso è vero. Ma ciò non significa che fosse una soluzione politica avveduta. Se giocate alla roulette russa con una o due pallottole nel tamburo, la probabilità di sopravvivere è maggiore di quella di morire; ma accettare una partita è giustificabile solo se la posta in gioco è incredibilmente alta, o se pensate che la vostra vita valga spaventosamente poco. Durante la guerra fredda ci hanno convinto a giocare proprio questa partita. Sarebbe interessante sapere quale fosse il livello di rischio stimato dai potenti dell’epoca, e se la maggioranza dei cittadini europei, dopo essere stata adeguatamente informata, l’avrebbe considerato accettabile. Per quel che mi riguarda, non avrei mai scelto di giocare a un gioco che, in un caso su tre (o su sei, ma ugualmente inaccettabile), avrebbe avuto come esito la morte di centinaia di milioni di persone e la distruzione delle città europee, anche se l’alternativa fosse stata la certezza di finire sotto il dominio sovietico. Senza contare che le conseguenze drammatiche della guerra termonucleare si sarebbero palesate anche nei territori non direttamente sotto attacco, soprattutto se si fosse verificato lo scenario del cosiddetto “inverno nucleare”.
La minaccia dell’annientamento nucleare incombe ancora: unica consolazione è il fatto che, grazie agli accordi tra le superpotenze, oggi abbiamo circa un quinto dei missili in circolazione durante la guerra fredda (Stati Uniti e Russia hanno circa settemila testate ciascuno), e sono molti di meno anche quelli pronti al lancio immediato. Però le potenze nucleari sono diventate nove, il che fa aumentare la probabilità che gli arsenali più piccoli siano usati in conflitti regionali, o addirittura per atti di terrorismo. Non possiamo poi escludere che più avanti in questo secolo si verifichi un rimescolamento geopolitico che porti a un nuovo stallo tra superpotenze. Le prossime generazioni potrebbero vivere la loro versione della crisi cubana, che magari sarà gestita meno bene (o con minore fortuna) di quella del 1962. La minaccia nucleare, capace di mettere in discussione la nostra esistenza, rimane dunque sospesa, ma non è svanita.
Nel capitolo 2 esamineremo le nuove scienze del XXI secolo (biotecnologie, cibernetica e intelligenza artificiale) e i loro possibili risultati. Un loro uso scorretto è un rischio sempre più evidente. Le tecniche e le conoscenze necessarie per organizzare un attacco biologico o cibernetico saranno accessibili a milioni di individui, perché non richiedono infrastrutture enormi e costruite ad hoc come le armi nucleari. Il successo di un programma di sabotaggio come il virus Stuxnet, che permise agli americani di distruggere le centrifughe utilizzate dall’Iran per separare materiali nucleari, o i frequenti attacchi degli hacker alle istituzioni finanziarie, hanno già fatto capire al potere politico quanto queste preoccupazioni siano reali e importanti. Secondo un rapporto del comitato scientifico del Pentagono, un attacco digitale di portata catastrofica – tale da far collassare, per esempio, la rete elettrica statunitense – potrebbe rendere giustificabile una risposta nucleare.7
Prima di esaminare questi rischi, tuttavia, concentriamoci sulla potenziale devastazione causata dai disastri ambientali prodotti dall’azione umana e dal cambiamento climatico. Si tratta di minacce insidiose e con molte ramificazioni, che nascono dall’impronta ecologica sempre più pesante che l’uomo lascia sul pianeta. Se le generazioni future non avranno il passo più leggero, o se la popolazione non diminuirà, l’ecosistema finito della Terra sarà sottoposto a uno stress non più sostenibile.
Ecominacce e punti di non ritorno
Cinquant’anni fa la popolazione mondiale era di circa tre miliardi e mezzo di individui. Oggi si stima che ce ne siano più di sette miliardi e mezzo. Ma la crescita sta rallentando: il numero di nati vivi per anno, che aveva raggiunto la cifra massima pochi anni fa, è in diminuzione. A ogni modo, si prevede che nel 2050 toccheremo i nove miliardi, o forse più.8 Ciò è dovuto al fatto che nei paesi in via di sviluppo la popolazione è in maggioranza giovane, non ha ancora avuto figli e potrà contare su una vita più lunga. In futuro la piramide delle età di queste nazioni sarà più simile a quella europea. Oggi la crescita più imponente si verifica in Asia orientale, dove nei prossimi anni si concentreranno le risorse umane e finanziarie del mondo, ponendo fine a quattro secoli di egemonia nordatlantica.
Secondo le previsioni demografiche, avanzerà l’urbanizzazione: nel 2050 il 70 per cento della popolazione mondiale vivrà in città, e già nel 2030 Lagos, San Paolo e Delhi avranno superato la soglia dei trenta milioni di abitanti. Evitare che le megalopoli ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Prefazione
- Introduzione
- CAPITOLO 1. Nel bel mezzo dell’Antropocene
- CAPITOLO 2. Il futuro dell’umanità sulla Terra
- CAPITOLO 3. L’umanità in una prospettiva cosmica
- CAPITOLO 4. I limiti e il futuro della scienza
- CAPITOLO 5. Conclusioni