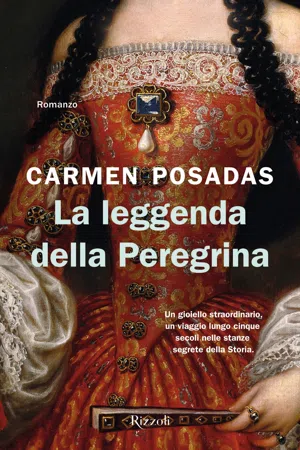Anno: 1580
Luogo: Madrid
«Sono un uomo pratico e parsimonioso.» Era così che amava definirsi don Diego de Tebes, alguacil mayor di Panama e ora compiaciuto proprietario della perla. E, a suo parere, durante la negoziazione con quell’uomo aveva dato prova di entrambe le qualità. Come diavolo si chiamava il tizio? Ah, sì, don Vicente de Tolosa, proprietario dello splendore che ora appartiene a lui. “Quanto è stato facile quell’acquisto, quasi come rubare una caramella a un bambino” si complimentò don Diego tra sé e sé. Era stato sufficiente menzionare i pirati perché questo don Vicente si accontentasse della metà del prezzo richiesto. «Tra gentiluomini è bene non pestarsi i piedi» così gli aveva detto prima di aggiungere che, nelle segrete di Porto Bello, stava scontando la sua condanna un tale che aveva appena confessato di essere testimone di come don Vicente commerciasse segretamente con i corsari di sua maestà inglese, la perfida regina Elisabetta. Il delatore non esisteva e non era mai esistito se non nella fervida immaginazione di don Diego, ma ai tempi era sufficiente che qualcuno fosse sospettato di trattare con i pirati perché si ritrovasse pieno di catene o, peggio ancora, mandato al patibolo.
«… Purtuttavia son certo che voi siate un galantuomo, per cui procediamo a concludere un affare tra cavalieri.» Così aveva detto subito dopo al proprietario dell’attività di pesca delle perle dinanzi allo sguardo di rimprovero di un vecchio schiavo sospettoso che lo accompagnava, un tale Romualdo. Quel negro aveva avuto la faccia tosta di sussurrare «State allerta, padrone» e lui, don Diego, si era prudentemente trattenuto dal dargli una frustata in faccia, come si sarebbe meritato. Perché, oltre a essere pratico e parsimonioso, era un uomo intuitivo e aveva la sensazione che don Vicente appartenesse a quella categoria di stolti che finivano per trasformare i propri schiavi in amici e confidenti e non era proprio il caso di far saltare l’accordo per colpa di un selvaggio stupido e impiccione. Ecco perché aveva sospirato, con grande comprensione e gentilezza, prima di aggiungere: «Vedete, vostra grazia? Persino questo vostro schiavo sa ciò che vi conviene fare e si preoccupa per voi. A cosa servono gli amici – e io da questo momento mi considero vostro amico e protettore – se non a intervenire in situazioni del genere? Ecco perché vi metto a conoscenza del fatto che, data la mia posizione di alguacil mayor di sua maestà, tutte le questioni concernenti l’amministrazione della giustizia passano dalle mie mani. Dimentichiamo or dunque l’incresciosa faccenda dei pirati, amici come prima, e giungiamo in fretta a un accordo. Quarantamila dobloni d’oro per la merce e che non se ne parli più».
Fu così che don Diego si impossessò di quella rara meraviglia, non senza che prima il vecchio Romualdo affermasse qualcosa in merito al fatto che le perle con una mano danno e con l’altra tolgono, o qualche idiozia del genere.
Ma che importanza poteva avere ciò che diceva uno sporco negro? Lui non credeva alle fandonie, e men che mai alle leggende e alle maledizioni degli schiavi. Era un uomo serio, razionale, ecco perché aveva ben chiara quale sarebbe stata la sorte della perla. Esattamente la stessa che vent’anni prima un altro cavaliere aveva riservato a un esemplare tanto insolito quanto questo, ugualmente acquistato da don Vicente de Tolosa.
In tutta Panama si raccontava di quel galantuomo – un vecchio magistrato che desiderava trascorrere i suoi ultimi giorni in Spagna – che, alla vigilia della sua partenza, aveva comprato una perla molto simile a questa al fine di farne dono alla sua giovane e adorata sposa. Tuttavia, la sorte aveva voluto che, a metà della traversata, la nave su cui viaggiavano venisse sorpresa da una grossa tempesta e che la giovane donna cadesse in mare e venisse inghiottita dalle onde davanti agli occhi inorriditi del marito. Stando a quanto si narrava, il giudice non era mai riuscito a liberarsi da tale visione e, una volta giunto al porto, aveva deciso, in memoria della moglie, di regalare al re, Filippo II, quella rara perla che lei tanto aveva amato. E quando il giudice aveva raccontato al sovrano la triste sorte della sua sposa – e questa, secondo don Diego, era la parte migliore della storia, quella che sembrava dar credito alla supposta leggenda secondo cui le perle restituiscono con una mano ciò che strappano via con l’altra – quest’ultimo era rimasto a tal punto colpito che, per alleviare la pena del vedovo, gli aveva concesso il marchesato di Mala Ola in ricordo della defunta.
“Mala Ola, onda crudele, che nome elegante” riflette adesso don Diego de Tebes mentre addenta filosoficamente un pezzo di formaggio secco che costituisce la sua cena. Quale titolo gli avrebbe conferito sua maestà allorché lui gli avesse regalato una seconda e ancora più splendida perla, pescata esattamente nello stesso punto?
In questo momento don Diego si trova a Madrid, alla pensione El Paraíso, luogo che di paradisiaco ha soltanto il nome, considerato che i suoi ospiti più assidui sono ragni, mosche e soprattutto cimici. E nemmeno il cibo è all’altezza del nome. Una brodaglia che più che altro sembra acqua, un tozzo di pane e due pezzi di formaggio secco è tutto quello che il locandiere gli ha potuto offrire. Ma don Diego decide di non lamentarsi: la parsimonia prima di tutto. Certo che la stanza è minuscola e piena di spifferi, il letto più duro di una pietra e il mobilio, fatta eccezione per un tavolino dalle gambe mingherline, brilla per la sua assenza. Ma quantomeno ha potuto posarci sopra i suoi oggetti devozionali preferiti, vale a dire una statuetta policroma di san Giorgio e due reliquie di tale santo: una zanna e due scintillanti squame del drago morto. E don Diego, come ogni notte, si affida a questi oggetti santi (che, tra l’altro, gli sono costati un patrimonio ma che, stando al frate che glieli ha venduti, sono provatamente miracolosi), non senza prima riesaminare gli altri interessanti avvenimenti di quella stessa mattina del suo arrivo a Madrid come, per esempio, quanto l’abbia impressionato ritrovarsi per la prima volta davanti alle alte mura e alle non meno alte torri dell’alcazar, il palazzo in cui risiede il più potente re della terra.
«In effetti, vostra grazia, è così. È lì che abita, con più di un migliaio di altre persone.»
Così gli aveva spiegato Alonso El Zurdo, locandiere e proprietario dell’eden in cui don Diego aveva portato le stanche membra dopo il lungo viaggio da Panama.
«Il re, e un altro migliaio di anime?» aveva ripetuto lui, scolandosi molto parsimoniosamente il mezzo quartino di vino che El Zurdo aveva appena posato sul tavolo, a suo dire per riscaldargli le budella. «Capisco che la corte di un tale signore richieda un numero considerevole di domestici, ma perdiana, un migliaio?»
«Be’, sapete già quel che si dice dell’alcazar, e, se non lo sapete, ve lo dico io: più che un castello è un alveare, con il suo miele appiccicoso, le mille cellette, le api, e anche parecchi fuchi…»
«Cosa intendete?»
«Be’, che sotto lo stesso tetto che accoglie il monarca del più grande impero mai conosciuto dalla storia sono accolte anche una miriade di entità ufficiali come il Consiglio delle Indie, quello delle Fiandre, d’Italia, d’Aragona, del Portogallo e un lunghissimo eccetera. Tutte realtà che, com’è naturale, necessitano a loro volta di un’infinità di legulei, apprendisti, informatori, consiglieri e operosi scribacchini. E questo per non menzionare, ovvio, tanti altri mestieri concernenti una qualunque delle necessità che sua maestà può arrivare ad avere. Ecco perché, all’interno dell’alcazar, sono presenti anche armaioli, coppieri, medici e cavadenti, esperti in erbe e purghe, falegnami, fabbri, barbieri e, ovviamente, musicisti, nani, buffoni, parassiti e tutti coloro il cui mestiere è intrattenere e far ridere – impresa, da quel che so, non affatto semplice – il nostro buon signore Filippo II.»
“Musica per le mie orecchie” si era detto don Diego, soddisfatto di aver scoperto che la fortezza era composta da uno sciame così chiassoso. Perché in tal modo, aveva riflettuto, accedere al suo interno sarebbe stato senza dubbio più semplice del previsto. “E anche meno dispendioso” aveva aggiunto, ancor più soddisfatto perché, considerata la sua proverbiale parsimonia, aveva molto temuto che raggiungere il monarca delle Spagne per fargli dono della perla che custodiva ben nascosta in un borsello di velluto nero gli sarebbe costato parecchi denari.
«Ma se state pensando che sia facile entrare a palazzo e raggiungere gli alti vertici» aveva detto a quel punto il locandiere quasi gli avesse letto nel pensiero, «non fatevi illusioni. Quello più che un alveare è un vespaio.»
«Dannazione» si era contrariato don Diego. «Ma ci sarà pur un modo di farsi largo lì dentro, dico io.»
«E dite bene, e potrebbe non essere troppo oneroso» aveva commentato il locandiere. «Certo che, per raggiungere il vostro obiettivo, dovrete poter contare su qualcuno in grado di farvi entrare tra quelle alte e invalicabili mura. Ma, suvvia! In questo e in molto altro vi posso essere assai utile, naturalmente previo pagamento di un modesto emolumento.»
«Quanto modesto?»
«Modestissimo, amico mio! È sufficiente conoscere qualcuno che viva in quel grosso alveare e io ho la persona perfetta. Mia nipote Angelilla che, oltre a fare onore al suo nome essendo un vero cherubino, si muove con grande disinvoltura in quella venerabile fortezza. Lavora come aiutante speziale nella farmacia reale, cosa che le consente di accedere a ogni zona del palazzo. Del resto, chi in un così brulicante labirinto non ha bisogno di una purga, di un cataplasma o di un paio di sanguisughe? Oggi un canonico… domani un leguleio… poi una dama di compagnia o un nano di sua maestà… e così via fino a qualsiasi membro della corte, che sia il re, la regina o uno dei piccoli infanti (che va detto, i poveretti sono davvero mingherlini). Ed è nelle stanze di tutti che, con alacrità, un sorriso radioso, e più bella di una mattina di maggio, si reca spesso la mia Angelilla. Se c’è qualcuno che vi può aiutare nel vostro proposito è proprio lei. Che faccenda ha tra le mani vostra grazia? Ditemi chi dovete incontrare e Angelilla se ne occuperà.»
Don Diego non aveva risposto alla prima domanda e aveva tentennato dinanzi alla seconda.
«Diciamo qualcuno della cerchia più vicina a sua maestà, io…»
Di certo san Giorgio da lassù stava muovendo i fili a suo favore perché non era stato necessario terminare la frase. Alonso El Zurdo aveva acconsentito dicendo di capire alla perfezione il grande riserbo con cui si esprimeva il suo stimabile e assai discreto ospite; che il silenzio era oro e che in bocca chiusa non entrano mosche, motivo per cui lui non aveva bisogno di sapere null’altro; c’era solo una cosa necessaria, imprescindibile in questi casi: «… Abbisogno che mi diate il vostro borsello».
«Il mio borsello?» si era stupito l’altro, temendo che il locandiere fosse entrato nella sua stanza mentre lui faceva il sonnellino e avesse sbirciato laddove teneva nascosta la perla.
Ma El Zurdo, dandogli un’invadente pacca sulle spalle, l’aveva tranquillizzato facendogli intendere che si riferiva al borsello in cui tutti i cavalieri tengono i propri denari: «… E non vi preoccupate, vostra grazia, anch’io sono più attaccato ai miei maravedí di una cozza al suo scoglio. Ma comprenderete che, per aprire la porta dell’alcazar, è necessario oliarne l’ingranaggio. Anzi gli ingranaggi, che nel vostro caso sono molti e di diverse dimensioni. Ma cosa pretendo di spiegare io a vostra grazia che non sappia già sulle faccende di questo mondo, sui suoi fasti e le sue opere!» aveva sospirato il locandiere. «A Madrid, come a Panama, come a Pernambuco, chi vuole pesce bisogna che s’ammolli e a chi non sborsa nulla non abbocca nessuno. Ma non vi preoccupate, di questo ingrato compito me ne devo occupare io. Un gran signore non deve affliggersi o abbassarsi a faccende relative al vile metallo. L’unica cosa che vostra grazia deve fare è darmi il denaro, ci penserò poi io a distribuirlo con la dovuta cautela.»
Fu così che il borsello – non quello della perla, ma quello dei denari che don Diego venerava (quasi) quanto il primo – passò dalla mano dell’alguacil a quella di Alonso El Zurdo, accortamente alleggerito dal primo che aveva deciso di tenersi, per pura cautela, una parte sostanziosa del contenuto.
«Certo, certo» gli aveva assicurato El Zurdo, replicando l’invadenza della pacca sulle spalle. «State certo, vostra grazia, che farò buon uso di questi ducati e maravedí. Vi assicuro che ci porteranno dritti fino agli appartamenti del re nostro signore e se no vedremo, perché la mia Angelilla è molto sveglia…»
Sulle strane cose che don Diego trovò all’alcazar dove gli angeli assomigliano troppo ai demoni
Angelilla, come avrebbe scoperto don Diego la mattina successiva, faceva parte dell’ampia schiera di api e fuchi che brulicavano dietro alle mura dell’alcazar. Constatare che il luogo in cui viveva il re più potente della terra assomigliava più a un mercato o a una piazza pubblica che a un palazzo, stupì l’uomo di Panama che, una volta attraversate le sue porte, per poco non divenne strabico nel tentativo di sbirciare tutto e di non perdersi nulla: le alte torri, i due grandi cortili, uno definito quello del re, l’altro della regina, entrambi con i loro porticati e i loro fascioni di azulejos e con un andirivieni di persone che si affannavano a portare ogni sorta di oggetto. Alcuni: assi, bulini e squadre; altri: attrezzi da fabbro o da fresatura; gironzolava anche, ben vestito, un leguleio carico di libri; più in là, con un aspetto decisamente poco pulito, vagavano un paio di passacarte. Menzione a parte meritava invece un gruppo di donne affacciate alla balaustra della loggia superiore, che don Diego immaginò essere nobildonne o dame di compagnia, mentre dal portico sul lato nord, e appena giunti dalla strada tutti impolverati, vide una decina di soldati, alcuni a piedi e altri a cavallo. Che altro poteva ancora vedere l’alguacil mayor di Panama? Ah sì, una mezza dozzina di bambini che scorrazzavano liberamente, diversi cani e persino un branco di oche che sbattevano le ali in modo molto suggestivo.
Se l’alguacil rimase pensieroso dinanzi a un tanto eterogeneo sciame, niente di quanto appena menzionato sembrava essere causa di stupore per Alonso El Zurdo che, dopo aver parlamentato con uno dei soldati di guardia, gli consegnò una moneta d’argento che l’uomo infilò tra i suoi abiti, senza il benché minimo riserbo, prima di permetter loro l’ingresso. «Ma non statevene lì a zonzo» fu il suo avvertimento, «o Angelilla e voi stesso ve la dovrete vedere con il sottoscritto.»
E mentre faceva scivolare un’altra moneta tra le dita di una seconda sentinella, El Zurdo rispose di sì, di non preoccuparsi, che non avrebbero perso tempo. Dopodiché, lui e don Diego s’incamminarono a passo deciso fino a raggiungere uno dei cortili. A quel punto, mentre l’alguacil si guardava attorno con il summenzionato stupore, il locandiere contò ad alta voce una, due, tre porte e si fermò davanti alla quarta, cosa che fece pensare a don Diego che quello fosse il suo modo di orientarsi in un tale chiassoso alveare.
«Angelilla… Angelilla, mia cara, sei lì? Sono tuo zio Alonso.»
Non ricevendo risposta, e nel tipico stile dell’alcazar dove tutti sembravano fare...