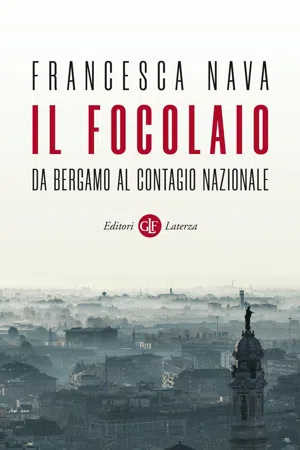III.
La zona rossa non s’ha da fare
La scienza sapeva
“Il 23 febbraio bisognava creare subito una zona rossa qui ad Alzano Lombardo”: queste le parole con cui mi lascia il direttore medico del presidio ospedaliero “Pesenti Fenaroli”, Giuseppe Marzulli, il 4 maggio.
La mia nonna materna Elena, citando Manzoni, mi diceva sempre che del senno di poi ne son piene le fosse. In molti, in troppi, nel corso delle settimane e dei mesi nei quali si susseguono i tragici eventi di Alzano e Nembro e di tutta la provincia di Bergamo, vanno ripetendo il concetto che nella mia terra ci si è mossi male e tardi. La frase “qualcosa è andato storto in Val Seriana” è quasi inflazionata. Ci fanno titoli e paginate i giornali cartacei e le testate online di tutta Italia, ci costruiscono intere puntate talk show e programmi d’inchiesta televisiva. Da tutto il mondo arrivano giornalisti, registi e videomaker per raccontare la tragedia dei morti di Bergamo, della città italiana ai piedi delle Prealpi, dove l’Esercito si è sostituito ai carri funebri. In meno di tre settimane mi trovo a rilasciare interviste a quotidiani ed emittenti di dieci paesi stranieri, dal Messico alla Turchia.
C’è un dato, gelido come il marmo, che ci viene sbattuto in faccia e che ci lascia senza fiato. Lo abbiamo già riportato ma vale la pena di ripeterlo: in un mese e mezzo a Bergamo muoiono di Covid-19 seimila persone. In alcuni paesini di montagna l’incremento del tasso di mortalità arriva al duemila per cento rispetto a quello dell’anno precedente. In Val Seriana va in scena un’ecatombe. Eppure nessuno riesce davvero a capire in quale momento si consumi il disastro. O meglio, in quali circostanze e sulla base di quali evidenze scientifiche si decida di non chiudere immediatamente un focolaio che sta divampando incontrollato. Chi sa e può decidere, perché non lo fa? Quello che succede è solo una tempesta improvvisa o è anche il frutto di scelte sconsiderate?
Dalla notte del 20 febbraio, quando scoppia il caso Codogno e si decide di istituire subito una zona rossa, al pomeriggio del 23 febbraio, quando divampa quello di Alzano e si riapre l’intero ospedale, che cosa accade? O meglio, qual è il fattore che cambia le carte in tavola in meno di 72 ore? Nella settimana successiva al 20 febbraio, la Lombardia registra un aumento rapidissimo del numero di casi affetti da Covid-19. Come ho già avuto modo di raccontare nei capitoli precedenti, a partire dalla mattina del 21 febbraio una squadra di tracciatori, coordinati da epidemiologi, virologi e infettivologi lombardi, si mette al lavoro per mappare il contagio intorno a quella che sarebbe diventata di lì a poche ore la zona rossa del Lodigiano. La task force opera anche nell’area circostante, arrivando a Cremona e a Bergamo. I dati epidemiologici vengono raccolti per lo più attraverso interviste telefoniche su casi confermati e sui loro contatti stretti. Si raccolgono date di insorgenza dei sintomi, caratteristiche cliniche, risultati dei campioni delle vie respiratorie e ricovero ospedaliero, fino a fornire stime del numero di riproduzione del contagio e dell’intervallo seriale (cioè il periodo di tempo tra il momento di insorgenza dei sintomi in un caso primario e il tempo di insorgenza nei suoi casi secondari). I dati raccolti vengono comunicati quotidianamente ai vertici di Regione Lombardia. Lo studio viene poi pubblicato il 20 marzo sul sito arXiv.
L’analisi si concentra sui primi 5.830 casi confermati in laboratorio per fornire la prima caratterizzazione epidemiologica di un focolaio di Covid-19 in un Paese occidentale. La rapida intensificazione della sorveglianza regionale messa in campo sin dai primissimi giorni dopo la scoperta del primo caso italiano – attraverso la tracciabilità dei contatti e il test delle esposizioni sia sintomatiche sia asintomatiche a casi positivi – fornisce da subito “informazioni critiche per l’individuazione di possibili collegamenti epidemiologici” e scopre “catene di trasmissione – in corso – precedenti all’identificazione del paziente uno”. Codogno non è la Wuhan italiana. A fine indagine un’importante osservazione viene messa per iscritto: “La stima del tempo in cui il virus si trasmette da una persona all’altra è di 6,6 giorni, compresa tra le stime ottenute per la provincia cinese di Hubei (media 7,5 giorni) e per le altre province cinesi (media 5,1). La differenza osservata di 1,5 giorni rispetto all’intervallo medio per le province cinesi al di fuori di Hubei è un possibile indicatore del fatto che i casi Covid-19 in Lombardia non siano stati isolati così rapidamente come in Cina e quindi continuino a diffondere l’infezione più a lungo”. In pratica, con questo primo studio, si mette nero su bianco che il tardivo isolamento dei casi Covid-19 in Lombardia abbia determinato una veloce e maggiore diffusione del virus. Solo nei primissimi giorni di tracciamento, nell’area di Codogno e in alcune città limitrofe, il numero di casi supera i 530 campioni positivi.
Nel gruppo di esperti che lavorano a questa indagine c’è anche l’epidemiologo Vittorio Demicheli, dal febbraio 2019 direttore sanitario dell’Ats di Milano Città Metropolitana, che copre un’area abitata da tre milioni di persone. Demicheli è stato scelto personalmente dal direttore generale dell’Ats Milano, Walter Bergamaschi, a sua volta nominato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel dicembre del 2018. Lo chiamo pochi giorni prima dell’avvio della cosiddetta fase due, il 30 aprile, per capire quale fosse l’evidenza scientifica del contagio in Lombardia in quei giorni di fine febbraio e quali fossero esattamente le indicazioni fornite a coloro che, dalla Regione e dal governo centrale, avrebbero dovuto prendere decisioni politiche sull’istituzione di nuove zone rosse. A partire proprio dal focolaio di Alzano Lombardo. Conosco Demicheli da oltre dieci anni. L’ho incontrato la prima volta nel 2010, quando era direttore del servizio di epidemiologia e referente per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive in Piemonte. Nel corso di quell’anno l’ho intervistato più volte durante la famosa pandemia dell’influenza suina, causata dal sottotipo H1N1 (variante fino ad allora sconosciuta) del virus dell’influenza A. È un epidemiologo di lungo corso, ci davamo del tu allora e continuiamo a farlo anche adesso. La chiacchierata con lui dura più di un’ora.
“Quando viene identificato il paziente uno di Codogno e iniziamo a cercare altri casi in modo attivo – mi spiega Demicheli – non tamponiamo meno di altri; il problema è che i nostri tamponi all’inizio ci fanno vedere che l’epidemia si era già diffusa ampiamente oltre i confini e che il tentativo di chiudere bene attorno a Codogno era insufficiente, perché il virus era già uscito da lì. E guarda che Codogno è stata chiusa in fretta, eh. Inizialmente nasce l’idea di fare una zona rossa più estesa, perché il numero di soggetti che veniva fuori con il contact tracing era soprattutto nei comuni vicini a Codogno, poi però avevamo identificato contagi andati molto lontano. Una cosa che dava l’idea di quanto il virus fosse andato ben oltre quell’area e che ci ha fatto dubitare che fosse partito da Codogno è che, per esempio, tra gli studenti di un Istituto Agrario di Codogno c’erano ragazzi della Valtellina e poi abbiamo trovato dei positivi anche in Valtellina, in provincia di Sondrio. I primissimi giorni l’idea era di allargare la corona attorno a Codogno, ad un’altra decina di comuni, poi io devo essere onesto, l’idea di Alzano è stata discussa con il comitato tecnico-scientifico, ma ricordo che c’erano fattori logistici e sanitari che rendevano la cosa complicata”. A complicare “la cosa”, secondo il direttore dell’Ats di Milano, sarebbe stato il fatto che uno dei due casi positivi di Alzano Lombardo si trovasse in ospedale già da qualche giorno (si tratta del primo paziente Covid della Bergamasca, Ernesto Ravelli, che trascorre due settimane in quell’ospedale, dal 5 al 19 febbraio) e per tale motivo, secondo il pool di esperti lombardi, una chiusura sarebbe stata tardiva. “Mi ricordo che questa ipotesi di chiudere tutto l’ospedale era stata scartata abbastanza velocemente – prosegue Demicheli – perché ci avevano detto ‘ma quello lì c’era già la settimana scorsa’, come dire ormai cosa chiudi, se c’era uno che infettava a questo punto aveva già infettato tutti. E noi allora abbiamo suggerito che bisognava prendere un provvedimento più drastico. Quando abbiamo scritto quell’articolo intendevamo chiedere non altre zone rosse, ma quella misura di cui si è parlato per più di una settimana e che hanno chiamato zona arancione, che era un livello non assoluto di lockdown, ma ne era già un principio”.
Quello che non mi torna, parlando con Demicheli, è il fatto che a fronte di una situazione già drammaticamente fuori controllo in Lombardia – parliamo del 27 febbraio – si perda tutto questo tempo prezioso e soprattutto che la richiesta di un “provvedimento più drastico” si traduca in una misura, di fatto, molto meno radicale rispetto a una zona rossa (trasformata l’8 marzo in zona arancione), vale a dire in una restrizione che non prevede la chiusura delle attività produttive e che consente, di conseguenza, la circolazione di merci e di persone (per motivi di lavoro) all’interno e al di fuori della regione stessa. Una regione, la Lombardia, con la più alta densità di fabbriche e di forza lavoro di tutta Italia. “Il problema era – prova a spiegarmi Demicheli – che se avessimo chiuso subito Alzano probabilmente i danni interni sarebbero stati un po’ ridotti (sic!), ma era già abbastanza chiaro che non avremmo fermato la diffusione del contagio, cioè la priorità era che l’infezione non si diffondesse al resto del Paese. Se tu ti rendi conto che chiudere solo in un punto non è sufficiente ad evitare che il virus vada in giro, l’alternativa è chiudere tutto”.
Sbam! Demicheli me lo dice en passant, eppure quel suo “l’alternativa è chiudere tutto” mi arriva come un pugno nello stomaco. Se già dopo pochissimi giorni dalla scoperta del paziente uno di Codogno appare evidente che “l’alternativa è chiudere tutto”, perché ad Alzano Lombardo si va avanti come se nulla fosse e, al contrario, si riapre tutto l’ospedale, senza mettere in sicurezza la struttura e in allerta la popolazione, che entra ed esce dagli ambulatori, si muove, va in città e viaggia su treni, autobus e aerei per due settimane? Faccio un respiro profondo per smorzare il mio sconcerto.
“Io mi ricordo un passaggio della presentazione che abbiamo fatto al ministro Speranza – prosegue Demicheli – in cui dicevamo ‘guarda che la zona rossa a questo punto può essere controproducente, perché dai alle persone la falsa illusione che il problema sia limitato a quella zona lì’. Se stiamo ragionando in termini di impatto sulla mortalità, se avessimo chiuso subito Alzano quando abbiamo chiuso Codogno, ovviamente avremmo limitato i danni in quell’area. Quando è maturata l’idea [di fare una zona rossa ad Alzano e Nembro], da noi, in Lombardia, c’era un tempo di riproduzione tra un caso e l’altro che era più corto di oltre un giorno e questo era uno di quei fattori che faceva anche abbastanza paura, perché se tu ritornavi al mattino trovavi che nella notte si era intasato un pronto soccorso. Arrivavano a grappolo le persone. Quindi secondo me è vero, bisognava chiudere tutto, però è diventato abbastanza evidente che, siccome il virus continuava a scapparci, per bloccare la diffusione nel resto del Paese la zona rossa sarebbe stata insufficiente. Il lockdown richiede comunque un po’ di adesione consapevole delle persone, in quel momento lì l’idea che ci fossero due o tre zone rosse poteva addirittura essere controproducente, perché tu immettevi la falsa percezione che il problema fosse limitato ad Alzano o a Codogno. Ma in realtà non era così. Dopo di che c’è stato un altro tipo di scambio, che probabilmente è avvenuto, ma è avvenuto in stanze diverse da quelle in cui lavoravamo noi”. In stanze diverse.
Ora, memorizzate bene questa data: sabato 29 febbraio 2020. Nel corso di questo capitolo vi spiegherò perché questa data funesta sia così importante nella ricostruzione del percorso decisionale che porta alla non creazione di una zona rossa in Val Seriana e alla successiva istituzione di una zona arancione in tutta la Lombardia e in seguito in tutta Italia.
Limitare i danni
“Se avessimo chiuso subito Alzano quando abbiamo chiuso Codogno, ovviamente avremmo limitato i danni in quell’area”. Ora proviamo a sostituire la parola “danni” con la parola “morti”. Anche solo per rispetto di chi, durante questa pandemia, ha perso improvvisamente un famigliare, un amico o un conoscente, senza sapere se sia stato fatto tutto il possibile per proteggerlo. Chi non ha vissuto la follia di quei giorni, la crudeltà di quelle morti, lo spaesamento dei bergamaschi, forse farà fatica a comprendere questo bisogno profondo di ristabilire un uso corretto delle parole e di rimettere in fila, uno ad uno, tutti i passaggi che portano a questo epilogo micidiale. Non sta a me prendere posizione in merito, ma sentir parlare di “danni” quando per due settimane non si è fatto nulla per mettere le persone al sicuro mi lascia addosso un senso di totale incredulità. La scienza sapeva, la politica era informata, la gente è morta. Se ci sia o no un nesso di causalità tra questi tre fattori lo accerterà eventualmente la magistratura. A prescindere dall’esito delle indagini, quello su cui vogliamo concentrarci in questo nostro racconto è la responsabilità politica delle scelte adottate. Ecco perché continuo la mia intervista con l’epidemiologo che ha vissuto, minuto per minuto, tutte le prime fasi di quei giorni drammatici.
“Se mi devo fare uno scrupolo di coscienza – ammette Demicheli – me lo faccio, perché da quando ci è apparsa chiara la necessità di chiudere tutto a quando siamo riusciti a trasmetterla alla consapevolezza dei decisori sono passati dei giorni preziosi, che hanno fatto la differenza. Col senno di poi adesso chiuderei l’Italia il 23 febbraio”. Mi dice proprio così: “col senno di poi”. “Questa malattia si è diffusa sotto traccia per delle settimane – mi spiega – e quando è emersa era già diramata. Questa è la verità che bisogna ammettere. Io mi ricordo che, a proposito del paziente uno di Codogno, abbiamo tamponato degli interi condomini e poi nel giro di quattro-cinque giorni da noi la dimensione era diventata tale che tra i nostri dicevamo ‘ma come ci mettiamo qui a fare le domande?’ Non riuscivamo a ricostruire i contatti, non finivi un’intervista che l’indomani ce ne sarebbero state altre cinquecento in più da fare. C’è stato proprio un momento in cui la velocità era quella, la stessa che vedevi negli ospedali. Andava fatto un lockdown nazionale in fretta. Cioè, la Lombardia alla fine se ne frega e infatti la zona rossa di Codogno la fa il governo, invece in seguito la zona arancione della Lombardia la fa Fontana insieme a Speranza”. Che il direttore sanitario dell’Ats di Milano, un epidemiologo, autore – insieme ad altri colleghi scienziati – di un’indagine sulla fase iniziale dell’epidemia di Covid-19 in Lombardia, mi dica che la sua Regione “se ne frega” non è un segnale incoraggiante.
Il 26 febbraio il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, annuncia in diretta Facebook che una delle sue strette collaboratrici è positiva al coronavirus, motivo per cui viene sospesa la quotidiana conferenza stampa in Regione e viene effettuato il test a tutti quelli che sono entrati in contatto con lei. Tutti negativi, compreso Fontana, che alla fine del video annuncia che si metterà in auto-isolamento per due settimane e mentre lo dice indossa goffamente una mascherina. Un gesto criticato da molti e a cui Fontana risponde dicendo che “bisogna avere rispetto per gli altri, quindi, pur essendo io non infettato dal virus, dato che ho avuto rapporti quotidiani con una persona che invece, purtroppo, risulta essere stata contagiata, devo muovermi con una certa cautela, perché la mia negatività può trasformarsi in positività in qualunque momento nei prossimi dodici giorni”.
Il 27 febbraio la conferenza stampa in Regione si svolge regolarmente, Fontana è videocollegato. Dopo i saluti iniziali, annuncia l’acquisto di quattro milioni di mascherine per i medici e gli operatori sanitari, poi passa la parola all’assessore al Welfare, Giulio Gallera. “Stiamo guardando con attenzione la zona di Alzano – dice il titolare della Sanità regionale –, ma al momento non c’è nessuna ipotesi di introdurre nuove zone rosse. Noi dobbiamo sempre prendere provvedimenti consultando esperti e istituzioni, affinché riusciamo a mantenere un giusto equilibrio tra contenimento del virus e minori danni possibili alla nostra economia e alla libertà e socialità delle nostre persone, sapendo che questo lo stiamo facendo non solo per la Lombardia, ma per tutto il mondo”. Quel giovedì 27 febbraio, mentre Gallera rassicura la stampa, Demicheli e i suoi colleghi si scambiano telefonate frenetiche: è evidente che il contagio in Lombardia è ormai fuori controllo. Gallera, tuttavia, dichiara che per ora le scuole resteranno chiuse in tutta la regione solo fino al 1° marzo. Si attendono disposizioni dal governo centrale. La volontà di centellinare all’opinione pubblica le misure di contenimento è prioritaria. La parola d’ordine è: no panic.
Durante la conferenza stampa di venerdì 28 febbraio in Regione intervengono diversi esperti. Ad aprire il dibattito c’è l’infettivologo Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale “Luigi Sacco” di Milano. Le sue dichiarazioni fanno scalpore. “Sicuramente non è una situazione facile e scordiamoci che sia una situazione che possa essere rapidamente risolta”, afferma il professore con tono pacato, ma deciso. “Le mie sono parole non popolari, ma questo è un dato di fatto. Un numero di infezioni così alto è qualcosa del già avvenuto, un qualcosa che è avvenuto prima della presentazione del paziente uno di Codogno. Dobbiamo ridurre questa diffusione in modo da passare da un R0 del 2,5 a meno di 1. Siamo in una situazione al limite della tenuta per le nostre terapie intensive. Gli ospedali di Lodi e di Cremona sono sovraccarichi di pazienti. In una realtà di questo genere circoscrivere il problema non può limitarsi agli interventi – seppur importantissimi – attuati sulla zona rossa con grande rapidità, ma deve necessariamente articolarsi su alcune misure che portino l’intera area metropolitana il più possibile fuori dai guai. È una medicina amara da inghiottire, ma personalmente non cred...