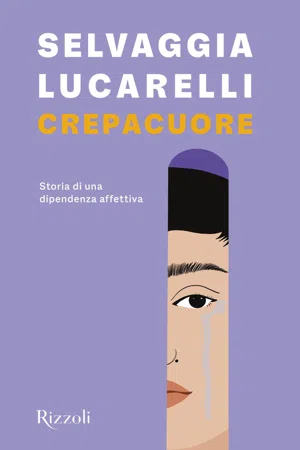«Non chiederti se saremo felici. Io so che lo saremo. Tanto. Tra le tue braccia io sarò duttile come la creta. Io sarò riservata e appassionata, fiera e sottomessa, come ogni eroina shakespeariana, se tu lo vorrai. O misteriosa, evanescente, pallida e trasognata come ogni creatura femminile del Poe. Non avrai che da scegliere.»
Era il 1965. Una ragazza imperiese di ventidue anni piena di talenti, ambiziosa, a un passo dalla laurea in giurisprudenza, si era innamorata.
Scriveva lettere appassionate all’oggetto del suo amore, uno studente fascinoso e irrimediabilmente fuori corso di Genova, che di anni ne aveva trentuno. Di lì a poco – fresca sposa – quella ragazza avrebbe abbandonato l’università e si sarebbe trasferita in un luogo ignorato dalla geografia. Non fu mai docile come certe eroine shakespeariane.
Fu però sottomessa. Da se stessa, soprattutto, e dalle sue scelte. Dall’idea romantica dell’amore che la ingannò e la convinse che solo nell’amore sarebbe stata piena e risolta.
Quella ragazza era mia madre.
Ho attraversato la sua rabbia per anni, promettendo a me stessa che mi sarei presa tutto quello a cui lei aveva rinunciato. Che io sarei stata la donna che lei non era stata. Che avrei studiato, lavorato, viaggiato, che non le avrei permesso di specchiarsi in una figlia pavida e inerte. Avrei spezzato quella catena di infelicità immobile e rabbiosa, di vite mai partorite, rintanate nel ventre illusorio del romanticismo. Vite che erano state la sua e quella di sua madre, infelice per un marito capitano di navi mercantili sempre assente, e quella della madre della madre che voleva scrivere romanzi e alla fine aveva fatto la moglie.
Io avrei riscattato il loro passato. Mi sarei presa il futuro che non era stato. Sarei stata un’eroina, sì, ma della Marvel. Quale Shakespeare.
E così fu.
Solo che mentre mantenevo fede ai miei propositi, mentre lavoravo, studiavo, guadagnavo, viaggiavo, non mi accorgevo che avrei potuto affrancarmi da tutto, tranne che da una cosa: l’imprinting sentimentale. Nella sfera relazionale ero quello che avevo respirato, senza realizzarlo. E se negli altri aspetti della mia esistenza – dal lavoro alla vita sociale – stavo agendo per compensazione, in quella emotiva agivo per reiterazione.
C’era qualcosa di latente in me, trasmesso alla nascita o forse prima, un’urgenza fatale di essere amata, un’idea di amore assoluto e annientante che ho ritrovato nelle lettere di mia madre, che ho riconosciuto nella sua infelicità ringhiosa, nella sua illusione sognante di poter essere felice, seppur infelice come un’eroina shakespeariana.
Solo che non lo sapevo.
Non sapevo che mia madre fosse stata qualcosa in più che infelice. Non sapevo nulla di quel bacillo segreto e camuffato che avevo ereditato e di cui nessuna delle due conosceva il nome.
Finché non è arrivato lui.
Avevo trentatré anni e stavo per essere investita dalla consapevolezza tardiva di avere un guasto.
Con la lucidità di oggi posso affermare con certezza che di indizi di quello che stava per accadere ne avevo seminati un bel po’, ma fino ai trentacinque anni ho vissuto con la beata inconsapevolezza di chi ha perso l’abitudine di osservare i dettagli. E il dettaglio ricorrente, dal primo amore del liceo all’ultimo che si stava sfasciando, era sempre quello: la mia sindrome dell’abbandono. Una sindrome che in realtà partiva da lontano. Da bambina, per un lungo periodo, mi svegliavo la mattina e rimanevo nel letto atterrita, piangendo il più silenziosamente possibile, convinta che i miei genitori mi avrebbero abbandonata. Che sarebbero morti, che mio padre sarebbe partito per qualche fantomatica guerra dall’altra parte del mondo. Quando iniziò la costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro (mai entrata in funzione), a pochi chilometri da casa mia, attraversai un lungo periodo di ostinata cupezza che nessuno riusciva a decifrare. Avevo otto anni ed ero assolutamente convinta che un incidente nucleare mi avrebbe resa orfana. Non avevo paura di morire, avevo paura di sopravvivere e di rimanere sola. Quando, anni dopo, arrivò la notizia che sarebbe stata convertita in centrale termoelettrica, provai un sollievo enorme, un alleggerimento emotivo che ricordo ancora oggi attraverso l’immagine vivida di mio padre che sventolava soddisfatto un articolo di giornale. Poi c’erano le discussioni tra i miei. «Un giorno vi sveglierete e non mi troverete più» era la frase più ricorrente di mia madre all’apice del climax. Mia madre, ovviamente, non sarebbe mai andata a comprare il pane senza mio padre e non si sarebbe allontanata da casa neppure se fosse stata infestata dallo spirito di Adolf Hitler, ma io – bambina – reputavo la minaccia plausibile. Mi chiudevo nell’armadio per non sentire, interrogavo mio fratello maggiore sull’attendibilità delle sue intimidazioni.
«Ma va» mi rispondeva sempre lui, che al massimo temeva l’abbandono degli Spandau Ballet da parte di Tony Hadley. Certe volte, dopo le liti più violente, in casa seguivano lunghi periodi di silenzio. Un silenzio scuro e pervicace, che temevo potesse precedere una fuga, un addio, un abbandono senza preavviso. In quel silenzio io sentivo il preludio della mia solitudine. Allora – nell’età in cui i dettagli sono fotografie – cercavo dei segnali, anche piccoli, per decodificare il presente. Per comprendere quanto fosse grave la crepa tra i miei genitori. Nessuno mi spiegava nulla, mio padre e mia madre non avevano l’abitudine di ritenerci spettatori, i miei fratelli vivevano il conflitto come normale amministrazione. E io quindi osservavo. Osservavo tutto, le carezze respinte, i baci rifiutati, le domande abortite perché prima del punto interrogativo l’altro cambiava stanza, gli sguardi posati sulle spalle dell’altro, gli sforzi di rivolgere la parola a noi figli, perché noi figli eravamo incolpevoli, ma rompere il silenzio era un segnale di normalità che l’uno non voleva lanciare all’altro. Ero solo una bambina, ma senza accorgermene stavo imparando un codice. Stavo assimilando una modalità relazionale che avrei replicato molte volte, in futuro, senza neppure rendermene conto. Mio padre era un uomo di poche parole e il suo silenzio non mi impressionava. Mia madre era una donna di molte parole, il suo silenzio era dirompente e punitivo. Mi terrorizzava.
Un’estate andammo in vacanza in Sardegna. Per percorrere la distanza tra nord e sud mio padre decise di non imboccare la Carlo Felice, ma una strada panoramica. Mia madre era terrorizzata dalla macchina. Del resto, tra le tante cose che non ha fatto per rendersi autonoma e per dipendere in tutto da mio padre c’è stato il prendere la patente. Quella strada era una curva continua, un burrone dopo l’altro. A tutto questo si aggiungeva il fatto che il giorno prima mia madre e mio padre avevano litigato. Non sapevo quale fosse l’origine del conflitto, ma conoscevo il duro codice del silenzio tra di loro, quel guardare sempre dritto di mia madre quando mio padre tentava un approccio, come se l’orizzonte, da qualche parte, le suggerisse la soluzione. O una via di fuga. Quel viaggio fu infernale. Avevamo tutti paura degli strapiombi che accompagnavano ogni curva, io e i miei fratelli avevamo la nausea, mia madre non parlava con nessuno ma teneva stretta la mano sulla maniglia sopra il finestrino, quindi capivamo che era nel panico. Era arrabbiata per via di mio padre e impaurita per via della strada, io sentivo quella tensione appiccicata addosso, assieme al sudore. Pensavo che quello sarebbe stato l’ultimo viaggio tutti insieme, che lei ci avrebbe abbandonati, che quella mano stretta alla maniglia, come se stesse viaggiando su un vecchio tram, fosse l’ultima stretta prima di volare via. Dopo ore di tornanti e silenzio, il viaggio finì. Mia madre aprì bocca per la prima volta il giorno dopo, al mare. «Mi fa male il dito, non riesco a muoverlo» disse. Mio padre la portò al pronto soccorso. In quel misto di paura e cose non dette, di terrore e rabbia soffocata, aveva stretto così forte quella maniglia che si era fratturata un dito. Non dire può fare molto male, avrei dovuto impararlo. Negli anni, ho cercato innumerevoli spiegazioni per i silenzi di mia madre. Alla fine, ho concluso che era l’unico modo che conosceva per acquisire un’illusoria idea di forza nel suo matrimonio. Incapace di prendersi ciò che la sua intelligenza e i suoi talenti avrebbero meritato, completamente pervasa in gioventù dall’ideale dell’amore assoluto e poi delusa dalla realtà (che comunque non avrebbe mai potuto essere all’altezza delle sue aspettative), sceglieva il silenzio perché ammettere ad alta voce la verità era troppo doloroso. La verità è che mia madre, sebbene non fosse capace di riconoscerlo, dipendeva completamente da mio padre. Quando lo ha incontrato, ha rinunciato a una parte di sé, convinta che lui potesse colmarla. Quel vuoto non le ha mai dato pace.
E non mi ha mai dato pace, perché quel vuoto era anche il mio. Un vuoto più subdolo, perché mascherato da molti “pieni”. Successi scolastici, il trasferimento a Roma appena finito il liceo, relazioni, lavori appaganti. Non c’era tempo per interrogarsi su cosa non andasse nella mia vita, perché la mia vita era tutto quello che mia madre non aveva avuto, quindi stavo facendo bene. Non sarei stata arrabbiata, mi sarei potuta comprare un vestito con i miei soldi, quello che scrivevo non sarebbe rimasto in un cassetto come le poesie di mia mamma, avrei vissuto dove succedono le cose, mica dove ci si va a nascondere. Ero bella, i ragazzi si giravano a guardarmi, avevo la mia forma di potere, avrei governato le mie relazioni, sarei stata felice. Lo ero già, in qualche modo, mi pareva.
Avevo però la memoria dell’anguilla. L’anguilla europea, in età adulta, compie una migrazione incredibile: attraversa l’oceano Atlantico, pur non essendo una nuotatrice fenomenale e va a deporre le sue uova nel mar dei Sargassi, tra le Antille e le Azzorre. Immaginate questo viaggio lungo anche cinquemila chilometri, che so, da Comacchio ai Caraibi, per poi riprodursi e morire lì. Ecco, le larve “orfane”, senza una guida adulta, possiedono quella che qualcuno ha denominato «memoria magnetica». Non restano dove nascono. Nuotano tre anni, sfruttano le correnti oceaniche e tornano dove “la madre” era partita. Le anguille sono animali misteriosi, la cui complessità appassionò anche un giovane Sigmund Freud, nel suo periodo di studio presso la stazione zoologica di Trieste.
Io ero andata lontano, ero sola in una grande città con i miei mezzi e le mie capacità, a una distanza di sicurezza da contaminazioni emotive, ma avevo la memoria dell’anguilla. Sarei tornata lì, nonostante tutto. Senza deciderlo, seguendo una corrente emotiva la cui temperatura e direzione mi erano inconsapevolmente familiari.
Dai sedici ai trentacinque anni non ho mai vissuto una pausa sentimentale. Il ragazzo del liceo mi lasciò dopo due anni di miei inutili struggimenti. Conservo un diario dell’epoca in cui non facevo che scrivere quanto poco mi sentissi amata, nonostante lui mi rassicurasse in ogni modo. Rinunciavo alle gite per stare con lui, piagnucolavo quando lui partiva, vedevo il suo ingresso all’università come una minaccia: troppi chilometri, troppi treni, troppe occasioni, troppa vita fuori da noi. Il giorno in cui lui, Marco, fece la cosa più giusta della sua vita ormai adulta (mi mollò, esausto) io mi feci trovare sul bordo del letto, in lacrime, dai miei genitori. «Non mi vorrà mai più nessuno» dissi. Mi consolarono, ignari del fatto che per me quello era il giorno in cui si compiva l’autoprofezia più temuta: ero stata abbandonata. Da quel momento, in ogni relazione successiva, mi assicurai di avere il controllo della situazione. Ho collezionato poche storie, rigorosamente lunghe, in cui avevo un ruolo dominante, in cui la mia fame d’attenzione e d’accudimento era continuamente soddisfatta da fidanzati pazienti e amorevoli. In cui la simbiosi era dovuta, perché qualunque slancio individuale dell’altro era per me un affronto, una minaccia, un tradimento. Ero una discreta manipolatrice affettiva, ma non nascondevo chissà quali mire: desideravo solo che l’altro mi sfamasse. Sempre e continuamente.
Questa consapevolezza all’epoca era lontanissima. Non c’era qualcosa che non andasse in me, era l’altro che non mi dava abbastanza. Era l’amore che andava così. Era la forma di tutte le relazioni. E se qualcuno amava diversamente era perché non amava abbastanza.
Alla fine, dunque, con fidanzati così adoranti e cedevoli, trovavo un habitat per le mie inquietudini.
Il lavoro e tutto quello che di positivo arrivava fuori dalla relazione mi entusiasmava e allo stesso tempo mi spaventava. Poteva allontanarmi e questo mi rendeva insicura. Cercavo il modo di creare occasioni di lavoro con i miei fidanzati e ci riuscivo, ero brava, perché mai dovevo fare l’attrice se potevo scrivere spettacoli al mio fidanzato attore o se potevamo recitare insieme? Perché mai lui la sera doveva andare a lavorare da solo, in discoteca, se anche io potevo fare la pr e lavorare con lui? (A vent’anni diventai bravissima perfino come pr, chi l’avrebbe mai detto.)
Poi, quando la scrittura e i primi successi sul web e in tv, slegati da ogni relazione, cominciarono a crearmi un’identità più precisa, a schiarire l’orizzonte delle mie attitudini, a chiedere a gran voce che cominciassi a non spartire più i traguardi con nessuno, nel giro di pochi mesi misi in pausa il futuro che si stava delineando: mi sposai. Sei mesi dopo nacque Leon. In sostanza, mi fermai quando stavo iniziando a correre. Mi sposai – e questo è il paradosso – quando stavo diventando una persona sola. Avevo ventinove anni, il mio primo contratto da conduttrice tv ed ero incinta. Durante la gravidanza smisi di scrivere sui giornali con cui avevo importanti collaborazioni appena nate, mi dicevo: “Voglio godermela”. Ricordo quando inviai la mail al noto direttore di una rivista in cui gli comunicavo che «sono incinta, quindi sospendo la mia collaborazione». Mi rispose sorpreso: «Sei il primo caso di donna a cui al terzo mese di gravidanza vengono le nausee di scrivere». In effetti, che “volessi godermela” era ciò che mi raccontavo, ma non era vero. La verità è che continuavo ad avere paura della mia indipendenza. Da una parte facevo, costruivo, perché ero brava e perché volevo prendermi tutto, dall’altra disfacevo perché quel mio desiderio non era compatibile con la fusione totale nell’altro.
La memoria dell’anguilla si risvegliava ogni volta che arrivavo troppo lontano. Dovevo tornare in quel posto che qualcuno prima di me aveva abitato, qualcuno con i miei occhi, il mio passo e il mio stesso odore.
Nel 2007 avevo un figlio di due anni e un matrimonio di tre, precocemente invecchiato. Quel fallimento, appunto, era il naturale approdo di due scelte infelici: quella mia e quella del mio ex marito. Dopo un anno dal parto ero tornata a lavorare e mi sentivo addosso l’irrequietezza solita di chi tira una coperta sempre troppo corta. La separazione l’avevo voluta io. In età adulta avevo chiuso io anche le mie relazioni precedenti. E non le chiudevo mai quando sentivo che erano esaurite, ma solo quando ero certa di avere un nuovo approdo. Un intervallo di solitudine, di vita sentimentalmente sgombra mi sembrava un’idea intollerabile. Questo comportamento, credo sia superfluo specificarlo, ha fatto sì che non abbia lasciato ricordi svenevoli e petali di rosa dietro di me. In definitiva, quando trovavo qualcuno capace di sfamarmi con rinnovato entusiasmo, l’altro poteva rimanere pure col cucchiaio sospeso a mezz’aria: aveva esaurito la sua funzione. Poi certo, in qualche caso c’è stato un discreto concorso di colpe, ma sopra ogni cosa prevaleva la mia coazione a ripetere uno schema malsano, in cui il mio ruolo dominante rimandava il momento in cui avrei dovuto comprendere il guasto.
Nel 2007 quel tempo era scaduto. Era arrivato il momento di fare i conti con la mia ferita primordiale. Stava per iniziare un lungo, rovinoso periodo di dipen...