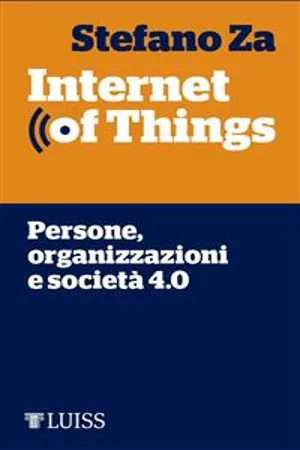![]()
Capitolo 1
Un po’ di storia: dalla conquista della Luna alla conquista delle cose
Nel corso della storia l’uomo ha sempre cercato un modo per trascrivere, documentare, condividere ciò che accade nella realtà. Nell’arco della sua esistenza ha utilizzato diversi supporti di memorizzazione e linguaggi che gli hanno permesso di codificare e condividere informazioni tra i suoi simili, presenti e futuri. Potremmo ad esempio partire dagli albori, considerando le pitture rupestri, le quali permisero all’uomo preistorico di rappresentare momenti della propria vita, codificandoli in semplici pitture (linguaggi) riportate solitamente sulle mura (supporti) all’interno di una caverna. Tra l’altro, c’è da notare che il supporto utilizzato si è dimostrato abbastanza affidabile, dato che le informazioni sono ancora disponibili a distanza di diverse migliaia di anni. Comunque, con il passare del tempo l’uomo ha perfezionato la codifica delle informazioni, elaborando linguaggi e utilizzando supporti sempre più evoluti e condivisi (come tavole di legno, papiri, libri, videocassette, sino ad arrivare ai moderni supporti digitali). Volendo raccontare come siamo arrivati a discutere di “Internet of Things”, trascurando l’evoluzione che nel corso dei secoli ha contraddistinto i linguaggi e i supporti di memorizzazione, potrebbe essere sufficiente fare un passo indietro di non più di cinquant’anni, in quello che può essere identificato come il periodo della rivoluzione digitale e più specificatamente la nascita di Internet.
“lo”, ovvero la nascita di Internet
Il 1969 molti lo ricorderanno, forse un po’ meno i giovanissimi, come l’anno di una conquista importante per l’uomo: la Luna! Famosa la frase attribuita a Neil Armstrong “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità” (“One small step for a man, one giant leap for mankind”). In questa occasione il mondo intero poté seguire in tempo reale l’allunaggio grazie ai mezzi di comunicazione di massa dell’epoca (ci siamo piuttosto evoluti rispetto alle pitture rupestri) come radio e televisione. Inoltre, foto e filmati furono trasmessi diverse volte dopo la missione, a distanza di mesi e anni, e riutilizzati ancora oggi, disponibili su carta (es. su documenti, libri, riviste) e su supporti digitali. File di diverso formato sono disponibili in rete, come documenti, immagini e video, basta provare a effettuare una ricerca su Internet menzionando parole chiavi come “Neil Armstrong” o “Apollo 11” e si ha accesso a notevoli quantità di informazioni che documentano quella indimenticabile impresa. Questo può essere considerato l’esempio di come l’evoluzione della codifica (digitale) dell’informazione e dell’accesso attraverso la rete abbia permesso di superare i vincoli di di spazio e di tempo. Non abbiamo infatti bisogno di recarci presso una biblioteca o un ente per accedere a quei contenuti, essi sono disponibili sempre, l’importante è avere un dispositivo digitale capace di accedere a Internet.
Ma nel 1969 ci fu un altro avvenimento, quello che verrà ricordato come la nascita di Internet.
Cerchiamo insieme di richiamare il contesto storico. Agli inizi degli anni Sessanta, in piena guerra fredda, vi era una forte competizione sugli avanzamenti tecnologici tra Stati Uniti e Unione Sovietica. In seguito alla messa in orbita dello “Sputnik 1” nel 1957 da parte dell’Unione Sovietica, il primo satellite artificiale in orbita intorno alla Terra, gli Stati Uniti crearono ARPA, l’agenzia incaricata di progettare e svolgere attività di ricerca avanzata con l’intento di evitare di ricevere ulteriori sorprese di natura tecnologica da parte dei rivali (la Russia in primis).
Una delle prime idee fu quella di creare una rete di computer che permettesse a tutti gli utenti dei vari centri di ricerca ed enti appartenenti o sponsorizzati da ARPA di poter condividere e scambiare informazioni e nuovi software più rapidamente e in maniera flessibile. All’epoca le comunicazioni erano basate su una struttura cosiddetta a “commutazione di circuito” (circuit switching). Il circuito era rappresentato da una catena basata su una serie di stazioni (nodi) intermedie collegate l’una all’altra da altrettanti brevi collegamenti. Su tale catena si poggiava il collegamento tra le due stazioni, quella di origine e quella di destinazione (che potevano essere due telefoni o due computer). Per ogni collegamento o trasmissione, il circuito identificato dalla combinazione sequenziale dei vari collegamenti intermedi era temporaneamente riservato e dedicato esclusivamente a quella specifica trasmissione. Questo rappresentava un evidente punto di debolezza in quanto nel momento in cui una delle stazioni intermedie smetteva di funzionare correttamente (o veniva distrutta da un attacco militare) cadeva immediatamente la comunicazione tra sorgente e destinazione. Un altro esempio di quali fossero i limiti di questa impostazione sulla comunicazione potrebbe essere l’esperienza fornita da uno dei padri fondatori di Internet, Robert W. Taylor. Tra il 1965 e il 1969, mentre lavorava su tre progetti finanziati da ARPA svolti in tre differenti istituti, per poter comunicare con ogni istituto utilizzava un terminale differente: uno per ogni connessione. Robert si disse che doveva esistere un modo per comunicare in maniera più agile e poter gestire tutte le connessioni utilizzando un unico terminale, e allo stesso tempo poter far utilizzare la potenza di calcolo disponibile in pochi centri di ricerca a più ricercatori potenzialmente sparsi in tutto il territorio nazionale. Nel 1966 lo stesso Robert Taylor fu nominato direttore dell’“Information Processing Techniques Office” (IPTO) in ARPA dove diresse il progetto ARPANET (il predecessore di INTERNET) sino al 1969.
Agli inizi degli anni Sessanta, l’obiettivo comune a diversi centri di ricerca (non solo all’interno di ARPA o degli Stati Uniti) era da una parte quello di realizzare una rete di comunicazione che fosse capace di sopravvivere ad attacchi nucleari e di mantenere la comunicazione tra le due stazioni trasmittenti (resilienza), dall’altra permettere di avere accesso alle risorse computazionali (a quell’epoca molto scarse) a più utenti contemporaneamente evitando un uso esclusivo.
Per esempio, Paul Baran nel 1959 mentre era dipendente della RAND Corporation (Research ANd Development, un ente americano non profit) propose un progetto di ricerca riguardante la realizzazione di un sistema di comunicazione formato da una rete di stazioni in grado di mantenere le comunicazioni esistenti anche se alcune delle stazioni all’interno del sistema avessero smesso di funzionare. Essendo in piena guerra fredda, la paura e la convinzione di possibili attacchi nucleari era piuttosto alta. Basti pensare al clima che si respirava durante la crisi del 1962, relativa ai missili nucleari stanziati a Cuba da parte dell’Unione Sovietica. Quel progetto portò Paul Baran a sviluppare l’idea della commutazione di pacchetto (packet switching) e della divisione del messaggio in piccoli blocchi (message blocks), passando da un sistema di comunicazione centralizzato a un sistema distribuito. In pratica il messaggio sarebbe stato spezzettato in tanti piccoli blocchi che sarebbero stati trasmessi nella rete e avrebbero seguito percorsi diversi per arrivare a destinazione. Non ci sarebbero stati più dei collegamenti punto-punto ma una maglia di connessioni (molto simile da un punto di vista logico all’attuale infrastruttura di Internet). Infine, i vari blocchi una volta ricevuti dal destinatario sarebbero stati ricombinati opportunamente in modo da ricreare il messaggio originale.
Ma queste idee non nascevano solo in USA. Dall’altra parte dell’oceano, in UK, nel 1965 Donald Watts Davies dipendente del National Physical Laboratory del Regno Unito, sviluppò un progetto simile, in realtà fu lui a utilizzare il concetto di “pacchetto” e non di “blocco” (da cui il nome packet switching). Il “corto-circuito UK-USA” tra le varie attività di ricerca può essere identificato nel momento in cui i lavori di Donald Davies furono presentati da un suo collaboratore a una conferenza a Gatlinburg, in Tennessee, nell’ottobre 1967. A questo evento parteciparono anche gli sviluppatori di ARPANET, il cui intento era quello di trovare un meccanismo che evitasse di dover utilizzare una linea dedicata, riservata a uso esclusivo, per permettere di trasmettere delle informazioni tra ogni coppia di stazioni (trasmittente e ricevente) presenti nella rete. A quanto pare a Gatlinburg nel 1967 trovarono la risposta che stavano cercando.
Da quel momento e negli anni successivi, i ricercatori adottarono e sperimentarono questo nuovo sistema di trasmissione nelle reti dei rispettivi centri di ricerca (ARPA e NPL). Nella seconda metà del 1969, negli Stati Uniti furono stabiliti i primi collegamenti basati su un’architettura a commutazione di pacchetto tra quattro enti (nodi) differenti facenti parte di ARPANET, rispettivamente: University of California, Los Angeles (UCLA); Augmentation Research Center, Stanford Research Institute; University of California, Santa Barbara; University of Utah, Computer Science Department. È interessante ricordare come il primo messaggio trasmesso all’interno di ARPANET basato sull’architettura packet switching conteneva soltanto la sillaba “lo”, inviata da UCLA a Stanford. In realtà doveva contenere la parola “login”, ma, mentre si stava testando per la prima volta il funzionamento della rete, un errore nel codice causò un malfunzionamento nel sistema e la connessione fu interrotta. I programmatori dopo poche ore risolsero il problema, permettendo nuovamente la connessione e l’esecuzione corretta del login. Il 5 dicembre del 1969 la connessione tra i quattro nodi fu completamente stabilita e con questa fu compiuto il primo passo verso la nascita di Internet. Considerando quello che oggi rappresenta Internet per l’umanità, per descrivere l’importanza di quanto realizzato alla fine del 1969 potremmo parafrasare l’affermazione di Neil Armstrong: “Un piccolo passo per un gruppo di uomini, un grande passo per l’umanità”.
Real working stuff: il packet switching alla ricerca della popolarità
Dal 1969 bisogna aspettare circa una decina di anni prima di arrivare a definire nel dettaglio l’architettura utilizzata ancora oggi e su cui si poggia il funzionamento di Internet. Ora il nuovo passo da compiere è diffondere l’utilizzo di questa tecnologia, trasformandola da una passione di pochi (ricercatori) all’interesse di molti (professionisti del settore e aziende operanti nelle telecomunicazioni).
Dal 1969 al 1973 i nodi di ARPANET passarono da 4 a 35, tra cui alcuni centri sponsorizzati da BBN (una società di consulenza fondata da Richard Bolt, Leo Beranek – entrambi professori al MIT – e Robert Newman), RAND Corporation, la NASA, includendo anche una connessione c...