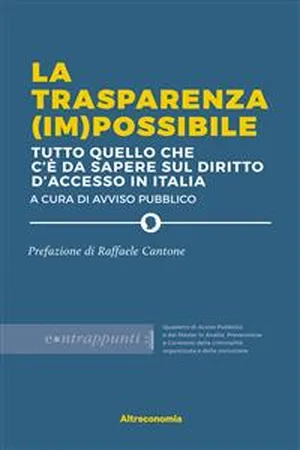
eBook - ePub
La trasparenza (im)possibile
tutto quello che c'è da sapere sul diritto d'accesso in Italia
Avviso Pubblico
This is a test
- Italian
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
La trasparenza (im)possibile
tutto quello che c'è da sapere sul diritto d'accesso in Italia
Avviso Pubblico
Book details
Book preview
Table of contents
Citations
About This Book
Un libro pensato come un vademecum che possa essere d’aiuto sia agli amministratori degli enti locali - chiamati ad applicare una normativa innovativa che li induce a somigliare sempre di più a una vera e propria “casa di vetro” - sia ai cittadini che devono imparare ad utilizzarla in modo corretto per esercitare appieno i loro diritti, per partecipare alla vita della comunità, per controllare l’operato della Pubblica amministrazione e stimolarla così ad operare sempre meglio. In un’espressione, per educarsi a diventare “comunità monitoranti”.
La trasparenza dell’operato della Pubblica amministrazione è un’arma fondamentale per prevenire, contrastare e sconfiggere le mafie e la corruzione.
Frequently asked questions
How do I cancel my subscription?
Can/how do I download books?
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
What is the difference between the pricing plans?
Both plans give you full access to the library and all of Perlego’s features. The only differences are the price and subscription period: With the annual plan you’ll save around 30% compared to 12 months on the monthly plan.
What is Perlego?
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Do you support text-to-speech?
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Is La trasparenza (im)possibile an online PDF/ePUB?
Yes, you can access La trasparenza (im)possibile by Avviso Pubblico in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Politics & International Relations & Public Affairs & Administration. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
1. La trasparenza amministrativa, strumento di prevenzione della corruzione
Nicoletta Parisi Consigliere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; Professore ordinario f.r. di Diritto internazionale
1. Il quadro normativo di riferimento del principio di trasparenza amministrativa
La parola “trasparenza” ha tante declinazioni, una delle quali è collegata all’azione di contrasto alla corruzione. Di quest’ultima si vuole parlare in queste poche pagine, non senza aver prima inquadrato la questione in una dimensione più ampia.
Dell’espressione “trasparenza amministrativa” vi è una prima traccia già nel Codice dei contratti pubblici del 2006 1, e, prima ancora, nella legge n. 241/1990. Quest’ultima ha anzitutto introdotto, nella propria versione originaria, il diritto di accesso cosiddetto documentale (o difensivo) agli atti amministrativi da parte di colui che abbia un interesse diretto, concreto e attuale alla loro conoscibilità in relazione a una connessa situazione giuridicamente tutelata, cioè a dire quando egli abbia una controversia aperta con la pubblica amministrazione e, in omaggio al principio della “parità delle armi”, necessiti di materiale conoscitivo e/o difensivo 2 . La legge è stata esplicitamente integrata da due principi: quello di trasparenza 3 e quello dell’accesso come regola generale per favorire la partecipazione del cittadino e assicurare l’imparzialità della P.A. 4. Tutto ciò è stato codificato infine dal decreto legislativo n. 150/2009 di riforma organica del rapporto di lavoro pubblico 5. Il Codice per l’amministrazione digitale (CAD), con un’integrazione del 2010, istituisce una Banca dati nazionale dei contratti pubblici, considerandola banca dati di interesse strategico nazionale 6. Come si comprende, il legislatore si è espresso fino a questo momento con interventi non sistematici, che si sono venuti via via sedimentando al di fuori di un processo coerente di approccio al tema della trasparenza.
È con la prima legge organica adottata in materia di prevenzione della corruzione (n. 190/2012) che la trasparenza assume le fattezze contemporanee di vero strumento di trasparenza dell’agire pubblico: la “legge Severino” (come questo provvedimento è usualmente denominato) ne ha affermato la vigenza e ha delegato al Governo il riordino dell’intera disciplina 7, avvenuto con il decreto legislativo n. 33/2013. Sui contenuti della disciplina adottata si è poi ritornati con la “Legge Madia”, per mettere a sistema le criticità emerse dalla prima prassi applicativa della giovane disciplina e, soprattutto, per ampliare la portata del principio 8: questi obiettivi sono stati perseguiti dal decreto legislativo n. 97/2016, cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA) su ispirazione della vigente normativa di stampo anglosassone.
Sviluppando l’approccio della normativa adottata in materia di prevenzione della corruzione, il nuovo Codice dei contratti pubblici accoglie il principio di trasparenza, conserva le competenze dell’Osservatorio nato con la legge n. 537/1993 (nonché del suo Casellario) e della Banca dati che raccoglie le informazioni che le devono essere conferite in materia di contratti pubblici 9: il Codice si salda, seppure con qualche problema interpretativo, alla “legge Severino” e alla disciplina generale sulla trasparenza di cui si è appena detto 10, prevedendo una penetrante e diffusa trasparenza delle informazioni (atti, dati e documenti) che riguardano l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici.
Conclusivamente: nell’attuale ordinamento italiano la trasparenza amministrativa è intesa come l’”accessibilità totale dei dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” 11.
È, questa, una dimensione della trasparenza rivoluzionaria rispetto a quella utilizzata nella legge n. 241/1990. Alla prospettiva secondo la quale al singolo - interessato, appunto, direttamente, attualmente e concretamente allo specifico atto amministrativo - si rimette l’iniziativa di fare luce, esclusivamente a proprio vantaggio, su una porzione dell’azione pubblica si sostituisce un’opposta prospettiva: la pubblica amministrazione deve fare luce dal proprio interno verso l’esterno, così che essa - al pari di una “casa di vetro” di cui all’evocazione di Filippo Turati 12 - sia tutta illuminata, appunto trasparente, per chiunque voglia guardarvi dentro, anche con la finalità di rendere pubbliche ad altri (a tutti) le modalità dell’agire pubblico.
Ancora più rivoluzionaria da questa prospettiva è la norma contenuta nella “legge Bonafede” 13, che contiene norme sulla trasparenza dei finanziamenti alla politica da parte di fondazioni e partiti: in un sistema ove è stato abolito il finanziamento pubblico alla politica, si avverte l’esigenza di norme capaci di tracciare i flussi che finanziano le attività politiche e che quindi incidano sulla trasparenza del processo di formazione del consenso di minoranza e maggioranza.
2. La duplice dimensione della trasparenza amministrativa nell’ordinamento italiano
La trasparenza amministrativa è principio indirizzato a garantire “i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino” 14.
La norma spiega che la trasparenza è tanto un fine, quanto un mezzo.
Quanto alla prima delle due dimensioni, la trasparenza amministrativa si configura come un diritto fondamentale della persona a conoscere, dunque anche a informarsi e a essere informato, componenti della libertà di manifestazione del pensiero protetta costituzionalmente 15. Nel caso specifico si tratta del diritto alla conoscibilità dell’azione amministrativa. A tale diritto fondamentale corrisponde l’obbligo in capo a ciascun ente appartenente alla pubblica amministrazione di rendere accessibili le informazioni che la riguardano 16, in adempimento ai principi costituzionali sopra ricordati. Si tratta di un obbligo che costituisce la declinazione di quanto espresso nell’art. 1 della Carta repubblicana, che intende garantire l’esercizio dei diritti di sovranità popolare sul piano sostanziale, non meramente formale. È indubbio, infatti, che solo l’esatta conoscibilità dell’agire amministrativo consente il consapevole esercizio da parte della persona del diritto di partecipazione alla vita pubblica 17. Ma è anche pertinente l’art. 97 della stessa Carta, che impone il rispetto da parte dei pubblici uffici del “buon andamento e [del] l’imparzialità dell’amministrazione”, canoni che, ancora una volta, sono il presupposto per il rispetto del principio della conoscibilità della norma. Ricordo con quale enfasi la Corte costituzionale ha affermato che l’affidamento del cittadino nella “sicurezza giuridica” rappresenta il corollario dello Stato di diritto; sicurezza giuridica conseguibile tramite la trasparenza, che è garanzia di chiarezza, comprensibilità, non equivocità dell’agire di ogni organizzazione sociale. 18
Sulla stessa lunghezza d’onda la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che la conoscibilità della norma è attributo del principio di legalità che sostanzia lo Stato di diritto 19.
La trasparenza, dunque, si connota come la naturale condizione dell’apparato burocratico di uno Stato 20 che esercita la propria funzione nell’esclusivo interesse delle persone che compongono la collettività nazionale.
Su questo snodo si innesta la seconda dimensione della trasparenza: quest’ultima può essere utilizzata come un mezzo per far emergere condotte di cattiva amministrazione relative alla sua organizzazione o alle modalità di impiego delle risorse finanziarie che possono concretarsi tanto in irregolarità quanto in vere e proprie illegalità, amministrativamente o penalmente rilevanti. Tramite la trasparenza - ovvero grazie alla “pressione”
21 dei cittadini sulla P.A. - è infatti possibile assicurare un più corretto funzionamento degli enti pubblici, una loro migliore organizzazione, un più imparziale svolgimento della loro azione complessiva nonché dell’agire di ogni singolo pubblico dipendente 22.
3. Trasparenza e prevenzione della corruzione
A questo punto è necessario spendere due parole sulla corruzione. È addirittura banale osservare che essa fiorisce in situazioni di opacità, fondandosi su di un patto che nessuno dei partecipanti ha interesse a far emergere, siano essi il corrotto, il corruttore, il concussore, il facilitatore, e così via, in funzione delle multiformi sfaccettature che può assumere questa “professione” a seguito della rapida evoluzione strutturale delle condotte di corruzione.
Non a caso si parla della cosiddetta “cifra oscura” della corruzione 23, sulla quale si sono apprestati indicatori soggettivi, basati sulla percezione che di essa ne hanno le persone 24, e si stanno costruendo indicatori oggettivi, fondati sulla misurazione del rischio di corruzione. 25 Questi indicatori sono particolarmente utili in una prospettiva di prevenzione della corruzione, in quanto permettono di applicare misure di vigilanza e presidi nelle aree specificamente a rischio, prima che le pratiche corruttive si avverino 26.
Tornando al discorso dell’opacità che contraddistingue le vicende corruttive: è possibile che questa loro caratteristica contribuisca a una certa sottovalutazione delle conseguenze prodotte dalla corruzione? È possibile, cioè, che la mancanza di un danno immediato di cui qualcuno possa dolersi diminuisca la portata negativa della corruzione agli occhi dei cittadini? Ciò non succede, per esempio, per reati nell’ambito della criminalità organizzata, i quali suscitano un maggior allarme sociale, che proprio a motivo di questo allarme hanno trovato una compatta risposta di contrasto da parte tanto delle istituzioni che dei cittadini.
Il codice penale italiano qualifica la corruzione come “reato contro la pubblica amministrazione”, in una prospettiva che risente di una sistematica certo appartenente ad altra epoca e per questo ora forse non più soddisfacente. Oggi le convenzioni internazionali che la Comunità degli Stati ha predisposto danno conto di una pervasività delle conseguenze negative discendenti dalla condotta di corruzione che va ben oltre i danni portati al sistema pubblico nel suo complesso. La Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 - che, per essere stata stipulata da 186 Parti, manifesta il comune sentire della Comunità internazionale in materia - dà conto della preoccupazione degli Stati circa la “gravità dei problemi posti dalla corruzione e dalla minaccia che essa costituisce per la stabilità e la sicurezza delle società, minando le istituzioni ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto”; dei “nessi esistenti tra la corruzione e altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro”; della ricorrenza di “casi di corruzione relativi a considerevoli quantità di beni, i quali possono rappresentare una parte sostanziale delle risorse degli Stati, e che minacciano la stabilità politica e lo sviluppo sostenibile di tali Stati” 27.
La Convenzione dà conto del fatto che un Paese corrotto cresce meno economicamente, poiché vi sono meno investimenti, e meno innovazione 28: in quello stesso Paese è anche più probabile che vi siano fenomeni di nepotismo e clientelismo.
La Convenzione riconosce anche che un Paese corrotto è più spesso retto da istituzioni fragili, perché le condotte di corruzione diffusa e pervasiva sono capaci di rompere il patto di fiducia fra governo e cittadini 29.
La Convenzione dà conto del fatto che un Paese corrotto si fonda sulla violazione dei diritti fondamentali della persona, in primo luogo del diritto a non essere discriminato, dal momento che la condotta di corruzione consiste proprio nel far prevalere il sodalizio corruttivo sul fondamentale principio di eguaglianza.
Tramite la disciplina della trasparenza amministrativa la legislazione italiana sulla prevenzione della corruzione scommette investendo sulla responsabilizzazione di persone ed enti di fronte alla consapevolezza dei danni prodotti dalle condotte di corruzione. Si vuole che il rifiuto della corruzione non sia frutto di una “ricetta” calata dall’alto, dalle istituzioni di governo alle quali i cittadini abbiano delegato la funzione del contrasto alla corruzione, ma che sia manifestazione di una scelta, di un bisogno espresso dalle persone, determinate a vivere in un ambiente integro.
4. La trasparenza come strumento di attuazione di un controllo sociale diffuso sulla pubblica amministrazione
L’operazione di responsabilizzazione avviata investe, anzitutto, la pubblica amministrazione nel suo complesso 30: si vuole che ciascuno degli enti di essa scelga, nel rispetto delle indicazioni legislative, come attuare sul piano amministrativo il proprio modo di essere trasparente. Ma essa opera anche nei confronti della singola persona, titolare del diritto alla conoscibilità dell’azione pubblica. Tale diritto è sostanziato da strumenti che tendono a ridurre l’opacità dell’agire pubblico, quali sono il diritto della persona a esercitare l’accesso civico e il diritto del lavoratore a segnalare condotte illecite in condizioni di sicurezza, tutto ciò nell’ambito di una politica cosiddetta di open government.
Le ragioni per le quali queste iniziative sono in grado di concorrere all’azione di prevenzione della corruzione sono abbastanza evidenti: gli istituti e le misure richiamati sono indirizzati a promuovere e a favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione della “cosa” pubblica tramite appunto l’accessibilità totale ad essa. Sono, questi istituti, indirizzati a porre nelle mani degli amministrati le leve del controllo sul rispetto di regole che sostanziano i principi di portata costituzionale detti. Essi contribuiscono, inoltre, a dare adempimento all’esigenza (anch’essa costituzionalmente sostenuta) di coordinamento di dati pubblici sul piano informativo, statistico e informatico, a propria volta strumentale all’esercizio del controllo sull’agire pubblico.
4.1 L’accesso civico: accesso semplice e accesso generalizzato
Si è detto che l’obbligo di trasparenza stabilito a carico della pubblica amministrazione ha una doppia dimensione 31. Tale obbligo si riflette nelle due diverse forme di accesso civico, quello semplice e quello generalizzato 32.
Anzitutto, si fa obbligo agli enti pubblici 33 di dare pubblicità -entro la propria home page, nel sito denominato “Amministrazione trasparente”- di certi specifici dati, documenti e informazioni individuati dalla legge 34 senza con ciò impedire un più elevato livello di trasparenza tramite la pubblicazione di ulteriore documentazione. Alla mancata pubblicazione di quanto stabilito come obbligatorio corrisponde il diritto di ciascuna persona a richiederne l’accesso e dunque a ottenerne la pubblicazione 35.
Da un punto di vista concettuale questa modalità di accesso risulta certamente essere l’evoluzione del diritto di accesso detto documentale o difensivo, introdotto dal già ricordato art. 22 della legge n. 241/1990 36. Ne condivide infatti la funzione: quella di consentire la verifica da parte del cittadino del contenuto del documento 37. Tuttavia, i due istituti coprono situazioni non coincidenti 38. Mentre infatti l’accesso documentale è sostenuto dalla titolarità di un interesse diretto collegato a una situazione giuridicamente rilevante per chi lo esercita, l’accesso civico semplice riguarda l’esercizio del diritto individuale di accedere alle informazioni, ai documenti e ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge 39.
Rispetto a ogni altro documento, informazione o dato di non obbligatoria pubblicazione la persona può esercitare il diritto di cosiddetto accesso civico generalizzato: la legge fa obbligo alla pubblica amministrazione di conservare tutta la propria documentazione (dati, informazioni, atti) e tenerla a disposizione di chi senza motivazione alcuna ne faccia richiesta 40. Come già anticipato a questa modalità di accesso si dà coerentemente il nome di FOIA, per indicare che essa concreta il diritto ...