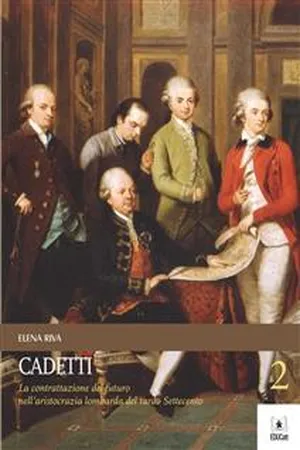![]()
— 1 —
Cadetti, un mosaico di vite parallele
My birth was unpropitious. I came into the world, branded and denounced as a vagant; for I was a younger son of a family, so proud of their antiquity, that even gout and mortgaged estates were traced, many generations back, on the genealogical tree, as ancient heir-looms of aristocratic origin, and therefore reverenced. In such a house a younger son was like the cub of a felon-wolf in good King Edgar’s days, when a price was set upon his head. There have been laws compelling parents to destroy their puny offsprings; and a Spartan mother might have exclimed with Otello, while extinguishing the life of her yet uncounscious infant, “I that am cruel, am yet merciful, I would not have thee linger in thy pain; which was just and merciful, in comparison with the atrocious law of primogeniture1.
Con questo incipit accusatorio che richiamava la sua condizione di cadetto, John Edward Trelawny introduceva la sua autobiografia romanzata Adventures of a younger son. Novelliere e amico fraterno di Lord Byron e Shelley, conosciuti entrambi a Pisa nel 1822, egli pubblicò quest’opera nel 1831. E nonostante la Rivoluzione francese e il Codice civile napoleonico avessero già inferto duri colpi al modello tradizionale della famiglia di antico regime, le sue parole testimoniavano la permanenza di uno stato di ‘minorità sociale’ per gli younger sons delle famiglie aristocratiche. Inoltre non mancavano di sottolineare, ancora a metà Ottocento, quanto il destino di un cadetto fosse considerato sfortunato già al momento della nascita per famiglie in cui persino la gotta e le proprietà ipotecate erano venerate come ‘cimeli’ di casa, mentre un figlio cadetto era da considerarsi, metaforicamente parlando, quasi come un ‘criminale’. Degna di nota appare anche la sua tremenda accusa ai codici del sistema successorio: nella storia c’erano state leggi – annotava – che avevano costretto i genitori ad annientare i figli più deboli, ma niente di paragonabile a quelle ‘atroci’ della primogenitura.
Sebbene l’uso di metafore di impatto fosse funzionale a una autobiografia romanzata, non vi è dubbio che Trelawney riflettesse un comune sentire sulla condizione di inferiorità dei cadetti delle famiglie nobili, nonostante le leggi in molti stati avessero già abolito o regolato le pratiche successorie2.
Come si può facilmente intuire da queste righe introduttive, i cadetti e, nello specifico, quelli di alcune famiglie aristocratiche lombarde del secondo Settecento rappresentano l’oggetto di questo volume, intesi nel loro ruolo di agenti di mobilità sociale e di negoziatori di strategie familiari. Giovani che vissero nel contesto storico e politico della Lombardia austriaca messo a ferro e fuoco dalle riforme di Maria Teresa d’Austria e del figlio Giuseppe II. Le storie familiari qui narrate vogliono semplicemente verificare in che misura i cambiamenti culturali e politici, peculiari di un’età di transizione fondamentale come quella a cavallo tra Sette e Ottocento, generarono una pluralità di comportamenti e di scelte personali nelle élites proprio a partire dai cadetti. Il mosaico di legami familiari che emerge dalle vicende qui narrate interagì con un modello di famiglia tradizionale messo in discussione e in profonda crisi non solo da scelte di vita personali radicali, ma anche dal mutato contesto storico in cui i protagonisti vissero.
L’intento è quindi quello di raccontare dei fatti e le modalità con cui questi fatti vennero percepiti e vissuti nel momento stesso in cui accaddero, allo scopo di comprendere cosa significasse essere figli, primogeniti e cadetti, padri, zii e fratelli in alcune famiglie aristocratiche del secondo Settecento lombardo, colpito dalla tempesta delle riforme asburgiche.
Le storie familiari qui tratteggiate si collocano dentro le dinamiche di fratellanza e conflittualità tipiche della società aristocratica di antico regime, dove le complesse regole di funzionamento della solidarietà, spesso intesa solo in senso patrimoniale, e la molteplicità degli interessi da salvaguardare riuscirono sovente a generare conflitti familiari non sempre sanabili che ebbero spesso tra i protagonisti los secundones, per dirla alla spagnola, oggetto ancora abbastanza ignorato dalla ormai abbondante se non strabordante storiografia sulla nobiltà di antico regime.
Il mio interesse per i cadetti viene da lontano, da un primo studio su uno dei protagonisti qui raccontati, Ercole Belgiojoso3, proseguito poi con un saggio dedicato a Paolo Greppi4 e culminato con una monografia su Carlo Verri5, fratello dei ben più celebri Pietro e Alessandro, tutti personaggi, nella sostanza, appartenenti al medesimo milieu socio culturale della Lombardia austriaca. In questi studi avevo sviluppato una riflessione sulla complessità della società del tardo illuminismo, figlia di una varietà di atteggiamenti e di logiche che trovavano proprio nella storia sociale della famiglia una delle sue principali espressioni, più idonea di altre a valutarne la tenuta anche sul lungo periodo. Il lavoro su Carlo Verri, in particolare, tentava di dimostrare come proprio il fatto di essere un cadetto, meno responsabile dunque nei confronti della tradizione e dell’onore familiare rispetto al primogenito Pietro, gli aveva consentito di compiere scelte di vera rottura socio-culturale, ancora rare nella società del tempo.
Questi lavori hanno rappresentato un punto di partenza per una riflessione che è proseguita nel tempo e che si è arricchita, oltre che di nuova documentazione, anche delle suggestioni offerte dall’abbondante storiografia prodotta negli anni sulla storia dell’aristocrazia e della famiglia. Le pagine che seguono, quindi, intendono aprire altre finestre sul variegato mosaico di strategie e reti familiari di una parte delle élites lombarde, evidenziando soprattutto la capacità dei singoli, in particolare dei cadetti, di aprire una serrata negoziazione del loro futuro con la tradizione familiare in grado, a seconda dei casi, di rispettarla, consolidarla e tramandarla ai posteri, oppure di demolirla. Scelte di vita personali, però, che non si traducono ancora in un comportamento collettivo di tipo generazionale6, come succederà nell’età successiva, ma che rilevano piuttosto quanto la diversità, le permanenze e i mutamenti, che sempre coesistono dentro un milieu sociale, in alcuni particolari frangenti storici diventino l’immagine di una maggiore complessità organizzativa della società che, nel caso della Lombardia austriaca, trova la sua espressione in un nuovo rapporto con la sovranità imposto dalle riforme.
Le famiglie prese in considerazione in questo volume appartengono tutte all’aristocrazia milanese. Due di loro, i Barbiano di Belgiojoso7 e i Serbelloni, fanno parte del patriziato cittadino da almeno tre secoli, la terza, invece, quella dei Greppi, è originaria di Bergamo e la sua nobilitazione è molto più recente, in quanto Antonio Greppi, il capostipite del clan familiare, viene inserito nel catalogo dei nobili nel 1774 e riceve il titolo di conte nel 1778 a Vienna.
Si tratta di tre casate che, pur nella diversità delle loro storie, evidenziano così tanti tratti in comune da poterle collocare sullo stesso piano interpretativo. In primis tutte manifestano la loro fedeltà agli Asburgo d’Austria, ampiamente ricambiata dai sovrani in termini di distinzione e di onore e utile. In secondo luogo la loro rete di relazioni internazionali, costruita nel tempo e in gran parte proprio dai cadetti, le colloca in una dimensione di sociabilità, non solo aristocratica, di livello europeo e le trasforma in un interessante oggetto di analisi. Inoltre, le scelte di vita dei singoli protagonisti vanno inquadrate in una cornice storica particolare, ovvero i decenni successivi alla Pace di Aquisgrana e alla Guerra dei sette anni, quando una lunga e duratura pace e lo sviluppo della cultura dei Lumi facilitarono un’attività riformista senza precedenti nei domini della Monarchia asburgica che, libera dalle emergenze imposte dallo stato di guerra permanente vissuto nella prima metà del secolo, mutò radicalmente il tradizionale rapporto tra principe e ceti e, di conseguenza, anche le strategie di carriera dei membri dell’aristocrazia che, in qualche modo, dovettero dare prova di sapersi reinventare all’interno di società nuova, anche se ciò non avvenne sempre con successo.
La riflessione su almeno due di queste famiglie (Belgiojoso e Serbelloni) copre l’arco temporale di tutto il Settecento e prende in considerazione a livello comparativo ‘generazioni’ diverse di cadetti, allo scopo di meglio sottolineare la portata di alcune scelte di vita personali sulle dinamiche familiari e sul contesto socio-culturale in cui esse si svilupparono. Non è possibile, però, applicare la medesima analisi di lungo periodo al caso dei Greppi perché, come ho ribadito poc’anzi, si tratta di una famiglia di più recente nobilitazione, la quale, però, rappresenta una perfetta sintesi di quel connubio tra tradizione e innovazione espresso dalla cultura europea del tardo Settecento.
1. Il gioco di squadra dei cadetti
Nel corso degli ultimi decenni la storia della parentela e della famiglia è stata sviscerata in molti dei suoi aspetti, tanto da rendere difficile dare conto di tutta la letteratura, ormai europea, prodotta in materia8. Tuttavia nelle ricostruzioni delle storie familiari che hanno arricchito l’ingente bibliografia sulla storia della famiglia, i cadetti compaiono spesso, ma come ‘attori’ secondari di strategie familiari più improntate all’analisi del ruolo dei primogeniti in rapporto all’autorità parentale. Sono stati certamente gli studi sulla trasmissione della ricchezza in antico regime a riportare in auge la categoria dei cadetti individuati più che altro come antagonisti dei primogeniti9. In queste pagine, però, saranno lasciate sullo sfondo le modalità con cui i sistemi successori condizionavano anche i rapporti familiari10, in quanto già ben analizzate dagli studiosi di demografia o dagli storici del diritto come espressione di modelli europei di lunga durata ormai piuttosto conosciuti11. Maggiore attenzione sarà invece dedicata ad altre dimensioni che i documenti utilizzati, in particolare i carteggi familiari, aiutano a far emergere, come ad esempio il ‘gioco di squadra’12 impostato dai cadetti dentro la loro famiglia d’origine, spesso determinante per il suo successo. Favoriti infatti da una maggiore libertà di movimento grazie al celibato, alcuni di loro, in particolare i militari, costruirono un patrimonio di relazioni dal valore strategico, politico e economico straordinario, da trasmettere in eredità anche alle generazioni successive, e sulla cui importanza non si riflette mai abbastanza. Il caso dei Belgiojoso, dei Serbelloni e dei Greppi è in tal senso eccezionale: poche altre famiglie nella Lombardia austriaca poterono vantare una rete di relazioni sociali di simile portata che, consolidatasi nel tempo, aiutò i membri della casata nella contrattazione del loro futuro, lasciando in eredità ‘un capitale’ di relazioni con cui perpetuarne la distinzione e potenziarne la tradizione nel tempo.
Alcuni dei cadetti qui presi in esame, infatti, fecero la fortuna delle loro famiglie e consolidarono quella che potremmo definire una sorta di vocazione familiare13 quale fu ad esempio quella militare o quella finanziaria, che consentì alle casate di scalare gli alti vertici del prestigio sociale e di superare indenni tutti i cambiamenti dinastici e le più delicate congiunture storiche14. Il tema di una carriera militare più o meno di successo è centrale in molti dei profili biografici dei cadetti qui narrati proprio perché tale scelta di vita rientrava nel solco di una plurisecolare tradizione di famiglia. Il caso dei Belgiojoso e dei Serbelloni lo dimostra in modo evidente e nel panorama delle famiglie milanesi, esse non furono le uniche a poter essere annoverate tra le ‘dinastie militari’, come dimostra uno dei pochi casi studiati come quello del marchese Antonio Giorgio Clerici15. Infatti i cadetti Ludovico Belgiojoso (1728-1801) e Giovanni Battista Serbelloni (1697-1778), grazie al prestigio conquistato sia sui campi di battaglia che nella loro attività diplomatica, consolidarono enormemente il prestigio della loro casata per tutto il XVIII secolo, riuscendo a guadagnarsi un posto di rilievo nel servizio del sovrano. Qualche anno dopo, come si vedrà, di tutt’altra natura furono invece i percorsi individuali dei nipoti ...