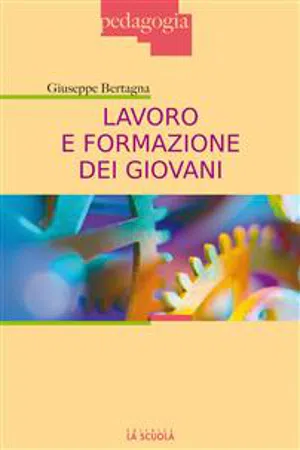
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Lavoro e formazione dei giovani
About this book
Un volume che pone in luce uno strano problema che si trova ad affrontare l'Italia: quasi due milioni e mezzo di giovani tra i 16 e 1 34 anni non studiano, non hanno un lavoro e nemmeno lo cercano. D'altro canto ci sono moltissime offerte di posti che nessuno vuole più ricoprire.
In queste pagine si analizza il fenomeno non solo dal punto di vista sociologico, ma soprattutto da quello formativo e culturale.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
At the moment all of our mobile-responsive ePub books are available to download via the app. Most of our PDFs are also available to download and we're working on making the final remaining ones downloadable now. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Lavoro e formazione dei giovani by Giuseppe Bertagna in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Business & Workplace Culture. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
Note
Introduzione
1 Questo il purtroppo ancora adesso futuristico «obiettivo strategico» assegnatosi dal Consiglio Europeo a Lisbona, il 23-24 marzo 2000.
2 T. Veblen, La teoria della classe agiata (1899), tr. it., Ed. di Comunità, Milano 1999.
3 A. Smith, La ricchezza delle nazioni (1776), tr. it., Utet, Torino 1975, libro IV, cap. VII e parti II e III.
4 C. Cattaneo, Del pensiero come principio d’economia pubblica, 1861. Carlo Lacaita ha raccolto tutti gli scritti di Cattaneo sull’innovazione in un testo significativamenteintitolato L’innovazione come leva dello sviluppo, Le Monnier, Firenze 2001.
5Lettera di Hegel a Niethammer del 28 ottobre 1808, in G. W. F. Hegel, Epistolario, tr. it. a cura di P. Manganaro, Guida, Napoli 1983, vol. I, p. 375.
6 G. W. F. Hegel, Aforismi jenensi (1803-1806), tr. it. a cura di C. Vittone, Feltrinelli, Milano 1981, p. 76, fr. 80.
7 I. Calvino, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1993, p. 83.
8 Poche intuizioni dell’antropologia, per esempio, sono state importanti quanto l’idea cardine del testo di C. Lévi Strauss, Il crudo e il cotto (1964), tr. it., Il Saggiatore, Milano 1974, secondo la quale “buone da mangiare” sono solo le cose “buone da pensare”.
Il lavoro e la tradizione ebraico-cristiana
1 Agostino di Ippona, Confessioni XI, 10, 12
2 Ibi, 12, 14.
3 Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 12.
4 K. Wojtyla, Perché l’uomo. Scritti inediti di antropologia e filosofia, Mondadori, Milano 1995.
5 Agostino d’Ippona, I monaci e il lavoro, Citta Nuova, Roma 1984, § 25.
6 San Benedetto, La Regola, San Paolo, Cinisello Balsamo 2001, § 48, pp. 88-91.
7 Benedetto XVI, Semplicità e sobrietà per costruire una società solidale, Udienza Generale, Piazza San Pietro, mercoledì, 27 maggio 2009, in «L’Osservatore romano», 28 maggio 2009, p. 1.
8 L. Bruni - A. Smerilli, Benedetta economia. Benedetto da Norcia e Francesco d’Assisinella storia economia europea, Città Nuova, Roma 2008.
9 S. Zamagni - L. Bruni, Lezioni di economia civile, Vita e Pensiero, Milano 2003; Id., Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica, il Mulino, Bologna 2004.
10 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae (1259-1273), Parte I, q. 76, art. 5 (Editiones Paulinae, Roma 1963, pp. 358-359). Con le mani, egli continua, l’uomo può apprestare strumenti di fogge infinite e per effetti infiniti (instrumenta infinitorum modorum, et ad infinitos effectus). Il brano commenta Aristotele che (De anima, III, 8, 432 a) definiva a sua volta «la mano (…) strumento degli strumenti».
11 G. Bruno, Spaccio de la bestia trionfante (1587), Rizzoli, Milano 1985, pp. 226-227 (III Dialogo).
12 J. Locke, Due trattati sul governo (1690), tr. it. parziale del secondo con il titolo Trattato sul governo, a cura di L. Formigari, Editori Riuniti, Roma 1984, p. 71.
13 Cfr. la distinzione tra possesso («frutto della forza») e proprietà (diritto naturale), frutto del lavoro personale in J.-J. Rousseau, Contratto sociale, I, in Opere, Mondadori, Milano 2010, p. 29. «Il fondamento del patto sociale è la proprietà, e la sua prima condizione è che a ciascuno sia assicurato il pacifico godimento di ciò che gli appartiene» (J.-J. Rousseau, Discorso sull’economia politica [1754], tr. it., in Scritti politici, a cura di P. Alatri, Utet, Torino 1970, p. 402). E ciò che gli appartiene è e deve essere esclusivamente, oltre a quanto attiene la sua libertà, risultato del suo lavoro. Sul tema, cfr. R. Wokler, Rousseau (1995), tr. it., il Mulino, Bologna 2001, pp. 75 e ss.
14 I. Kant, Antropologia pragmatica (17981, 18002 ), tr. it., Laterza, Bari 1985, § 16, p. 38.
15 S. Weil, La prima radice (1949), tr. it. di F. Fortini, Ed. Se, Milano 1990, p. 268.
16 A. Cuneo, Il maestro di Garamond (2002), tr. it. di G. Amaducci, Sironi ed., Milano 2010.
17 «Largo campo di filosofare a gl’intelletti specolativi parmi che porga la frequente pratica del famoso arsenale di voi, Signori Veneziani, ed in particolare in quella parteche mecanica si domanda; atteso che quivi ogni sorte di strumento e di machina vien continuamente posta da numero grande d’artefici, tra i quali, e per l’osservazioni fatte dai loro antecessori, e per quelle che di propria avvertenza vanno continuamente per se stessi facendo, è forza che ve ne siano de i peritissimi e di finissimo discorso» (G. Galilei, Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, in Opere, Barbera, Firenze 1929, vol. VIII, Giornata I, Salviati).
18 Come già ricordava Adamo Smith, infatti, «gran parte delle macchine usate nelle manifatture in cui il lavoro è più suddiviso furono originariamente invenzione di operai comuni (A. Smith, La ricchezza delle nazioni…, cit., libro I, cap. I, pp. 86).
19 Cfr. il paragrafo 4.4 del capitolo IV.
20 G. Gilder, Lo spirito dell’impresa. Il ruolo dell’imprenditore nello sviluppo economico e nel benessere delle nazioni (1984), tr. it. di G. Salinas, Longanesi, Milano 1985, p. 86 passim.
21 F. Nietzsche, Genealogia della morale. Uno scritto polemico (1887), in Opere a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1965-1967, VI, 2: Al di là del bene e del male. Genealogia della morale, Milano 1968, III, 1-3.
22 S. de Beauvoir, Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano 1994.
23 M. F Sciacca, L’ora di Cristo, Marzorati, Milano 19732, pp. 232 e ss.
24 Su queste questioni e sulla specificità del lavoro come e in quanto téchne rimando al mio Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell’educazione, La Scuola, Brescia 2010, cap. IV, pp. 133-171.
25 S. Weil, La condizione operaia (1951), tr. it. di F. Fortini, Ed. di Comunità, Milano 1980, p. 276.
26 H. Arendt, Vita activa. La condizione umana (1958), tr. it. di S. Finzi, intr. di A. Dal Lago, Bompiani, Milano 1988, p. 85.
27 Nel senso di espressa, pervenuta a pienezza nel suo essere, tutta, quella cosa che è (Tommaso d’Aquino, De Veritate q 21 a 1, c). Consummata, insomma, è l’esatto contrario del significato moderno di «consumare» che è usato, invece, per svanire, nientificare, “slisire”.
28 A. Solzenicyn, Una giornata di Ivàn Denìsovic (1962), tr. it., Newton Compton, Roma 1993, pp. 56 e ss.
29 A. Solzenicyn, Dialogo con il futuro. Discorsi e interviste (1975), tr. it., La Casa di Matriona, Milano 1977, pp. 66-67.
30 S. Weil, La prima radice…, cit., p. 261.
31 M. Scheler, Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei valori. Nuovo tentativo di fondazione di un personalismo etico (1913-1916), tr. it., a cura di G. Caronello, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, soprattutto p. 590 e ss.
La Costituzione, il lavoro, la scuola
1 A.C. Jemolo, Riflessioni critiche sulla carta costituzionale (1965), in Questa Repubblica dalla contestazione all’assassinio di Aldo Moro, introduzione di G. Spadolini, Le Monnier, Firenze 1978, p. 3.
2 H. Arendt, Vita activa…, cit., p.153 e ss.
3 S. Hessen, I fondamenti filosofici della pedagogia (1923), tr. it. Armando, Roma 1962, p. 138; da questa parola, letteralmente "lavoro forzato", Karel Čapek, scrittore ceco, ha plasmato per la prima volta nel suo dramma R.U.R. (Rossum's Universal Robots), del 1920, la parola robot. Per gli altri significati dei termini citati e per la loro contestualizzazione cfr. F. Totaro, Lavoro, in E. Berti - G. Campanini (ed.), Dizionario delle idee politiche, Ave, Roma 1993, pp. 427 e ss.
4 S. Weil, La condizione operaia…, cit., p. 52, p. 47, p. 183, p. 36.
5 Questa è la proposta contenuta in T. Moro, Utopia (1516), tr. it. di G. Zuanazzi, La Scuola, Brescia 1998, p. 128: «tre prima di mezzogiorno, dopo le quali vanno apranzo, e quando, dopo pranzo hanno riposato due ore, ne dedicano altre tre al lavoro».
6 T. Campanella, Città del sole (1602, ma pubblicata nel 1623), tr. it., Adelphi, Milano 1995, p. 65. Della stessa idea di Campanella sarà Bertrand Russell, Elogio dell’ozio (1935), in Il diritto all’ozio, tr. it., Ed. Olivares, Roma 1974.
7 P. Lafargue, Il diritto all’ozio (1880), tr. it., nel volume dello stesso titolo, Ed. Olivares. Della stessa idea V.I. Lenin, Opere, tr. it., Ed. Riuniti, Roma 1966, vol. XX, p. 143 (da un articolo pubblicato il 13 marzo 1914).
8 Questa è la proposta che J.M. Keynes fece a Madrid, nel 1930, in una sua conferenza intitolata Prospettive economiche per i nostri nipoti, tradotta nel volume La fine del lasserfaire e altri scritti, Bollati Boringhieri, Torino 1991.
9 Questa è la proposta di Travailler deux heures par jour firmato dalla sigla collettiva Adret e pubblicato in Francia nel 1977.
10 «Guadagnarsi da vivere lavorando, ma lavorando sempre meno e ricevendo (…) la parte della ricchezza crescente prodotta socialmente», scrive A. Gorz (Metamorfosi del lavoro [1988], tr. it., Bollati Boringhieri, Torino 1992, p. 104). Il tempo così liberato renderebbe possibile «l’autorealizzazione (…) attraverso la cooperazione volontaria, le attività scientifiche, artistiche, educative, politiche, ecc.» (ibidem). La sfera degli svaghi così ottenuta non sarebbe semplicemente «destinata al riposo o alla ricostituzione delle energie dissipate», ma diventerebbe «tempo essenziale e ragione di vita, rispetto alla quale l’occupazione venga ridotta a un ruolo strumentale» (p. 109). Al là degli adattamenti del caso, il nucleo di questo paradigma ideologico, a partire da V. Forrester, L’orrore economico (1974), tr. it., Ponte alle Grazie, Firenze 1976, si ritrova in molti altri testi; per esempio, in D. De Masi, Sviluppo senza lavoro, Ed. del Lavoro, Roma 1994; Id., L’ozio creativo, Ediesse, Roma 1997; Id., Il futuro del lavoro. Fatica e ozio nella società postindustriale, Rizzoli, Milano 1999; A. Gorz, Addio al proletariato (1980), tr. it., Ed. del Lavoro, Roma 1982; Id., La strada del paradiso, ibidem 1983; Id., Miserie del presente, ricchezze del possibile (1997), tr. it., Manifestolibri, Roma 1998; G. Aznar, Lavorare meno per lavorare tutti, tr. it., Bollati Boringhieri, Torino 1993; D. Méda, Società senza lavoro, tr. it., Feltrinelli, Milano 1995; G. Mazzetti, Quel pane da spartire. Teoria generale della necessità di redistribuire il lavoro, Bollati Boringhieri, Torino 1997; Id., Tempo di lavoro e forme di vita, Manifestolibri, Roma 1999.
11 Alla luce degli articoli 5 e 114 della nostra carta fondamentale «costituiscono» la Repubblica, oltre allo Stato, le...
Table of contents
- Copertina
- Colophon
- Introduzione
- Il lavoro e la tradizione ebraico-cristiana
- La Costituzione, il lavoro, la scuola
- L’apprendistato come opportunità formativa
- Crisi economica e riforma del pensiero
- I giovani tra studio, disoccupazione e lavoro
- La fine del modello separatista
- Conclusioni
- Indice dei nomi
- Sommario
- Note