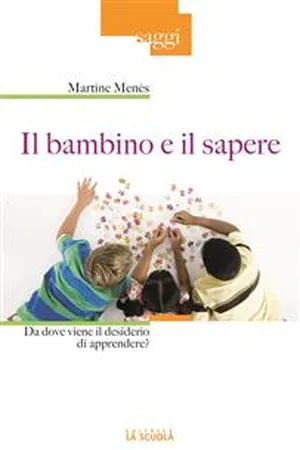![]()
Capitolo quarto
Destini della spinta verso il sapere
Il periodo dell’investigazione sessuale e delle costruzioni intellettuali che accompagnano le teorie sessuali infantili e il complesso di castrazione, centro dell’Edipo, subisce una repressione progressiva sotto l’effetto dell’interiorizzazione progressiva degli interdetti. Il piccolo soggetto esce dalla fase edipica con questa duplice capacità: rinunciare a fondersi nell’altro, rappresentato dalla madre, da cui si aspetterebbe tutto, compreso l’impossibile, e accedere da allora in poi ad altre forme di soddisfacimento e ad altri interessi.
Questo periodo termina con una forte spinta alla rimozione, come scrive Freud in Tre saggi sulla teoria sessuale1. La rimozione è una difesa necessaria, un mezzo di regolazione della vita psichica, che permette di dimenticare le aspirazioni bandite, una volte che il soggetto abbia ammesso e integrato il loro divieto. È un’operazione attraverso cui il soggetto cerca di mantenere o di respingere dall’inconscio rappresentazioni, idee, fantasie, desideri che il conscio non può più accettare. Alla fine del periodo edipico, la rimozione orienterà la meta originale della soddisfazione verso degli investimenti oggettivi e respingerà dal conscio le fissazioni «amorose» sui genitori. Questo meccanismo è indispensabile per la umanizzazione del soggetto, permette di entrare nei legami sociali ordinari e di accedere alle regole del gioco culturale. Ovviamente, lo spostamento pulsionale non è mai totale, rimangono dei resti di soddisfazione del corpo, che riappariranno nel modo di mangiare, nel rapporto con il controllo sfinterico, nell’importanza dello sguardo e dell’ascolto. Inoltre com’è ovvio l’oblio non è mai massiccio e definitivo, è soggetto a dei «ritorni di rimosso» in cui i contenuti censurati giudicati indesiderabili riappaiono, ad esempio nei sogni, nei flash di memoria che si producono in situazioni emotivamente cariche, o in qualche altra occasione, come la sensazione di déjà vu.
Certo, il desiderio, in particolare il desiderio di sapere, sotto l’azione della rimozione perde la sua potenza, dato che il pensiero non si muove più in libertà, ma sotto un controllo interno. Questo faceva rimpiangere a Freud il «contrasto intristente che esiste tra la raggiante intelligenza di un bambino sano e la debolezza mentale di un adulto medio»2. Ma la vera difficoltà è che lo slancio verso il sapere rischia di essere ostacolato da alcuni affetti: angoscia, inibizione, o da alcuni comportamenti sintomatici legati ai fallimenti della rimozione. Quando la forza pulsionale supera le capacità del bambino di mobilitarla verso gli oggetti esterni, un «resto» inassimilabile di libido si accumula e intralcia gli apprendimenti. Questo potrebbe tradursi in inibizione, quando il movimento che domina è la protezione nei confronti dei ritorni di rimosso inammissibili per la coscienza, diciamo «morale» del soggetto; in angoscia, quando i conflitti inconsci non sono sufficientemente rimossi e restano attivi nella psiche; infine in sintomi, formazioni di compromesso che traducono i conflitti psichici interni in comportamenti.
Ma lo slancio verso il sapere si dirigerà anche, o soprattutto, a seconda dei soggetti, verso degli interessi e si svilupperà, si sublimerà, in ambiti generali, culturalmente ammessi e valorizzati.
1. Dalla curiosità mal posta alla curiosità sublimata
La sublimazione è un recupero dell’energia libidica «civilizzata», trasformata dall’interiorizzazione dei limiti che trova il suo apogeo durante il periodo detto edipico. Essa consiste nel sostituire agli scopi originari delle pulsioni, degli scopi secondari come le attività intellettuali, artistiche, creative, e in particolare nei bambini, gli apprendimenti. L’energia libidica che alimenta le pulsioni, a cominciare dalla voracità orale, poi la ferocità anale fino alla vigilanza dello sguardo e dell’ascolto – tutti sanno che il bambino si arrangia per vedere e sentire tutto quello che gli interessa – non scompare. È preservata e rimane attiva grazie alla sostituzione degli obiettivi mirati dalle pulsioni. La sublimazione permette quindi una soddisfazione pulsionale canalizzando l’energia verso degli obiettivi culturalmente valorizzati e valorizzanti.
La sublimazione introduce il periodo di latenza. Estendendosi dai 5-6 anni fino alla prepubertà, ricopre tutta la durata della scuola primaria, nel corso della quale si fanno gli apprendimenti di base. Durante il relativo silenzio delle pulsioni di questo periodo, una gran parte dell’energia del bambino può essere disponibile per l’attenzione e la concentrazione necessarie alla duttilità cognitiva imposta dagli apprendimenti fondamentali. Si potrà così spostare su ambiti diversi da quelli che mobilitavano la curiosità infantile: dall’intimo verso l’esterno; da una volontà di sapere primario ad un desiderio di apprendere; dal desiderio di possedere l’altro a quello di possedere un sapere; da un sapere sul desiderio a un desiderio sui saperi. Gli oggetti del sapere collettivo proprio di una data cultura si sostituiranno agli oggetti delle teorie sessuali infantili. La sublimazione permette, in sintesi, un acquietamento e il passaggio dalla curiosità sessuale verso un uso esteso della capacità di pensare e di creare.
Durante il periodo di latenza, l’immaginazione è al potere. Aspettando di essere grande, il bambino costruisce la sua mitologia personale, si identifica ad un eroe, vive delle avventure da cui esce trionfante. Questa intensa attività immaginativa è la testimonianza di una spinta verso l’avvenire, di una proiezione verso il momento dell’uscita definitiva dalla dipendenza infantile. La pubertà vi metterà una fine che obbligherà il giovane soggetto a trovare un nuovo equilibrio psichico.
La povertà o l’assenza di questi copioni immaginari possono essere il segno esteriore di una inibizione del pensiero. È per questo che spesso ai bambini vengono proposte attività che favoriscono l’espressione: modellatura, teatro, disegno, che possono aiutare il processo di sublimazione. Potremmo dire che la sublimazione è la via regia del pensiero.
2. L’inibizione, la depressione
Gli adulti non sempre si preoccupano di quei bambini troppo buoni, riservati, che si fanno scudo della loro sedicente incapacità, dove pensano che nessuno verrà a cercarli. Spesso, i soli elementi individuabili o di cui si lamentano sono somatici: stanchezza, mal di testa, ecc. Si dichiarano incapaci di ogni sforzo intellettuale e si confinano in situazioni passive, ad esempio rimanendo ore intere a giocare sul loro computer con giochi ripetitivi, evitando gli scambi con gli altri bambini. Timidezza, rifiuto, mancanza di fiducia nei loro atteggiamenti, paura degli altri? Non sono segni di un’inibizione che può aggravarsi?
Perché l’interesse per il sapere può condividere la stessa sorte del sapere sessuale, che è divenuto in larga parte sapere inconscio, rimosso, dimenticato. Diventa impossibile o vietato per il soggetto di «sapere», «ça voir», cosa ne è dei suoi limiti perché non può accettarli. La rimozione, la volontà di non sapere, sono tali da portarsi via ogni curiosità intellettuale. L’inibizione che ne deriva è una rinuncia, un meccanismo di evitamento. Blocchi, povertà intellettuale, lentezza, disinteresse per gli apprendimenti: i suoi effetti sono vasti.
Eppure l’inibizione è dapprima un processo regolatore. La parola latina inhibere, che significa insieme «trattenere» e «vietare», designa le due facce di questo processo. L’inibizione prima «trattiene»: arresta l’illusione dell’onnipotenza, permette di contenere i movimenti spontanei verso la soddisfazione immediata, gli impulsi. Forse i bambini cosiddetti iperattivi non sono abbastanza inibiti… La prima funzione dell’inibizione è quella di rendere possibile l’accesso alla realtà e alla vita sociale. Il bambino deve rinunciare a fare ciò che vuole quando vuole, senza preoccuparsi né delle restrizioni né degli altri. È sotto l’effetto dell’inibizione strutturante, del lavoro di d’uomesticazione3 pulsionale che essa svolge, che la sublimazione può insediarsi.
Ma questa funzione dell’inibizione può arrivare fino a provocare una siderazione totale, sino a vietare ogni manifestazione spontanea. L’inibizione, sia troppa che troppo poca, colpisce la libera circolazione dell’energia psichica. L’inibizione è allora restrittiva, patologica, e può comportare dei blocchi in tutti gli ambiti: motorio, come ad esempio la paralisi atipica del braccio che impedisce di scrivere, o il crampo dello scrittore; funzionale, come la vista che si annebbia, le linee della pagina che si sovrappongono al momento di fare un lavoro scolastico, intellettuale, in questo caso è il funzionamento stesso del pensiero ad essere ostacolato. L’inibizione è acefala, non fa pensare a niente; il soggetto non riesce a dire quello che gli succede. Comunque può essere transitoria, legata ad un evento particolare, e rimanere limitata.
Quando l’inibizione tocca in maniera duratura la funzione della comprensione, essa in qualche maniera segna il fallimento delle teorie sessuali infantili nell’otturare, nel mascherare, attraverso l’invenzione intellettuale, la cruda realtà delle questioni sessuali. L’inibizione intellettuale è, quindi, l’impossibilità per il soggetto di trovare da sé le proprie risposte. Una delle sue particolarità è che chi ne è vittima non se ne lamenta. Non si rende conto, con questo braccio di ferro con se stesso, di mettere in dormiveglia le proprie capacità di pensiero e di autonomizzazione. Il soggetto inibito è chiamato dalle esigenze esterne, dai genitori, dalla scuola, a sbarazzarsi della sua difficoltà («non bisogna essere così timido», «bisogna rispondere quando si viene interrogati»…) mentre, per l’appunto, i mezzi per farlo, anzi, la necessità di farlo, gli sfuggono completamente. Il sentimento che egli dà di essere depresso gli resta estraneo e questo svia gli adulti che lo circondano e rende difficile il suo accompagnamento, in particolare per le insegnanti. I «non so» e il silenzio che il soggetto inibito oppone ad ogni domanda sono la confessione della sensazione di essere invasi non da un non-sapere, ma dal terrore di incontrare un sapere che egli preferirebbe non sapere.
È così per Dominique, giovane donna proveniente da un ambiente modesto nel quale la lettura veniva considerata come un’attività da pigri, che è riuscita nel suo percorso di scolarizzazione fino alla maturità, malgrado un assenteismo scolastico molto importante legato al disinvestimento della sua famiglia nella scuola; potersi mantenere da sola era la cosa che contava di più. Si iscrive alla facoltà nell’indirizzo prescelto ed è ammessa da curriculum. Ma il giorno della ripresa scolastica non riesce a varcare la soglia dell’università, e neanche i giorni successivi. L’impossibilità è fisica, non «si tiene più sulle gambe», dice. Si impedisce di andare avanti, in tutti i sensi della parola. Poiché voler sapere, «è essere pretenziosa», «è voler superare i suoi genitori», commenta qualche anno più tardi, quando mi riporta questo episodio della sua vita. Non può prendersi il rischio, immaginario, di perdere il loro affetto. Soprattutto, lotta contro il risentimento nei confronti dei suoi genitori, risentimento che si indovina dietro le sue negazioni: «Non è colpa loro se mi hanno impedito di andare a scuola» e dietro la sua inibizione tinta di auto deprecazione. Presenta i suoi argomenti come nella storia del calderone che Freud amava raccontare4: «È sicuramente un errore» se il suo curriculum è stato accettato, «lei non lo meritava», e «in ogni caso, non sarebbe stata all’altezza».
Quando, in situazioni estreme, il libero esercizio dell’intelligenza è pesantemente ostacolato, il pensiero diventa povero al punto di sfociare talvolta in quadro di pseudo-debilità.
Il caso di Robert lo illustra bene. Ha 9 anni quando i suoi genitori lo portano in consultazione. Lo descrivono lento, impressionabile fino al panico. In seduta, Robert resta paralizzato, lo sguardo sfuggente, non si muove dalla sua sedia, trattiene il respiro. Soffre sin dalla prima infanzia di un diabete insulinodipendente, ereditario. E ne fa un destino: è ebete, e così rimarrà, come sua madre, con la quale condivide questi due tratti: diabetica ed ebete (anche lei si definisce così). Di queste due caratteristiche lui fa un condensato: è «diabête»5. Le sedute sono silenziose, punteggiate solamente da «non lo so», «niente», «no», mormorati e imbarazzati quando lo sollecito. Nessun racconto di sogni: «è da idioti», dichiara. Un solo disegno, dietro mia insistenza, un omino minuscolo, minuzioso, che disegna laboriosamente per poi concludere: «Non gli manca niente». «È possibile?», mi arrischio a domandargli. La mia domanda lo lascia in una fredda siderazione. Da quel momento si rifiuta di venire, avendo deliberatamente scelto di non sapere che è impossibile che niente manchi.
Il soggetto inibito non si autorizza nessun immaginario. L’angoscia davanti al compito lo paralizza (i fogli bianchi in occasione degli esami), o gli impedisce di andare là dove circolano i saperi, in particolare a scuola. Il rifiuto di entrare in classe a volte è la manifestazione di un’inibizione paralizzante apparsa progressivamente, e spesso molto discretamente. La maggior parte di coloro che ne soffrono sono scialbi e silenziosi, non si fanno notare se non, ogni tanto, per la loro esagerata riservatezza. Succede così che ci si renda conto, quasi per caso, che alcuni bambini, ritenuti «non-lettori» siano semplicemente «incapaci» di leggere ad alta voce.
Al contrario in alcuni casi, un superinvestimento del pensiero maschera l’inibizione. Le difese contro l’invasione del pensiero da parte di pensieri parassitari, provocano la sua mobilitazione eccessiva in uno o in pochi ambiti molto limitati che risucchiano tutta l’attenzione del soggetto.
È così per questa bambina di quasi 9 anni che viene da me dietro le pressioni di sua madre, perché è paralizzata da una timidezza che la svantaggia pesantemente nelle sue relazioni extra-familiari. Mi dichiara già nel primo appuntamento che la sola cosa che le dia sollievo è lavorare bene in classe: almeno durante il tempo che vi consacra non pensa ai suoi brutti pensieri. Si rifiuta di dirmi qualcosa di più, e anche di venire ad un secondo colloquio perché parlare di ciò che la angoscia «gliela rende ancora più presente», dice.
Vengo a sapere da sua madre che questa bambina, attualmente in terza elementare, resta totalmente muta a scuola. Nel profondo, soffre di una rimozione insufficiente. È costretta a lottare ininterrottamente contro l’invasione di pensieri angoscianti. L’investimento esclusivo del sapere scolastico e i buoni risultati che ottiene malgrado la sua assenza nella partecipazione orale, aiutano. Rinforza o rimpiazza l’onnipotenza infantile; imparando a memoria, piegandosi ad ogni consegna, ella fugge dall’angoscia. Ma, allora, l’inibizione colpisce un altro ambito della sua vita, quello delle relazioni con gli altri, e rischia più tardi di toccare quello delle relazioni amorose, area sensibile per eccellenza.
Dunque ci sono paradossalmente dei successi su un fondo di inibizione. Ma la lamentela di essere incapaci di pensare correttamente, o semplicemente di poter pensare, non è mai alleviata, né dall’acquisizione di diplomi né da una incontestabile riuscita sociale. È quello che succede a Odile, di cui abbiamo parlato poco sopra6. Lei ha funzionato attraverso un rassicurante conformismo intellettuale che però impediva qualsiasi invenzione, aspetto fastidioso per una ricercatrice, e schiacciava ogni desiderio personale.
L’ombra della depressione plana sopra quei bambini troppo buoni. Per lungo tempo ignorati nei soggetti giovani, gli stati depressivi li colpiscono - i suicidi in questa fascia d’età non sono rari, soprattutto a partire dall’adolescenza (seconda causa di mortalità dopo gli incidenti tra i 15 e i 19 anni). La depressione è una malattia del desiderio. La sua conseguenza immediata è l’addormentamento di ogni slancio vitale, il che comporta immancabilmente un disinvestimento scolastico. D’altronde è un segno premonitore al quale occorre essere attenti, tanto più che il conseguente fallimento rinforza il sentimento depressivo e si instaura molto velocemente un circolo vizioso. Il bambino che si lamenta, ma di niente in particolare, oppure oppone un patetico «non so» ad ogni sollecitazione, testimonia della vicinanza tra l’affetto depressivo e l’orrore di sapere. C’è, nella depressione, una dimissione, un arretramento di fronte alla necessità di orientarsi a partire dal proprio desiderio.
Questo stato, caratterizzato da una sofferenza morale eccessiva e invasiva, è conosciuto e descritto sin dall’antichità. Ognuno ha a che fare con una perdita fondamentale e strutturante che lascia sempre una cicatrice più o meno dolorosa. Ma cos’è che rende intollerabile il dolore di esistere? In quale momento si può parlare di depressione?
Il bambino misura poco a poco l’impossibilità di padroneggiare tutto, di vivere nella cieca beatitudine. L’abbiamo visto, si scopre limitato nelle sue possibilità, dipendente da un altro per la sua sopravvivenza fino a dover passare attraverso le parole dell’altro per chiedere. Impara il mondo attraverso un altro che può donargli solo quello che ha, che non può dunque donargli tutto. Scoprirsi limitati e mortali è un sapere ingombrante che non soltanto non protegge da una realtà inevitabile, ma la fa temere. Solo l’essere umano sa di essere mortale e, anche se può scegliere di darsi la morte, non può scegliere di evitarla. La condizione umana di parlessere [parlêtre]7 rende tristi.
Dalla depressione anaclitica nell’ospedalismo dei neonati privati di legami stabili e costruttivi, al sentimento d’abbandono e alla ricerca affettiva eccessiva, il bambino piccolo soffre. I suoi tratti depressivi sono più o meno marcati. Si manifestano attraverso reazioni somatiche (mal di testa, di pancia, vaghi malesseri…), una fragilità recidiva alle malattie, una affaticabilità importante (un bambino che dorme molto, o che al contrario è insonne), perché il corpo resta il mezzo più diretto per esprimere le parole che non si possono dire. Il bambino depresso può essere irritante poiché è pauroso, piagnucoloso, si aggrappa all’adulto o al contrario rimane nel suo angoletto, si fa dimenticare, sembra spento o tormentato.
A scuola appaiono anche dei sintomi relazionali: isolamento, aggressività, instabilità, e dei disturbi della concentr...