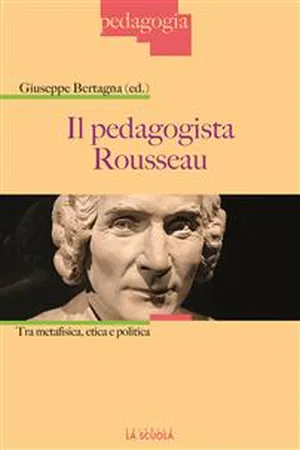Rousseau, fin dalla Prefazione dell’Emilio, attraverso la sua prosa sincopata, paradossale e spesso allusiva, è singolarmente chiaro sull’oggetto formale della sua opera e sul modo con cui intende istituirlo. Chiarezza che disseminerà, poi, come Pollicino, in tutti e cinque i libri dell’opera, per non lasciare dubbi nei lettori anche più prevenuti. A riprova di quanto si sia in presenza di una sua consolidata scelta epistemologica, non di un’opinione passeggera o di qualche inconsapevole e disordinato refuso concettuale.
1. Educazione, pedagogia e teoremi
Egli, infatti, avverte subito, fin dalle prime pagine, che, in educazione, non bisogna per nulla lasciarsi affascinare da «ciò che si fa». E ancor di più che non bisogna farlo in pedagogia, intendendo con questo termine né più né meno di quello che intendiamo noi ancora oggi, cioè una sistemazione teorico-critico-riflessiva delle esperienze educative presenti o di quelle passate, di cui troviamo traccia nella storia o nella nostra storia.
Nel suo linguaggio, non bisogna, quindi, lasciarsi affascinare dall’educazione o dalla pedagogia che ci provengono «dagli uomini o dalle cose» che ci sono (noi compresi) o che ci sono stati. In altri termini, in questi campi, non possiamo limitarci ad analizzare i «rapporti esistenti nelle situazioni (educative e/o pedagogiche, n.d.r.) determinate».
Nemmeno procedere ad un’operazione critica a doppia potenza, del genere: a) ricavare dalle esperienze educative esistenti una qualche formalizzazione teorico-pedagogica, diversa da quelle già prodotte e disponibili in letteratura; b) ricavare dalle stesse sistemazioni pedagogiche comunque disponibili una formalizzazione pedagogica ancora più alta, di secondo grado, una specie di «pedagogia delle pedagogie esistenti».
La «presenza», ovvero ciò che c’è o ciò che si fa, infatti, se è ineliminabile sia dalle pratiche educative, sia dalle elaborazioni pedagogiche, è, a suo avviso, del tutto insufficiente a costituire le une e le altre, nella loro autenticità ed affidabilità.
Ambedue le dimensioni, al contrario, hanno o devono aver a che fare, secondo Rousseau, con «altro» rispetto alla mera «presenza». Con un linguaggio derridiano, potremmo sostenere che esigono un «supplemento»: sottoporre la presenza all’ineliminabile mediazione di un’assenza, che, tuttavia, la compie.
La critica a Grozio, Hobbes e Montesquieu. Per questo non bisognerebbelavorare, in educazione e pedagogia, come avrebbe lavorato Grozio in diritto: «fondare sempre il diritto sul fatto».
Oppure procedere come si sarebbe comportato Hobbes in filosofia politica, il quale, vedendo di fatto, cioè guardandosi attorno o/e gettando il proprio sguardo dietro di sé, nel passato, nella storia, come la «specie umana» sia e sia stata sempre «divisa in greggi di bestiame, ognuno dei quali ha il suo capo che lo sorveglia per poi sbranarlo», concluse quasi senza accorgersene che, dunque, i «capi» sarebbero stati di «natura superiore a quella dei loro popoli», se non altro perché avevano la forza di sbranarli.
Nemmeno, infine, si può agire come avrebbe agito anche Montesquieu, il quale se pur rimproverava Hobbes di voler «far fare agli uomini ciò che neanche i leoni fanno» (infatti «nessun animale attacca i suoi simili senza ragione, casomai ne cerca l’alleanza nel branco»), al posto di correggere l’errore di impostazione del filosofo inglese e, di conseguenza, con coraggio, «trattare i princìpi (etico-metafisici, n.d.r.) del diritto politico», si sarebbe invece paradossalmente accontentato di continuarne la strada dei fatti, studiando «il diritto positivo dei governi esistenti» per ricavarne poi adeguati insegnamenti teorici da consegnare ai lettori. Mentre invece «nulla al mondo […] è più diverso», per oggetto formale e per metodo, di queste due ricerche, la prima metafisica e la seconda storico-fisica.
La critica alla scienza moderna. Sarebbe sbagliato, insomma, ad avvisodel ginevrino, ridurre l’educazione, e a maggior ragione la pedagogia, al programma epistemologico moderno baconian-galileiano, che, come è noto, si può riassumere nello slogan: «dall’esperienza alla scienza». Per di più, siccome l’intelletto «è come uno specchio ineguale rispetto ai raggi delle cose» esso, di conseguenza, «mescola la propria natura con quella delle cose, che deforma e trasfigura», con l’ambizione di correggerne addirittura, grazie al metodo autocorrettivo, gli errori che sarebbero, però, strutturali (idola).
Per lui (e bisogna dire non solo per lui, viste le proposte di molte epistemologie del novecento post scientiste o postgalileiane e non per questo anarchiche), almeno dal punto di vista dell’educazione e della pedagogia, questa strada sarebbe impropria e, soprattutto, sterile. Sterile perché condurrebbe sempre e comunque a risultati soltanto ipotetici, se non addirittura «finzionali» (proprio da fiction).
Tutto ciò che parte dall’esperienza, infatti, e ancora di più quanto coinvolge l’esperienza personale vissuta da ogni uomo nel suo educarsi concreto, storico, è, per definizione, «accidentale» e «singolare». L’idiografico personale «varia», infatti, «all’infinito».
Per questo, come aveva già insegnato Aristotele, non si può ricavare da esso qualcosa che ambisca al definitivo, e non solo nel senso di «assoluto» e «universale», ma perfino di «generale».
Non è un caso, dunque, che non rientri nelle corde del ginevrino la propensione a indurre «leggi» universali e necessarie dall’educazione e dalla pedagogia così «come esse sono», «come si presentano», o «come sono state», «come si sono presentate», nel concreto degli spazi e dei tempi, vicini o lontani, per protagonismo personale diretto o mediato. Se fosse stato così, avrebbe ragione chi lo rimprovera di incoerenza temeraria. Come poteva, infatti, pretendere di poter ricavare dalla propria esperienza insegnamenti attendibili per gli altri se sapeva benissimo, e ne aveva anche parecchio sofferto, di essere stato non solo un orfano infelice, un precettore fallimentare (come nel caso dei figli del signor De Mably, analizzato nelle Mémoire o del figlio di Madame Dupin), ma anche un cattivissimo marito e padre?
Si potrebbe allora sospettare che se, per Rousseau, qualsiasi sapere induttivo, in educazione e pedagogia, non era attendibile, lo avrebbe potuto essere maggiormente quello matematico-deduttivo. Anche al netto dell’antipatia per il cartesianesimo, tuttavia, la sua risposta rimane negativa. L’educazione delle persone, infatti, non è un sillogismo.
Poteva anche essere che avesse ragione Aristotele (con Pascal) a sostenere che i principi originari della logica su cui fondare la puntigliosa penetrazione dimostrativa degli Analitici primi e degli Analitici posteriori fossero indimostrabili tutto sommato perché così evidenti da non aver bisogno di dimostrazione. In effetti, ad essi si giunge per via extracategoriale: anche aristotelicamente, attraverso i Topici.
Il problema, però, nasceva dal dover poi comunque connettere questi principi universali con l’esperienza particolare di ciascuno, attraverso proposizioni dedotte. Per questa connessione, infatti, serviva, da un lato, un ragionare sillogistico rigoroso, oggi diremmo digitale, del tutto esente dal disturbo di qualsiasi filtrazione analogica, tipica del linguaggio comune o delle emozioni e dei sentimenti. Quando è stato osservato che nemmeno Aristotele era riuscito a dare un solo esempio di questa purezza. Ma, dall’altro lato, era ancora più necessario che questa meravigliosa macchina di proposizioni sillogistiche in sé certa e affidabile aiutasse davvero a penetrare i segreti e a controllare l’imprevedibile contingenza, tipici di ogni fenomeno empirico e a maggior ragione di ogni singola ed unica esperienza umana. Pretesa che il semplice buon senso esclude, se non altro perché anche il più piccolo esercizio della libertà di ognuno può beffare le deduzioni più rigorose e necessarie a suo riguardo.
Per questo, Rousseau scrive nell’Emilio che non metterà «mano all’opera, ma alla penna, e quel che si deve, anziché farlo» si sforzerà soltanto «di dirlo». Per la stessa ragione, confessa, inoltre, di saper «bene che, in imprese quali la mia, l’autore si trova sempre a suo agio tra teorie che non ha l’obbligo di mettere in pratica, so bene che impartisce senza sforzo una folla di bei precetti impossibili a seguirsi e che, per mancanza di particolari esempi, anche la parte attuabile delle sue proposte resta lettera morta, quando non ne abbia mostrato l’applicazione». Sempre rifacendosi allo stesso motivo, avverte, poi, che se mai vi fosse stato qualcuno che gli avesse voluto chiedere, dopo aver letto ed apprezzato l’opera, di fare il precettore dei figli, lo avrebbe pregato di «risparmiarsi l’inutile fatica». E, infine, per non lasciare dubbi, dopo la pubblicazione dell’Emilio, dichiara di essersi ben guardato non solo dall’accettare le numerose e spesso allettanti proposte di precettorato che gli venivano rivolte, ma addirittura di dare consigli su come dedurre dai suoi principi pedagogici orientamenti per casi concreti. Emblematica, ad esempio, in questo senso, la corrispondenza con il principe del Württemberg che chiedeva precise indicazioni per una buona educazione della figlia.
Anche la soluzione ipotetico-deduttiva inventata dai geometri platonici, rilanciata con così rilevante successo da Galileo per ottenere scientia riferita all’esperienza e, infine, rivisitata da Peirce con la proposta dell’abduzione, non poteva apparire al ginevrino più adeguata di quella esclusivamente induttiva e deduttiva a centrare in maniera affidabile e certa il bersaglio di una buona e veritiera educazione e di una buona e veritiera pedagogia. Si trattava, forse, di una sintesi del meglio delle altre due, ma anch’essa, al pari delle precedenti, non avrebbe comunque portato ad altro che a fiction.
La ricerca di una strada alternativa. Tuttavia, che farsene di un’educazione e di una pedagogia soltanto ipotetiche, friabili, sempre «immaginate», cinematografiche, mai confermate e confermabili, nel loro merito, come teorie vere, valide per ogni uomo e per tutti gli uomini, erga omnes, per sempre?
L’educazione e la pedagogia non hanno a che fare con «cose» con le quali ci si può permettere anche il lusso di «tirare ad indovinare», aprendo poi l’infinita catena dell’autocorrezione che così tanta fortuna ha avuto nelle filosofie della scienza contemporanee. Avendo a che fare con persone e, ciò che più conta, con «l’unica vita di ciascuno», insostituibile, irreparabile, se sbagliata, pregiudicata o offesa, aveva almeno l’obbligo di tentare di non rassegnarsi, per definizione, a sempre mezze verità, ma di trovare la verità essenziale, quella tutta pura e tutta vera. Non potendo giudicarci «sempre uguali» perché «continuamente cambiamo», ribadiva il ginevrino, abbiamo, infatti, bisogno di una «saggezza che non inganna», così che «qualunque decisione» prendiamo non solo sia sempre «onesta e buona», ma sia anche sempre liberamente voluta perché e in quanto con tali qualità.
Tanto valeva, allora, essere molto chiari, sul problema. E non dare l’impressione, o usare la furbizia retorica di non darla per volere, in realtà...