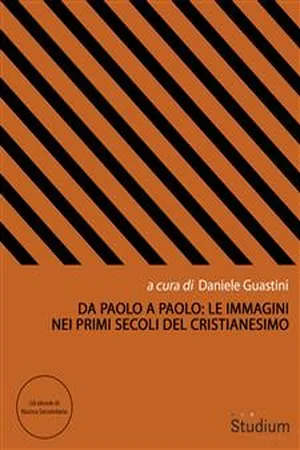
Da Paolo a Paolo
Le immagini nei primi secoli del cristianesimo
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
Da Paolo a Paolo
Le immagini nei primi secoli del cristianesimo
About this book
La prospettiva da cui muovono questi saggi non coincide esattamente con quella più diffusa tra gli storici dell'arte tardo antica e gli studiosi di archeologia cristiana. Se in quell'ambito, infatti, sotto l'influenza più o meno diretta della tradizione estetologica, si è usi guardare ai primi manufatti figurativi riconducibili alla fede cristiana perlopiù come a una sorta di apprendistato artistico, che vedrà compiuta realizzazione del proprio Kunstwollen solo nei primi decenni del V, cioè in epoca bizantina, qui la questione è posta in altri termini. Nella prospettiva qui offerta si ritiene, invece, che tale periodo di due secoli in cui videro la luce affreschi, mosaici e sculture presenti, prima della svolta costantiniana dell'impero, solo nei coemiteria e nelle domus ecclesiae, abbia costituito un'epoca a se stante, non spiegabile con le categorie provenienti dall'ambito degli studi di iconografia bizantina. Abbia, cioè, costituito un'epoca caratterizzata certamente da una novitas, da una svolta effettiva e decisiva realizzata dalla fede cristiana rispetto al precedente periodo aniconico, durato anch'esso ben due secoli e segnato, sotto questo come sotto altri punti di vista, dall'equiparazione con la religione giudaica, che, nella fattispecie, interdiceva la produzione e l'uso delle immagini in nome del rispetto del comandamento della Legge riportato in numerosi passi veterotestamentari. Ma una novitas che non può essere tuttavia spiegata, come spesso è stato fatto, semplicemente nei termini di un passaggio di consegne: quello che si sarebbe verificato all'interno di una cultura cristiana prima legata a doppio filo con l'ebraismo e la sua religione e poi, una volta oltrepassati i confini palestinesi, consegnatasi ai valori e alle pratiche del mondo ellenistico-romano.
Frequently asked questions
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Information
Verso Bisanzio
Pietro Del Soldà



Le immagini della “nuova Roma”
Plotino ispiratore. La lezione di Grabar
Table of contents
- Copertina
- Da Paolo a Paolo
- Indice dei contenuti
- Da Paolo a Paolo
- Prima dell’immagine. La sopravvivenza del divieto biblico di “farsi immagini” nel cristianesimo delle origini
- Il ruolo delle eresie nella nascita dell’immagine cristiana
- Verso Bisanzio