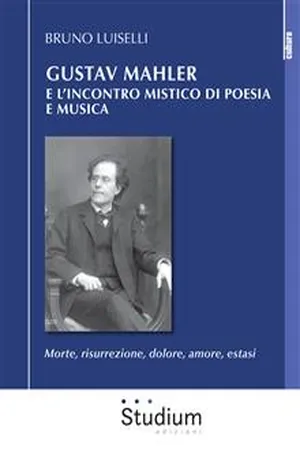
eBook - ePub
Gustav Mahler e l'incontro mistico di poesia e musica
Morte, risurrezione, dolore, amore, estasi
- English
- ePUB (mobile friendly)
- Available on iOS & Android
eBook - ePub
Gustav Mahler e l'incontro mistico di poesia e musica
Morte, risurrezione, dolore, amore, estasi
About this book
Nel sottotitolo l'autore anticipa l'esprimersi del misticismo di Mahler attraverso il quintuplice sentimento di morte - risurrezione - dolore - amore - estasi. Nel Prologo riafferma il sentimento mahleriano della morte, della risurrezione, del dolore, dell'amore e dell'estasi, ma nel corso della sua esposizione, ulteriormente approfondendo, eglidistingue l'estasi in estasi nietzschianamente lirica e in estasi contemplativa cristiana immaginata e musicalmente interpretata dallo stesso Mahler. significativa la conclusione cuiperviene l'autore: Mahler visse questa vita guardando verso l'altra Vita, l'Unsterblich Leben.
Frequently asked questions
Yes, you can cancel anytime from the Subscription tab in your account settings on the Perlego website. Your subscription will stay active until the end of your current billing period. Learn how to cancel your subscription.
No, books cannot be downloaded as external files, such as PDFs, for use outside of Perlego. However, you can download books within the Perlego app for offline reading on mobile or tablet. Learn more here.
Perlego offers two plans: Essential and Complete
- Essential is ideal for learners and professionals who enjoy exploring a wide range of subjects. Access the Essential Library with 800,000+ trusted titles and best-sellers across business, personal growth, and the humanities. Includes unlimited reading time and Standard Read Aloud voice.
- Complete: Perfect for advanced learners and researchers needing full, unrestricted access. Unlock 1.4M+ books across hundreds of subjects, including academic and specialized titles. The Complete Plan also includes advanced features like Premium Read Aloud and Research Assistant.
We are an online textbook subscription service, where you can get access to an entire online library for less than the price of a single book per month. With over 1 million books across 1000+ topics, we’ve got you covered! Learn more here.
Look out for the read-aloud symbol on your next book to see if you can listen to it. The read-aloud tool reads text aloud for you, highlighting the text as it is being read. You can pause it, speed it up and slow it down. Learn more here.
Yes! You can use the Perlego app on both iOS or Android devices to read anytime, anywhere — even offline. Perfect for commutes or when you’re on the go.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Please note we cannot support devices running on iOS 13 and Android 7 or earlier. Learn more about using the app.
Yes, you can access Gustav Mahler e l'incontro mistico di poesia e musica by Bruno Luiselli in PDF and/or ePUB format, as well as other popular books in Art & Religious Art. We have over one million books available in our catalogue for you to explore.
Information
I. Mahler e Klopstock
Nel 2013 è stato pubblicato in Italia un ponderoso volume a cura di Gastón Fournier-Facio: Gustav Mahler, Il mio tempo verrà . La sua musica raccontata da critici, scrittori e interpreti, 1901-2010 , Milano 2010, comprendente scritti su Mahler che, già editi, vanno appunto dal 1901 – Mahler ancora vivente – al 2010: molto mi sorprende che tra gli articoli, reperiti da ogni dove, non se ne sia trovato uno incentrato specificamente su Mahler e Klopstock, argomento veramente fondamentale per lo studio della vicenda esistenziale e poetico-musicale del grande Gustav. Né mi risulta che un contributo su Mahler e Klopstock, concepito nei termini che verranno qui esposti, sia mai stato pubblicato.
Mahler, fiorito in clima culturale tedesco postromantico, fu musicalmente legato al romanticismo tedesco (Leonard Bernstein, Il suo tempo è arrivato [titolo originale: Mahler: His Time Has Come, del 1967], in Fournier-Facio appena citato, pp. 432 sgg.), ma fu anche creatore – chi può negarlo? – di nuove espressioni musicali. Ne derivò una musica profondamente personale e nuova. A tale riguardo è ben significativo il concetto che Alma – già moglie di Gustav, donna musicalmente molto preparata, pianista e compositrice (autrice di Lieder) lei stessa e di grande personalità – ebbe occasione di esternare quando era al massimo della sua maturità musicale e culturale, cioè nel 1959 (qualche anno prima della sua morte [1964]): … Mahler war ein abstractum, aber wegweisend für mich und unvergeßlich («… Mahler fu un abstractum, ma un orientamento per me e indimenticabile»). Ein abstractum: ciò vuol dire che la musica di Mahler non è inquadrabile né in questa, né in quella realtà musicale, e non ha imitatori (Alma scrisse quelle parole in una sua lettera a Willy Haas del 10 aprile 1959, da questo poi inserita nell’edizione, da lui stesso curata, del Mein Leben di Alma [vedi sopra, p. 6], p. 336).
Il tema che in questa sede affronto è l’incontro, d’ispirazione mistica, di poesia e musica in Gustav Mahler. Esso ci porta a momenti di quasi silenzio o di espressione sussurrata/silenziosa. Il che non è una contraddizione. Al contrario, è sublime incontro e indissolubile intreccio del canto solistico-vocale e/o corale col silenzio: incontro e intreccio che sono ben lontani da un assurdo razionalismo, artisticamente irricevibile. È la irrazionalità del sublime, che solo chi ha sensibilità tale da calarsi nello spirito dell’arte (in questa sede, nello spirito del connubio mistico poesia/musica) e di viverlo, può cogliere ed esserne coinvolto. Ma non basta. Ci sono momenti in spirito di invocazione e di meditativa espressione sussurrata/silenziosa e ci sono anche momenti a distanza da essi, ma da essi derivati, in spirito di glorificazione e di grandiosa apertura verso l’infinito, e scopriamo che i secondi momenti richiamano i primi in una ideale continuità: grazie a questa i secondi momenti, malgrado la distanza dai primi, rivelano una sublimazione di quanto espresso nei primi. L’incontro mistico, in Mahler, di poesia e musica esprime in modo sublime il Mahler doloroso, il Mahler gioioso e anche, in taluni momenti, il Mahler silenzioso, il Mahler, cioè, dei momenti di silenzio carico di tensione. Tutto ciò ci parla della profonda spiritualità di Gustav. Da questa deriva il titolo di questo scritto: Incontro mistico di poesia e musica in Gustav Mahler.
Mahler, nella lettera del 7. 2. 1893 a Gisela Tolnay-Witt scrive (Gustav Mahler, Briefe, Neueausgabe erweitert und revidiert von Herta Blaukopf, Wien-Hamburg 1982, p. 106): «Quanto più la musica si sviluppa, tanto più complicato diventa ( desto komplizierter wird) l’apparato [di note], che il compositore pubblica per esprimere le proprie idee ( um seine Ideen auszudrücken)». Esprimere le proprie idee. Sono infatti innumerevoli le osservazioni e indicazioni che Mahler fa in tedesco (come già Wagner, ma anche più di Wagner) in aggiunta alle tradizionali indicazioni agogiche e dinamiche in lingua italiana (ma molto frequentemente Mahler esprime anche queste in tedesco). Per esempio, nel momento iniziale della sua prima sinfonia, in relazione alla bassa nota pedale ( la) in pp ( pianissimo) del terzo gruppo dei contrabbassi divisi, egli ha scritto: Anmerkung für den Dirigenten: Dieses tiefste a muss sehr deutlich [così, sottolineato nel testo mahleriano] wenngleich pp gespielt werden («Annotazione per il direttore d’orchestra: questo profondissimo la deve essere suonato molto chiaramente, sebbene in pp»). La realtà è che Mahler, poeta e musico vissuto al tramonto del romanticismo tedesco e nel postromanticismo, sentiva in maniera romanticamente viva le sue emozioni, e sentiva vivamente le sue idee, tanto che fra le sue emozioni e le sue idee molto spesso non avvertiamo distinzione: una sua idea era per lui emozione, egli viveva emozionalmente l’idea. Possibile obiezione: si può vivere, sì, una emozione, ma si può vivere una idea? La mia risposta è no, se per idea intendiamo, per esempio, l’Idea (con l’iniziale maiuscola) metafisica di Platone o l’Idea (ancora iniziale maiuscola) gnoseologica di Aristotele. Ma se per idea intendiamo una idea (con iniziale minuscola) connessa con un nostro Erlebnis, cioè con una nostra interiore personale esperienza (per esempio, il verso mahleriano Sterben werd’ ich, um zu leben! «Morirò per vivere!», idea del morire finalizzato al vivere post mortem), possiamo allora dire che viviamo quell’idea. Leggere i versi di Mahler o i versi di altri poeti da lui profondamente assimilati e ascoltare la sua musica che li esprime e fare l’esegesi di quelle sue pagine musicali vuol dire entrare nella sua anima, penetrare nelle più profonde “pieghe” della sua anima. E in generale, anche indipendentemente dalla sua musica su versi propri o altrui, è importante l’interpretazione del testo soltanto orchestrale di Mahler e coglierne i moti, consistenti tante volte anche in repentini sbalzi umorali, per non parlare, poi, di tanti momenti orchestralmente di alta liricità, come, per esempio, il Sehr einfach und schlicht wie eine Volksweise («Molto semplice e schietto come un’aria popolare») nel III movimento della I sinfonia, battute 10, 3 sgg. (riferimento della partitura all’edizione: Gustav Mahler, Symphonies Nos. 1 and 2 in Full Score, Dover Publications, New York 1987) o l’ Adagietto della V sinfonia. E poiché la mia esemplificazione è in riferimento a situazioni soltanto orchestrali, taccio di momenti poetico-musicali, intensamente struggenti, dei Kindertotenlieder (ma ne tratterò specificamente più avanti). In relazione al Mahler autore della bellissima inscindibile unità dei suoi versi e della musica che li esprime, è stupendo il suo concetto del Tondichten, del poetare in suono, del poetare in musica (ne parlerò specificamente più avanti).
Molto mi interessa anche entrare in ciò che egli pensava della sua musica. A questo proposito, trovo molto importante una sua lettera del giugno 1906 a Josef Reitler (pp. 307-308 della citata ediz. Blaukopf). Reitler, scrittore (giornalista) di argomenti musicali allora attivo a Parigi, comunicò a Mahler di avere, nella primavera del 1906, sollecitato l’esecuzione di una sua (di Mahler) sinfonia ivi, in amplissimi circoli, ancora sconosciuto (Blaukopf in nota* [p. 308]). Gustav lo ringrazia e gli precisa: «Io talvolta ho il sentimento ( die Empfindung) che non vivrò l’esperienza del “mio tempo” ( daß ich “meine Zeit” nicht erleben werde)». Ciò nel senso che nel tempo, in cui Mahler viveva e musicalmente si esprimeva, non mancavano coloro che non capivano il suo sinfonismo: quello, dunque, non era per lui il “suo tempo”. Il che, del resto, quadra bene anche col fatto che la sua VI sinfonia, compiuta nell’estate del 1904 ed espressione di grande sofferenza sino allo sfinimento del suo autore (lettera ad Arnold Berliner del 9 settembre 1904, edizione poc’anzi citata dell’epistolario, p. 294: «La mia VI è finita – anche io!» [ Meine VI. ist fertig – Ich auch!]»), era considerata enigmatica ed era oggetto di riserve, come chiaramente dimostrano alcuni sfoghi epistolari dello stesso Mahler (lettera nr. 336 a Richard Specht dell’autunno 1904, p. 295; lettera nr. 352 a Ludwig Karpath di inizio giugno 1906, p. 306). Soprattutto doveva essere bruciante per lui l’incomprensione dell’ultimo tempo della VI, espressione della sua sofferenza fino alle lacrime. Tuttavia, «ed ecco – prosegue Mahler nella sua lettera a Reitler – un’eco da uno sconosciuto mondo ben situato»: qui ci imbattiamo nel Mahler mistico. In quel mondo egli ebbe la fonte di molta parte della sua ispirazione: «dunque forse legor [così, in latino: «sono letto»] e (cosa di cui, del resto, mi sento sicuro) legar! [«sarò letto!»: così, nuovamente in latino]». E su Mahler testimone del significato profondo della sua musica tornerò ancora. Ma intanto, su Mahler che confessa a Reitler, nel 1906, non essere, allora, giunto il “suo tempo”, domando: «È giunto il suo tempo?». Risposta: di fronte al titolo del già da me citato (p. 11) volume miscellaneo a cura di Fournier-Facio: Il mio tempo verrà, sta il titolo del bel saggio, ivi compreso, di Bernstein: Il suo tempo è arrivato (ma su ciò tornerò molto più avanti, in uno specifico contesto nel quale, in rapporto all’idea bernsteiniana dell’essere arrivato il tempo di Mahler, indicherò una sorpresa).
Con la sua prima sinfonia Gustav Mahler aveva dato inizio all’aspetto più grandioso della sua produzione: il sinfonismo. Proprio in relazione a questo, io ora guardo soprattutto a quelle sinfonie nelle quali, a partire dalla seconda, egli ha realizzato l’incontro del canto, solistico-vocale e/o corale, con l’orchestra. Nella già citata lettera a Gisela Tolnay-Witt (p. 106 della ediz. Blaukopf dell’epistolario mahleriano [sopra cit., p. 12]) Mahler manifesta il suo bisogno, per esprimersi musicalmente, del grande apparato orchestrale e lo spiega comparando la esiguità orchestrale del sinfonismo haydniano con la ben maggiore consistenza orchestrale richiesta da Beethoven per la sua IX sinfonia, per non parlare (aggiunge) di Wagner e dei nuovi compositori. Ma pensare che Mahler guardasse alla IX solo in relazione alla sua esigenza di grande apparato strumentale sarebbe riduttivo. Egli guardava alla IX anche, e soprattutto, in relazione – né poteva essere diversamente – alla grande svolta impressa da Beethoven alla storia del sinfonismo attraverso l’ultimo movimento della medesima con l’inserimento, ivi, delle voci solistiche (soprano, contralto, tenore e baritono) e corali (soprani, contralti, tenori e bassi) sulle prime strofe dell’ode An die Freude («Alla gioia») di Friedrich Schiller. Mahler, inoltre, aveva di fronte a sé Wagner, che aveva concepito e realizzato il dramma in musica come Gesamtkunstwerk («opera d’arte totale») e Worttondrama («dramma di parola e suono» o «dramma nell’unità di parola e suono»). Mahler, molto incline alla liederistica, guardando alle grandi svolte della IX sinfonia da una parte e del dramma wagneriano dall’altra, pervenne alla sua grande svolta: l’incontro del liederismo, su versi altrui e propri, col sinfonismo, ed eccoci, dunque, alle sinfonie II, III, IV e VIII (prima parte).
Considero Wagner e Mahler, con Brahms, le più grandi personalità musicali, in Germania, dopo l’universale Beethoven.
Sopra ho ricordato il Mahler autore di versi (p. 12). Sì, consideriamo una sua lettera da Vienna ad Anton Krisper del 3 marzo 1880 (ediz. Blaukopf cit. dell’epistolario mahleriano, pp. 14-15): egli, ventenne (era nato, come sappiamo, nel 1860), richiama l’attenzione del destinatario della sua missiva sull’improvviso ritorno ( über Nacht), quell’anno, della primavera e gli comunica di essersi risvegliato afflitto dalla solita nostalgia e malinconia. «Io – scrive Gustav al suo amico – ho appena scritto alcuni versi, che ti comunico, «poiché essi possono svelarti al meglio il mio intimo» ( weil sie Dir am Besten mein Inneres enthüllen können)», e trascrive integralmente una sua poesia intitolata Vergessene Liebe («Amore dimenticato»). È un carme traboccante di sentimentalità articolato in quattro belle strofe, ciascuna di due distici (= quattro versi con rima ABAB) + un tristico (= tre versi con rima AAB). Mi pare che il giovane Gustav vi esprima il suo Inneres come esperienza di due distinti momenti: il primo (strofe I-III) è ...
Table of contents
- Copertina
- Gustav Mahler e l'incontro mistico di poesia e musica
- Indice dei contenuti
- Prefazione
- Introduzione. Semantica dell’incontro mistico di poesia e musica
- Prologo. Il misticismo del Parsifal e il misticismo mahleriano
- I. Mahler e Klopstock
- II. Oltre il rapporto Mahler/Klopstock. I Kindertotenlieder: da Rückert a Mahler
- Appendice
- III. Ancora oltre il rapporto Mahler/Klopstock. L’ottava sinfonia mahleriana: la visione panamorosa di Mahler; dall’estasi lirica alla scoperta dell’estasi cristianamente intesa
- IV. Testimonianze su Mahler di Thomas Mann, Oskar Fried e Alma Maria Mahler
- Epilogo