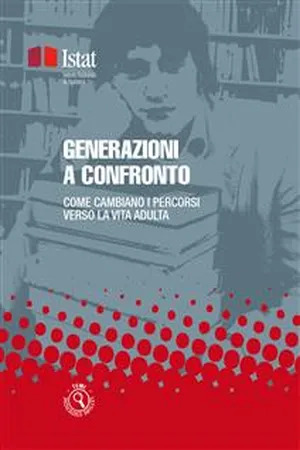![]()
1. Percorsi di vita dei giovani e origini sociali: una visione di insieme
1.1 La crescente articolazione dei percorsi di vita
Le diverse discipline che in ambito sociale studiano il comportamento umano convergono nel riconoscere che, a partire dalla seconda metà del ‘900, si sia assistito ad una crescente individualizzazione dei fenomeni demografico-sociali che ha determinato una forte diversificazione nei percorsi di vita nelle società avanzate. Se un tempo il ciclo di vita era individuato da fasi universali, ordinate e legate all’età degli individui, cioè in un certo senso era standard, in seguito, a partire dagli anni ’60 il processo di transizione allo stato adulto ha perso le precedenti rigidità e si è progressivamente articolato grazie ai cambiamenti sociali avvenuti che hanno inciso sia sulla cronologia degli eventi che sul loro ordine sequenziale. Tuttavia, il grado di individualizzazione e de-standardizzazione dei corsi di vita nelle società avanzate non è uniforme dal momento che il processo di modernizzazione è andato diffondendosi prima di tutto nei paesi nord-europei e solo successivamente nei paesi del sud Europa.
La transizione allo stato adulto si compone di diversi passaggi di rilievo del vissuto degli individui: ad esempio dalla famiglia dei genitori alla vita indipendente o di coppia, dallo status di studente a quello di occupato, dallo status di single a quello di coniugato e dall’essere senza figli alla genitorialità. I tempi e i modi di questi passaggi sono strettamente legati al benessere degli individui e alle loro prospettive di vita.
A partire dagli anni ’60 le traiettorie di vita familiari e lavorative sono passate dall’essere molto rigide e sincronizzate a complesse e diversificate, al punto da far ritenere che il processo di individualizzazione riguardasse la maggior parte degli individui e rappresentasse comunque uno dei cambiamenti più profondi della società. I cambiamenti strutturali e quelli culturali hanno alterato i percorsi di transizione allo stato adulto introducendo anche nuove forme di vulnerabilità. Per alcuni è la destandardizzazione dei percorsi biografici individuali a produrre le nuove forme di vulnerabilità rendendo “il rischio” una condizione strutturale in ciascun ambito della vita sociale (Beck 2003).
Negli ultimi decenni si è assistito ovunque nei paesi a sviluppo avanzato ad una posticipazione delle età alle quali gli eventi caratterizzanti il processo di transizione allo stato adulto sono vissuti. In questo quadro l’Italia, dove la permanenza dei giovani nella famiglia di origine raggiunge livelli massimi da diverso tempo, occupa una posizione di primaria importanza. Nel 2011, infatti, l’Italia, con il 62,3 per cento dei giovani di 18-34 anni che vivono in casa con i genitori, si posiziona in vetta tra i 15 Paesi dell’Unione europea, dove tale quota si attesta al 44,5 per cento (Eurostat, 2010). In particolare tra 18 e 34 anni permangono con i genitori il 56,4 per cento delle giovani e il 67,9 per cento dei giovani italiani.
Questo comportamento accomuna il nostro Paese ad altri paesi dell’Europa mediterranea quanto ai sistemi di formazione della famiglia: anche in Spagna, Grecia e Portogallo i giovani restano più a lungo nella casa dei genitori (anche quando lavorano), se ne distaccano prevalentemente quando vanno a vivere in coppia, spesso sposandosi, e andando a risiedere in una casa di proprietà acquistata grazie al sostegno delle famiglie di origine. Al contrario, nei paesi dell’Europa centro-settentrionale avviene più frequentemente che, per motivi di studio e di lavoro, i giovani si allontanino presto dalla famiglia di origine, andando a vivere in affitto e sperimentando una fase di vita indipendente come single o in convivenza con amici o con un/a partner (Barbagli et al. 2003; Corijn e Klijzing 2001; Cavalli e Galland 1993).
Uno dei principali fattori di cambiamento strutturale che sottende all’allungamento dei tempi di transizione allo stato adulto è l’espansione del sistema educativo (Shavit e Blossfeld 1993): grazie all’accelerazione registrata nella maggior parte dei paesi occidentali durante gli anni ’50, la partecipazione dei giovani adulti all’interno del sistema formativo nella tarda adolescenza è aumentata. Il processo di espansione dell’istruzione ha contribuito al posponimento della formazione dell’unione e delle nascite dei figli (Blossefeld e Huinink 1991). Un secondo fattore di eminente importanza è rappresentato dall’incremento nella partecipazione delle donne al mercato del lavoro: anche se l’Italia non occupa ancora una posizione di rilievo in tale ambito, le donne oggi escono più frequentemente dalla famiglia di origine dopo aver trovato lavoro dal momento che è considerato non più sufficiente che uno solo dei partner abbia trovato lavoro per costruire una vita indipendente. Nel complesso, le condizioni economiche generali influenzano il passaggio alla condizione adulta, poiché, ad esempio, in corrispondenza di un quadro favorevole si accelerano le transizioni ai matrimoni e alle nascite, mentre il deterioramento delle condizioni economiche contribuisce al rinvio di queste tappe. Così, le generazioni di giovani adulti che si trovano a fronteggiare un clima economico in deterioramento, per essere in grado di mantenere le aspirazioni di consumo acquisite durante l’adolescenza, posporranno le attività che potrebbero ostacolarne la realizzazione, come la formazione della famiglia.
Le differenze nei tempi e nei modi del fare famiglia in Italia e nei paesi mediterranei rispetto a quelli riscontrati altrove in Europa affondano però le radici nel passato. I paesi mediterranei si caratterizzano per l’esistenza di legàmi familiari forti tra genitori e figli e tra fratelli che rimangono intensi in tutte le fasi della vita, anche dopo il distacco dalla famiglia di origine. Così, ad esempio, si riscontra una forte prossimità abitativa delle neo-famiglie con quella di origine, si mantengono frequenti contatti e rapporti di scambio, monetario e non, tra le generazioni e si costruiscono rapporti di solidarietà continuativi nel tempo. Allo stesso tempo, nei paesi del sud dell’Europa, il sistema di welfare appare debole se confrontato con quello esistente nel resto d’Europa (Livi Bacci 2005; Saraceno 2007 e1994; Dalla Zuanna e Micheli 2004; Reher 1998; Rosina e Sabbadini 2006).
In letteratura esistono diversi studi che guardano ai mutamenti nelle biografie degli individui nella loro complessità. Quelli che riguardano il nostro Paese hanno molto spesso un approccio comparativo (Sironi et al. 2013; Elzinga e Liefbroer 2007; Schizzerotto e Lucchini 2002; Lucchini e Schizzerotto 2001; Billari e Piccarreta 2005; Billari 2001) basandosi su dati relativi a Fertility and Family Survey (FFS), o Indagine Longitudinale sulle Famiglie Italiane (ILFI) o Famiglia e soggetti sociali (2003) dell’Istat. Da queste analisi per l’Italia è emerso un basso livello di eterogeneità tra le generazioni prese in esame, una forte stabilità delle traiettorie tipiche verso la condizione adulta, un importante effetto di rinvio delle tappe di formazione della famiglia. Inoltre, la classe sociale di origine e il livello di istruzione possono agire sui tempi di sperimentazione delle varie tappe e nel facilitare l’assunzione di modelli comportamentali meno tradizionali (Sironi et al. 2013; Pisati 2002).
La disponibilità dell’edizione del 2009 dell’indagine Famiglia e soggetti sociali permette di arricchire il patrimonio conoscitivo fino ad ora acquisito sia facendo luce sulle generazioni più giovani, non osservate nelle precedenti indagini, sia utilizzando dimensioni di analisi molto dettagliate quali ad esempio il genere, la classe sociale e l’esperienza di lavoro atipico. La dimensione di classe sociale viene inserita non tanto e non solo alla luce delle potenziali chances di mobilità dei soggetti, quanto come caratteristica ascritta degli individui, in grado di rappresentare un fattore propulsivo nei calendari dei corsi di vita e nelle modalità di accesso e svolgimento del percorso di transizione: i modelli sociodemografici m...