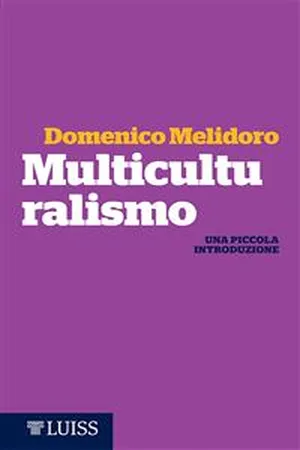![]()
1. Che cosa è il multiculturalismo?
1.1 Premessa
Nelle liberaldemocrazie occidentali si parla di multiculturalismo da circa cinquant’anni. Infatti, è almeno a partire dagli anni ’60 del secolo scorso che, soprattutto in Canada e Australia, la presenza di gruppi etnici e culturali diversi all’interno dei confini del medesimo Stato-nazione è diventata una delle questioni centrali del dibattito politico. Più precisamente, considerando che per i Paesi appena elencati quelli erano anni di immigrazione di massa, ci si cominciò a chiedere quale fosse la risposta adeguata delle istituzioni alla diversità culturale. Quest’ultima era rappresentata principalmente da gruppi di immigrati, da minoranze nazionali e da popolazioni indigene. Bisognava in qualche modo riconoscere questa pluralità culturale, e dunque adottare politiche pubbliche capaci di riflettere il fatto che alcuni cittadini avanzassero richieste in quanto membri di un gruppo piuttosto che come individui? Oppure, più semplicemente, per evitare la disgregazione sociale c’era bisogno di riproporre le consuete politiche di assimilazione delle minoranze, in modo da indurre le minoranze ad essere indistinguibili dalla maggioranza?
Il Canada scelse la strada del riconoscimento della diversità culturale tanto che, nel 1971, il primo ministro Pierre Trudeau adottò ufficialmente il multiculturalismo come politica pubblica. Lo scopo era quello di sostenere e promuovere le minoranze culturali e, allo stesso tempo, di includerle nello spazio pubblico in qualità di eguali. Per i tre decenni successivi, anche nell’opinione pubblica delle altre liberaldemocrazie occidentali il multiculturalismo ha goduto di buona fama. Sembrava che il multiculturalismo à la canadese, ovviamente modificato a seconda dei contesti, fosse la risposta giusta alla diversità culturale e che le politiche di riconoscimento delle minoranze culturali potessero garantire la coesione sociale e la coesistenza pacifica tra diversi.
Negli ultimi anni, tuttavia, l’atteggiamento generalmente positivo nei confronti del multiculturalismo è mutato. Da più parti, anche a causa del clima socio-politico venutosi a creare all’indomani degli attentati dell’11 Settembre 2001, si è parlato di fallimento delle politiche multiculturali. È sembrato quasi che il riconoscimento della diversità culturale, anziché l’integrazione, avesse prodotto l’isolamento e la ghettizzazione delle minoranze, con presunte conseguenze che vanno dalla crescita del radicalismo religioso fino al terrorismo vero e proprio. Perciò, sostengono i detrattori odierni del multiculturalismo, bisogna sostituire le fallimentari politiche multiculturali con nuove politiche di integrazione civica che riportino alcuni valori tradizionali quali la libertà di espressione e di culto, l'uguaglianza dei diritti e il rispetto della legge, al centro della vita collettiva delle liberaldemocrazie occidentali. Queste preoccupazioni che, come è facile capire, riguardano principalmente le minoranze musulmane in Europa o in America del Nord, sono state sollevate nel 2011 dal premier britannico David Cameron che, insieme ad Angela Merkel e a Nicolas Sarkozy, è tra i leader occidentali più convinti del fallimento del multiculturalismo.
Con questo libro non intendo occuparmi di storia del multiculturalismo. Tantomeno pretendo di riflettere sociologicamente sulle ragioni del presunto fallimento delle politiche ispirate al multiculturalismo. Il mio scopo è piuttosto quello di analizzare la natura e i limiti del multiculturalismo dal punto di vista della teoria politica. Più in particolare, intendo discutere criticamente alcune delle questioni teorico-politiche che sono al centro della discussione accademica internazionale sul multiculturalismo negli ultimi anni.
Prima di entrare nel vivo della discussione ritengo opportuno precisare che cosa si intenderà per multiculturalismo nelle prossime pagine. La prossima sezione preciserà il significato di multiculturalismo che adotterò nel prosieguo del libro. Nella terza sezione specificherò i nessi tra multiculturalismo e liberalismo. A partire dal rapporto tra queste due teorie individuerò le tre posizioni teoriche che saranno analizzate nei capitoli 2,3 e 4.
1.2 Definire il multiculturalismo
Che ‘multiculturalismo’ sia un concetto al quale, sia in teoria politica sia nel dibattito pubblico, sono stati attribuiti molteplici significati è una constatazione a proposito della quale è facile essere d’accordo. Come è stato osservato, ci si è serviti del termine ‘multiculturalismo’ per indicare una pluralità di questioni che vanno «dal discorso sulle minoranze alla critica post-coloniale, dai gay and lesbian studies alla narrativa chicano» (Bhabha 1998, p. 31). Alcuni studiosi hanno inteso il multiculturalismo come una teoria che riguarda in primo luogo i diritti delle minoranze nazionali. Altri si sono concentrati sui diritti degli immigrati e su cosa bisognerebbe fare per rendere equa la loro integrazione all’interno del Paese che li accoglie. Altri ancora hanno riflettuto su come bisognerebbe trattate le minoranze religiose o i gruppi LGBT in modo da evitare discriminazioni arbitrarie in ambito scolastico o lavorativo. Infine, alcuni teorici hanno visto il multiculturalismo come una teoria che rivela i limiti dei principi liberali quando si tratta di discutere le condizioni dei popoli indigeni oppure di questioni inerenti contesti sociali post-coloniali.
Considerata questa pluralità di significati, la difficoltà (o forse addirittura l’impossibilità) di identificare un significato non controverso o universalmente accettabile di ‘multiculturalismo’ non dovrebbe sorprendere. A questa difficoltà non sfugge nemmeno il modo di intendere e definire il multiculturalismo che offrirò in questo libro. Lungi dall’aspirare a una definizione universalmente accettabile, mi riterrò soddisfatto se il modo in cui il multiculturalismo sarà trattato in queste pagine illustrerà criticamente e rigorosamente alcune influenti teorie politiche che discutono di come le istituzioni politiche devono affrontare le questioni poste dalla diversità culturale.
Il punto di partenza della mia riflessione è che la diversità culturale rappresenta semplicemente un fatto che caratterizza le società liberal-democratiche contemporanee. In una società che garantisce le tradizionali libertà di pensiero, associazione ed espressione, la presenza di diversi gruppi culturali è un fenomeno facilmente osservabile. Gli individui, se ne hanno la libertà, tendono a costituire molteplici gruppi. Questi gruppi, se si trovano in condizioni di adeguata libertà, tenderanno a distinguersi tra essi per quanto riguarda credenze, tradizioni e valori. Il quadro diventa ancora più complesso se consideriamo che anche la presenza di immigrati portatori di tradizioni e valori diversi è solitamente ritenuta una delle cause dell’incremento della diversità culturale. Quest’ultima aumenta anche quando uno Stato autonomo viene annesso ad un altro Stato, vale a dire nel caso delle minoranze nazionali delle quali si discuterà più diffusamente nel capitolo successivo.
A questo punto è opportuno fare due precisazioni. La prima riguarda la nozione di ‘cultura’ che viene adottata in questo libro, mentre la seconda riguarda alcune conseguenze che derivano dall’assunzione della diversità culturale come fatto.
Ogni volta che in questo libro si parlerà di cultura, a meno di indicazioni diverse, si intenderà «un sistema di credenze e pratiche nei termini del quale un gruppo di esseri umani comprendono, regolano e strutturano le loro vite individuali e collettive. [La cultura] è un modo di comprendere e organizzare la vita umana» (Parekh 20062, p. 143). Data questa definizione di cultura, un gruppo culturale deve essere inteso come un insieme di esseri umani che condividono una cultura che è (almeno in parte) diversa da quella che contraddistingue altri gruppi. Dunque, è come se un gruppo culturale fosse tenuto insieme da una cultura, ed è proprio la condivisione di una cultura a rendere possibile l’identificazione di un gruppo e a distinguerlo dagli altri gruppi.
Quando si discute di cultura e di gruppi culturali bisogna evitare di cadere nel cosiddetto essenzialismo (Benhabib 2005; Bhabha 2001; Kymlicka 2015; Mason 2007; Patten 2014; Phillips 2007). Chi vede le culture in termini essenzialisti, come ha scritto Anne Phillips, «esagera l’unità interna delle culture, solidifica le differenze […] fa in modo che le persone che appartengono ad altre culture sembrino più esotiche e differenti di quanto siano realmente» (Phillips 2007, p. 14). La cultura e i gruppi culturali non devono essere visti come delle entità immutabili, monolitiche e omogenee. Le culture sono infatti entità fluide, diversificate al loro interno, sempre soggette al mutamento in risposta all’evolversi delle circostanze, e caratterizzate da dissensi più o meno profondi.
Negli ultimi anni il multiculturalismo è stato frequentemente criticato in quanto essenzialista. Tuttavia, mi sembra si possa affermare che l’obiezione sia mal posta o esagerata. Infatti, uno degli assi portanti di molti dei tentativi di elaborare una difesa del multiculturalismo è stato proprio quello di scardinare l’essenzialismo cui le maggioranze hanno fatto ricorso per elaborare idee di identità nazionale solide e monolitiche che finiscono per escludere le minoranze culturali e le loro specificità (Kymlicka 2015, p. 212).
Per quanto riguarda invece l’assunzione della diversità come fatto che caratterizza le società liberal-democratiche contemporanee, bisogna osservare che essa ha delle conseguenze fondamentali per le questioni affrontate in questo libro. Innanzitutto questa assunzione implica che la diversità culturale sia una circostanza che le istituzioni devono considerare e alla quale devono fornire delle risposte. Se invece la diversità fosse più di un fatto, e cioè un valore da perseguire, l’atteggiamento delle istituzioni sarebbe inevitabilmente diverso. In questo caso ci sarebbero, sempre e comunque, delle ragioni valide per preferire una società più pluralista dal punto di vista culturale rispetto a una più omogenea. Inoltre, le istituzioni dovrebbero sforzarsi per realizzare una società pluralista dal punto di vista culturale, indipendentemente dalle preferenze dei cittadini e dalle circostanze storiche e sociali che essi si trovano a fronteggiare.
A questo punto, coerentemente con le considerazioni appena svolte sulla nozione di cultura e sulla diversità culturale come fatto, è possibile avanzare una definizione di ciò che qui si intende per multiculturalismo nell’ambito teoria politica. Considero multiculturali quelle teorie che cercano di rispondere alla seguente domanda: in che modo le istituzioni politiche devono affrontare i problemi posti dal fatto della diversità culturale, vale a dire dalla presenza di diverse culture all’interno della stessa comunità politica?
Diversità culturale, sostengono i teorici del multiculturalismo, significa anche che in una comunità politica esistono maggioranze e minoranze culturali (immigrati, minoranze nazionali, popoli indigeni, ecc.). Al centro della riflessione del multiculturalismo si trova il fatto che le società, per effetto del processo di costruzione dello Stato-nazione, sono strutturate in un modo che le norme sociali, la lingua e gli usi riflettano le preferenze, i principi e le tradizioni della maggioranza. Anche ciò che è normale, nel senso di socialmente accettato, viene definito sulla base dei valori della maggioranza.
In una situazione del genere, le minoranze potrebbero incontrare difficoltà a vivere secondo ciò che esse ritengono giusto e doveroso. Si consideri, per esempio, l’obbligo di indossare il casco per i motociclisti. Quest’obbligo, nel nostro Paese, è generalmente accettato per i benefici che produce in termini di prevenzione del rischio di infortuni. La minoranza Sikh, che per motivi religiosi ha l’obbligo di indossare il turbante, potrebbe considerare l’obbligo di indossare il casco come un ostacolo al rispetto di un fondamentale obbligo di coscienza. In che modo bisogna affrontare i conflitti tra obblighi di legge e obblighi di fede (Lecaldano 2013)? È accettabile esentare i membri di una minoranza dal rispetto di una legge che contrasta con i loro principi religiosi (De Caro 2014)? Come rispondere alla disuguaglianza di condizioni tra maggioranze e minoranze culturali? Bisogna riconoscere diritti alle minoranze, oppure assumere un atteggiamento di laissez faire? Inoltre, fino a che punto si può concedere autonomia alle minoranze culturali? Sono queste, ed altre ancora, le domande tipicamente affrontate dal multiculturalismo, e ne renderemo conto nelle pagine di questo libro.
Per il momento mi soffermerò su due aspetti della definizione di multiculturalismo appena formulata. In primo luogo, la presente definizione si distingue in maniera piuttosto netta da alcune definizioni, che qui chiamerò ristrette, per le quali una qualche forma di approvazione della diversità culturale è un elemento essenziale di ogni multiculturalismo. In secondo luogo, vi sono delle affinità e delle diversità tra il multiculturalismo come viene qui trattato e il liberalismo. Nel resto di questa sezione renderò conto del primo aspetto, mentre il secondo sarà oggetto della sezione successiva.
Una definizione ristretta di multiculturalismo è stata recentemente proposta da George Crowder. In Theories of Multiculturalism Crowder sostiene che il punto di partenza del multiculturalismo è che molte società contemporanee sono multiculturali, nel senso che «contengono molteplici culture» (Crowder 2013, p.7). A questo fatto, il multiculturalismo risponde con un atteggiamento che va oltre la mera tolleranza. Infatti, la diversità culturale è approvata e riconosciuta dalle istituzioni pubbliche per mezzo dell’attuazione di misure politiche ad hoc. Una definizione del genere, sebbene inizialmente plausibile e molto diffusa, a mio avviso, restringe eccessivamente l’ambito del multiculturalismo. Sebbene Crowder lo neghi (Crowder 2013, p. 8), sembrano di fatto essere escluse tutte quelle teorie per le quali la diversità in sé non è un valore da promuovere o da celebrare. Inoltre, questa definizione assume senza fornire un adeguato argomento che qualche forma di riconoscimento della diversità culturale sia in ogni caso un tratto definitorio del multiculturalismo. Come si vedrà più in dettaglio nel capitolo 4, non sempre il riconoscimento pubblico è auspicabile, e non sempre la diversità culturale è preferibile all’omogeneità (Kukathas 1998, 2008).
1.3 Multiculturalismo e liberalismo
Concepire il multiculturalismo come una teoria riguardante la risposta delle istituzioni alla diversità culturale e sottolineare che l’obiettivo del multiculturalismo consiste nell’analisi delle condizioni in cui sia possibile realizzare la coesistenza pacifica tra gruppi culturali diversi e potenzialmente in conflitto, pone la questione del rapporto tra multiculturalismo e liberalismo (Weinstock 2015). Quest’ultimo è infatti una tradizione del pensiero politico che, fin dalle origini, ha posto al centro della sua riflessione teorica la diversità.
È qui sufficiente richiamare la diffusa ipotesi secondo la quale alle origini del liberalismo ci sarebbe la ricerca delle condizioni che rendono possibile la coesistenza pacifica tra persone con fedi religiose diverse all’indomani delle sanguinarie guerre di religione che sconvolsero l’Europa tra il XVI e il XVII secolo (Rawls 1994, p. 12; Laden e Owen 2007, p. 8). Dunque, secondo questa versione delle origini del liberalismo, il problema che i liberali si pongono all’inizio della loro storia è la diversità religiosa.
Per venire a tempi più recenti, John Rawls, che è il filosofo politico più influente del secolo scorso, ha sostenuto che la propria teoria liberale ritiene fondamentale la seguente domanda: «come è possibile che esista e duri nel tempo una società stabile e giusta di cittadini liberi e uguali profondamente divisi da dottrine religiose, filosofiche e morali incompatibili?» (Rawls 1994, p. 6). Quindi, la diversità (di dottrine religiose, filosofiche e morali) è un aspetto essenziale del progetto filosofico rawlsiano. Una prova ulteriore del fatto che la riflessione sulla diversità occupi un ruolo fondamentale nel liberalismo è data dalla francese Catherine Audard. Quest’ultima, in una recente e voluminosa monografia sul liberalismo, ha affermato che tutta la storia del liberalismo può essere letta come un tentativo di rispondere alla domanda «come vivere insieme?» (Audard 2009, p. 727) a dispetto del fatto che gli individui sono diversi per quanto riguarda credenze, valori, interessi, ecc.
Quindi, ci si potrebbe chiedere, quali sono le reali differenze tra liberalismo e multiculturalismo, in particolare a proposito del modo in cui queste teorie considerano la diversità? Un essenziale punto di differenza è che il multiculturalismo, come si è detto nella sezione precedente, mette al centro dei suoi interessi la diversità tra culture e gruppi culturali presenti all’interno della stessa comunità politica. Il liberalismo, invece, assume che le diverse credenze morali e filosofiche presenti in una società liberal-democratica siano aspetti di un’unica cultura (Kymlicka 1989, p. 177). Come ha scritto Bhikhu Parekh, il liberalismo «è sensibile alla pluralità di visioni morali, non alla pluralità di culture, e trascura le aspirazioni culturali di quelle comunità come i popoli indigeni, minoranze nazionali, gruppi subnazionali e immigrati». Tutti questi gruppi avanzano diverse rivendicazioni, ma in genere richied...