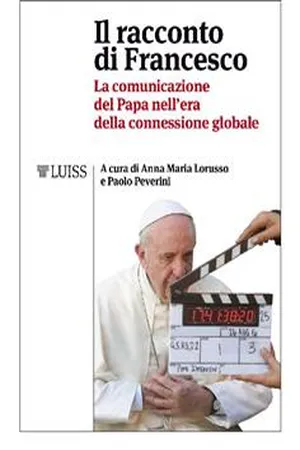![]()
Imprevedibile Franciscus
franciscu sedda
università di cagliari
...questo è il mio corpo
offerto in sacrificio per voi
1. introduzione
A distanza di due anni dall’ascesa di Jorge Mario Bergoglio al soglio pontificio la constatazione euforica della sua “autenticità, semplicità ed immediatezza” è già diventata luogo comune. Tuttavia, ammesso (ma non concesso) che questo stile efficace dipenda esclusivamente da una sua speciale dote, resterebbe comunque da spiegare perché proprio ora spontaneità, semplicità e immediatezza acquisiscano tutta questa forza sociale, comunicativa, semiotica. Ammesso (ma non concesso) che autenticità, spontaneità ed immediatezza siano valori, resterebbe dunque da capire perché e come ora – e proprio nel modo in cui li incarna Papa Francesco – ci appaiano come valori, comunicativamente efficaci se non dirompenti.
La domanda è necessaria perché altrimenti non si spiegherebbe il sentimento del nuovo, della differenza, della trasformazione ai limiti dell’imprevedibile che l’azione del Papa incarna. Se spontaneità, semplicità e immediatezza fossero valori di per sé non si capirebbe perché tutto questo stupore, questo entusiasmo, questa sensazione di qualcosa di imprevisto che irrompe sul proscenio del mondo. Soprattutto non si capirebbe l’efficacia di quest’azione, con le sue inusitate potenzialità di senso e con le sue nuove ed inevitabili contraddizioni.
Ricostruire la trama di relazioni di cui Papa Francesco è segno – nodo sensibile e semantico, prodotto e produttore di una differenza che produce altra differenza – è ciò che ci proponiamo di fare. Cercheremo dunque di rendere visibile quell’incrocio e quella somma di differenze che fa di Franciscus una grande differenza.
Per farlo ci sembra utile riandare ai primi istanti del pontificato, a quel Big Bang del senso rappresentato dall’uscita di Papa Francesco sul balcone di Piazza San Pietro. Lì ci pare di ritrovare condensate alcune delle traiettorie più feconde – in quanto imprevedibili, rilevanti, problematiche, contraddittorie – del suo agire, della sua ideologia, del suo comunicare. Traiettorie che proveremo a seguire attraverso gli atti semiotici più diversi – gesti, omelie, tweet, selfie, dialoghi, encicliche… – che hanno segnato in particolar modo il primo anno del pontificato. Traiettorie che oggi continuano a produrre effetti innovativi o già si sono fatte senso comune. Traiettorie che si possono secondo noi capire e sentire meglio approfondendo, appunto, il senso di quei primi istanti e di quel primigenio silenzio.
2. in principio fu il silenzio
(…) ci farà bene stare un po’ in silenzio,
per sentire la voce dell’Amore
@Pontifex_it, 23 dicembre 2013
Fratelli e sorelle…buonasera. (Papa Francesco, Roma, 13 marzo 2013)
Un gesto di saluto, un segno di contatto. Questo il principio. Fare cose ordinarie, e ordinariamente dimenticate, in momenti straordinari. Rendere l’ordinario straordinario, ridargli sensibilmente incanto.
Si deve iniziare da qui, dal principio, per cogliere la potenza semiotica di Papa Francesco. Quel semplice gesto porta infatti con sé un’intera poetica. E una complessa ideologia.
Esso infatti, mentre chiama in causa coloro che assistono al rito, dà senso, concretezza e credibilità a ciò che lo ha anticipato: Franciscus.
Un nome imprevisto, mai sentito prima da quel balcone. Un nome che, verrebbe da dire prosaicamente, “è tutto un programma”. Un programma narrativo, un concatenamento di azioni, passioni, valori, si direbbe semioticamente. Quel nome appena pronunciato, che già ha generato stupore, che già riattualizza una memoria semantica che evoca semplicità, povertà, amore, contatto crea una tale gerarchia di aspettative che il suo senso potrebbe facilmente e fragorosamente implodere. Il gesto di saluto del Papa appena presentatosi sul balcone di Piazza San Pietro, quel saluto pronunciato in modo lieve, esitante, assolutamente non solenne, conferma invece l’apertura di un campo di realtà semantica e sensibile fino a quel momento imprevisto.
Non solo dunque l’ordinario che si fa straordinario ma la promessa che immediatamente si realizza. Nel nome-storia che immediatamente si fa corpo-gesto c’è del re-ligioso: costruzione di un legame attraverso un nuovo complesso di relazioni. Fra segni: “Franciscus” “…buonasera”. Fra l’istanza enunciante e ciò che enuncia: mantenimento di sé attraverso una promessa immediatamente mantenuta. Fra il Papa e l’uditorio che vive queste nuove relazioni mentre si sente chiamato in causa: perché se questa prima concatenazione semiotica genera, in profondità, una coerenza semantica, in superficie essa si offre come una storia seguibile. Che può essere facilmente seguita. A cui si è chiamati a dar seguito. A parteciparvi.
Se il gesto di saluto da un lato appare infatti come la prima espansione e traduzione in pratica di quel nome che ha anticipato il corpo in presenza del Papa, dall’altro lato esso fa risaltare che quel primo imprevedibile gesto – Franciscus – non è né scelta indifferente né pura promessa rivolta al futuro. La relazione fra i due gesti si offre come carne viva, che il credente sempre più s-fiduciato può toccare per ritrovare il principio della sua fede. Nella relazione fra “Franciscus” e il “buonasera” c’è dunque un sapere che si fa carne, un corpo che si offre al contatto, un simulacro attraverso cui fondare un nuovo credere per un nuovo popolo.
In secondo luogo quel saluto fa differenza – e che differenza - rispetto ad un campo di gesti che popolano la memoria vissuta degli astanti. In particolare di quel simulacro del pubblico che sono i “romani” dato che, come meglio vedremo, è ad essi che il Papa si rivolge mentre li convoca nel suo discorso. Lo spazio culturale che i “romani” sono tenuti ad abitare, infatti, è saturato e dominato da ben altri gesti verbali rispetto al saluto del Papa: “Vaffa!”, “Fuori!”, “Rottamazione!” e più tardi “Ruspa!”. Il “buonasera” senza punto esclamativo del Papa irrompe dentro questo campo occupando una posizione vuota, o forse creandola ex novo. All’escalation di negazione dell’altro – sebbene un altro sempre diverso, va da sé - che Grillo, Renzi e Salvini hanno utilizzato per definire se stessi, il Papa contrappone l’incontro con l’altro; alla volgarità si oppone la gentilezza; alla brutalità dei modi le buone maniere.
Da un lato dunque l’urlo sempre più forte per superare e soverchiare l’urlo altrui. Dall’altro una parola quasi sussurrata per far spazio ad un linguaggio inaudito. Nel primo caso l’esistente portato a turbolento parossismo. Nel secondo un imprevedibile e rischioso atto di rottura con l’esistente.
Nello spazio aperto da questa relazione ciò che si fa doppiamente sensibile è il silenzio. Quando il Papa pronuncia il suo timido “Fratelli e sorelle…buonasera” ciò che fa senso non è semplicemente il riconoscimento molare di un tanto ordinario quanto inatteso gesto di cortesia; e nemmeno lo schema semantico di una chiamata in causa dell’interlocutore a rischio di disillusione e di distacco. Ciò che fa (ulteriormente) senso è la percezione di un ritmo paradossale: quel parlare si staglia a malapena sul silenzio che è intercorso fra la sua uscita sul balcone di Piazza San Pietro e le sue prime parole, il tanto che basta per rendere evidente che si è nel silenzio. Rispetto poi al rumore del mondo circostante – quello euforico della piazza, quello aggressivo della comunicazione politica italiana, quello fragoroso del terrorismo internazionale e delle violenze mondane – questo silenzio risulta ancor più presente e comunicativamente denso, rivelando tutta la sua carica etica. “Come tornare al silenzio”, si chiedeva Umberto Eco pochi anni prima. Il Papa non solo ritorna al silenzio ma fa tornare il silenzio sulla scena comunicativa, offrendo un’alternativa al rumore. Ancor meglio, offrendo il silenzio come alternativa etica all’idea di rispondere al rumore con un rumore più forte.
C’è un che di poetico-estetico in questa irruzione semiotica che va a creare una posizione strutturale attesa e tuttavia imprevista. Come il Robinson di Tournier – eletto a modello della presa estetica da Algirdas Greimas (1987) – è infatti proprio il ritardo della parola, quel ritardo che la fa ancor più apparire gentile, che retroattivamente fa percepire il silenzio che la fonda, origina e attraversa. Per questo quella parola è gesto. Perché non è e non vuole essere parola, e men che meno flatus vocis, ma pura e semplice azione. Se poi ci figuriamo questo movimento retroflesso, questo movimento che costituisce l’inizio a partire dalla fine, il prima dal dopo, facendo di due cose diverse una cosa sola, una cosa condivisa, ci rendiamo conto che esso riproduce a livello plastico un movimento di abbraccio, o ancor meglio di recupero del coinvolgimento. Dalla superficie (discorsiva) al fondo (strutturale), quel “buonasera” che si staglia sul rumore del mondo fa sentire il silenzio, facendone il luogo e la...